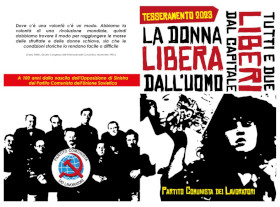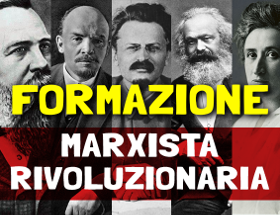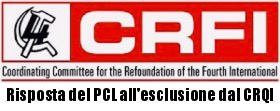Prima pagina
Cosa accade fra imperialismo USA e imperialismo russo?
Le aperture di Trump alla prova della chiusura di Putin. Le incognite delle relazioni mondiali
24 Luglio 2025
Lenin inquadra l'imperialismo come fenomeno dinamico, esposto permanentemente per sua natura a relazioni variabili, in particolare tra le grandi potenze. Tanto più oggi, il cambio di direzione della principale potenza del pianeta rende attuale il metodo d'analisi leninista. La mobilità delle relazioni mondiali ha assunto infatti una forte accelerazione, con ripetuti cambi di scenario e diverse incognite. La figura di Trump, e la sua ormai proverbiale imprevedibilità, è un epifenomeno di tale processo, con il ruolo indubbio di protagonista. Ma non l'unico protagonista. L'imperialismo russo e l'imperialismo cinese sono soggetti non meno attivi nello scenario mondiale, e non meno incidenti sulle sue dinamiche. Anche sulle scelte dell'amministrazione americana.
LE APERTURE DI TRUMP ALL'IMPERIALISMO RUSSO
Nei mesi successivi al proprio insediamento, l'apertura della nuova amministrazione americana al regime di Putin e alla sua guerra d'invasione dell'Ucraina non è un elemento di analisi ma un fatto. Solo la cecità ideologica della cantilena campista (“la guerra per procura”) si è rivelata incapace di coglierlo.
Il voto comune di USA, Russia, Israele in sede ONU il 24 febbraio 2025 (terzo anniversario dell'invasione) contro la condanna dell'invasione; l'umiliazione di Zelensky a rete unificate come “responsabile” della guerra, con la sostanziale richiesta della sua resa (“non hai le carte”); la sospensione della copertura militare satellitare delle forze ucraine durante l'operazione nel Kursk quale strumento estremo di pressione su Kiev; l'imposizione all'Ucraina, sotto la pressione del ricatto, di un accordo di rapina basato sul saccheggio delle sue risorse minerarie; l'avanzamento di una proposta di soluzione di “pace” americana fondata sul riconoscimento alla Russia dei territori ucraini militarmente conquistati, con tanto di piantina di Kellogg sulla possibile linea di spartizione del paese (territori annessi alla Russia ad Est, una Ucraina centrale comprensiva di Kiev demilitarizzata, l'Ovest del paese con a capo Leopoli eventualmente protetto dagli imperialismi europei); il rifiuto di nuove sanzioni americane contro la Russia, aggiuntive a quelle varate da Biden; la pubblica legittimazione di Vladimir Putin quale interlocutore privilegiato degli USA e del Presidente Trump in particolare (“Abbiamo un buon rapporto”, “È un uomo che difende il suo paese”...); la riduzione annunciata di nuovi sostegni militari all'Ucraina una volta esauriti quelli stanziati da Biden; la denuncia più generale della difesa dell'Ucraina come “la guerra di Biden” da archiviare definitivamente (“con me la guerra non vi sarebbe stata”); l'emarginazione ostentata degli imperialismi europei dal negoziato russo-americano, e più in generale da ogni scacchiere negoziale, come nel caso del Medio Oriente, e ancor più l'assunzione di una propaganda USA anti-UE ricalcata su toni e argomenti di Mosca (sino al sostegno all'estrema destra tedesca in piena campagna elettorale, e dell'estrema destra rumena), combinata con la guerra commerciale (anche) contro la UE.
Tutti questi fatti, tra loro intrecciati e in rapida successione, hanno misurato la profonda discontinuità della politica USA verso la Russia. Una svolta apparentemente mirata a impostare una relazione diretta fra grandi potenze fuori dal solco della tradizionale alleanza transatlantica, in funzione di una rinegoziazione generale degli equilibri mondiali. Il coinvolgimento indiretto della Russia nella crisi iraniana e mediorientale, quale calmiere di Teheran, è stato parte di questo nuovo corso negoziale americano.
Come PCL e come Lega Internazionale Socialista abbiamo ripetutamente affrontato l'analisi di questa svolta, indagandone premesse, caratteri, difficoltà, e ponendoci anche gli interrogativi, tuttora aperti, che essa ha obiettivamente posto: Trump ha cercato di separare la Russia dalla Cina, in funzione della centralità della propria competizione strategica con Pechino? Mira semplicemente a uscire dal conflitto ucraino per destinare le risorse anche così risparmiate a riduzioni di spesa sociale e tagli fiscali per i capitalisti USA? Punta a un accordo con Mosca nella gestione dell'Artico, delle sue enormi ricchezze, del suo ruolo strategico, e anche a un nuovo volume di affari e investimenti USA in Russia in cambio di materie prime preziose? Oppure una combinazione diversamente graduata di tutti questi fattori? Questi e altri nodi interpretativi troveranno una risposta compiuta dalla sviluppo degli avvenimenti, dentro uno scenario mondiale in ogni caso profondamente scosso dalla svolta trumpiana.
IL DISEGNO DEL REGIME PUTINIANO E LO SPIAZZAMENTO DI TRUMP
Tuttavia c'è un problema. Vladimir Putin ha corrisposto solo in minima parte alla grande apertura di credito di Donald Trump.
Intendiamoci. Da un punto di vista formale, politico e diplomatico, Putin ha fatto comprensibilmente ponti d'oro a un'apertura trumpiana probabilmente più ampia di quella prevista. Ha incassato il riconoscimento di grande attore globale, la legittimazione della propria guerra d'invasione, l'uscita di fatto dallo status di criminale di guerra sancito dalla Corte Penale Internazionale. Ha pubblicamente salutato il nuovo Presidente americano come “uomo di pace”, ha enfatizzato la sua svolta rispetto all'amministrazione precedente, ha inzuppato il pane della propaganda nella contraddizione tra imperialismo USA (“volto alla pace”) e imperialismi europei (“guerrafondai”).
Il suo stesso prestigio di comandante in capo delle operazioni di guerra ne è uscito rafforzato agli occhi di larga parte della sua base sociale nella stessa Russia. E con esso, la forza della sua pressione militare, direttamente proporzionale all'indebolimento ucraino.
Ma tutto questo non era e non è abbastanza per Putin. Il Presidente della Federazione Russa non si accontenta della nuova offerta dell'imperialismo USA. Punta alla vittoria piena della “operazione militare speciale” e ai suoi obiettivi di fondo. Almeno gli obiettivi di guerra, ridefiniti come subordinata dopo il fallimento iniziale della conquista di Kiev: la conquista piena e non solo parziale delle quattro regioni annesse; il drastico ridimensionamento della forza militare dello Stato ucraino (“smilitarizzazione”); la defenestrazione politica di Zelensky (la cosiddetta “denazificazione”). Nei fatti, attraverso il recupero dell'Ucraina, il rilancio di un'area imperiale russa in Europa, sulle orme della vecchia tradizione zarista. Quella tradizione che del resto lo sciovinismo grande-russo saluta e rivendica apertamente (Dugin), con la benedizione della Chiesa ortodossa del Patriarca Kyrill (ex KGB) e la sua campagna contro “il satanismo” occidentale.
L'obbiettivo di Putin è tutt'altro che agevole, e tanto meno scontato. La progressione militare russa sul campo di battaglia – oggi indubbia – procede lentamente. In tre anni di guerra, nonostante la grande sproporzione delle forze, l'area dell'Ucraina militarmente conquistata e complessivamente intesa non supera il 20% del Paese. Chi da tre anni celebra ogni giorno la disfatta dell'Ucraina e la vittoria della Russia (Marco Travaglio in primis, e a rimorchio il grosso della carovana campista) ha un problema di rapporto sia con la realtà che con la logica. Anche le difficoltà della Russia legate all'economia di guerra – inflazione, alti tassi di interesse, penuria di manodopera, rischio di cadute recessive – sembrano complessivamente accresciute, e con esse le incognite sul futuro.
E tuttavia Putin sembra investire nel proprio azzardo. Si avvale sul fronte di guerra di un relativo indebolimento della difesa ucraina; mobilita sul fronte interno il consenso nazionalista – oggi soprattutto in chiave antitedesca – attorno alla memoria della “grande guerra patriottica”, non senza incorporare apertamente la figura di Stalin allo sciovinismo nazionale grande-russo con tanto di restauro di statue e memoriali; stringe i bulloni della repressione interna (assai più dura oggi che nella prima fase della guerra); dirotta il malcontento sociale sul terreno della xenofobia coprendo una politica di pogrom contro gli immigrati col supporto dell'organizzazione fascista Comunità Russa; recluta soldati dalle galere e dalle regioni limitrofe della federazione – per risparmiare il più possibile la Russia bianca, che è il cuore della sua base di consenso – pagandoli fior di quattrini; ricorre al supporto massiccio di truppe e armi nordcoreane (decisive nella riconquista del Kursk). Soprattutto, si appoggia sulla grande potenza materiale dell'alleato cinese (acquisto di petrolio, fornitura di tecnologia) e su un sistema di relazioni internazionali (vedi Emirati Arabi Uniti) che gli consente di aggirare le sanzioni imperialiste occidentali.
Sono questi i punti di forza del regime, nonostante il rovescio subito in Siria con la caduta di Assad, e l'indebolimento dell'alleato iraniano, che Mosca peraltro si è ben guardato dall'aiutare, per non compromettere le proprie relazioni con Israele.
In questo quadro generale, lo stesso cambio di direzione dell'amministrazione USA, e le nuove contraddizioni fra USA e UE, sono state viste da Putin non come l'occasione per concludere la guerra con una soluzione di “pace” sostanzialmente vittoriosa per l'imperialismo russo – quale quella offerta da Trump – ma come occasione di rilancio della propria offensiva militare per conquistare l'intero bottino agognato. Un tentativo spregiudicato di sfruttare a proprio vantaggio la divisione interna al campo imperialista della NATO.
I due round negoziali tra Mosca e Kiev, al netto dello scambio di prigionieri, sono serviti a Putin per guadagnare tempo per l'azione di guerra, dietro la cortina fumogena di una disponibilità diplomatica di facciata.
Da qui lo spiazzamento di Trump, la sua “delusione” per Putin, il suo sospetto di una “presa in giro” da parte del capo del Cremlino. Da qui il riposizionamento tattico del Presidente americano: ripresa di contatto con gli imperialismi europei, riattivazione di un qualche sostegno militare all'Ucraina, e ultimatum a Putin di cinquanta giorni per fare la pace, pena nuove e più pesanti sanzioni.
LE INCOGNITE DEL NUOVO SCENARIO
Registriamo dunque un ritorno degli USA alle vecchie alleanze, nel nome di un ritrovato atlantismo? No, oggi non siamo a questo.
Il riposizionamento di Trump, pur importante, resta nei margini di una manovra tattica. “Non ho chiuso con Putin” dichiara Trump, ed è vero. La fornitura americana delle armi all'Ucraina riprende al momento col contagocce, ha modalità e tempi lenti, ed è a carico degli imperialismi europei (oltre che a beneficio, in misura preponderante, dell'industria bellica americana).
“Cinquanta giorni di tempo” corrispondono al programma di completamento della conquista militare integrale delle regioni annesse, comunicato da Putin a Trump il 4 luglio: non esattamente un ultimatum.
Lo stesso metro di verifica dell'esito dei cinquanta giorni è al momento molto indeterminato (accordo di pace, avvio di negoziato?). Così come resta indeterminato il quadro delle eventuali sanzioni minacciate: l'interscambio commerciale USA-Russia è di cinque miliardi, obiettivamente irrisorio; le sanzioni indirette (“al 100%”) ai paesi materialmente sostenitori della Russia, come la Cina e l'India, avrebbero invece enormi ricadute sull'economia mondiale, colpirebbero le relazioni strategicamente preziose fra USA ed India, e dunque sono ritenute di dubbia credibilità.
Il riposizionamento americano si configura pertanto attualmente come una pressione sulla Russia, più che come azione di rottura. La Borsa di Mosca ha commentato le “minacce” USA con una crescita dei propri valori azionari, quasi a festeggiare uno scampato pericolo. E Trump, a scanso di equivoci, si è affrettato a rassicurare: “Non sto né con la Russia né con l'Ucraina, sto dalla parte dell'umanità” (!).
È vero tuttavia che Trump si attende da Putin un risultato. Ne va del prestigio dell'imperialismo USA su scala globale, e dell'immagine di Trump sul versante interno americano. Altrimenti? Al giornalista del Financial Times che ha chiesto al Presidente: “Se dopo cinquanta giorni la situazione è immutata, quali saranno le sue reazioni?”, Trump ha risposto: “Per cortesia, non mi faccia questa domanda”. La verità è che la nuova amministrazione dell'imperialismo USA naviga a vista, con una buona dose di empirismo.
LA GRANDE INSTABILITÀ MONDIALE
Restano i fondamentali:
1) L'imperialismo USA in declino non è più in grado di caricare sulle proprie spalle gli oneri esorbitanti della sua vecchia area di influenza. Se vuole concentrarsi sul confronto strategico con la Cina nei mari del Pacifico, ha esigenza di ridurre la propria esposizione su altri scacchieri: in Medio Oriente, dove Trump lavora a rilanciare e allargare gli Accordi di Abramo all'Arabia Saudita, e persino alla nuova Siria, a garanzia dello Stato sionista (ma non senza contraddizioni con la politica autocentrata di Netanyahu, a sua volta in conflitto col disegno neo-ottomano di Erdogan); ed anche in Europa, dove cerca di venir fuori dalla guerra in Ucraina e di ridimensionare l'attuale presenza continentale di truppe USA: una presenza che oggi conta 67000 uomini, e che Trump vorrebbe poter dimezzare per spostarne 30000 nell'Indo-Pacifico.
Un accordo con Putin sarebbe funzionale su entrambi i versanti. Ma non può essere gratis, come Putin vorrebbe.
2) Il grande riarmo degli imperialismi europei è anche e soprattutto una risposta alla minaccia del disimpegno USA. La NATO resta in piedi, ed anzi rimane formalmente il quadro del riarmo europeo. Ma al suo interno le relazioni sono in via di ristrutturazione profonda. Trump ha aperto addirittura a una libera interpretazione dell'articolo 5, un messaggio storico per Putin, che però esige riscontro. Mentre Francia e Germania, in concorrenza tra loro, stipulano accordi bilaterali di mutua assistenza militare con la Gran Bretagna, rientrata a pieno titolo nella partita europea, e la Danimarca raddoppia le proprie spese militari anche a tutela... della Groenlandia.
Le relazioni mondiali sono in pieno movimento in ogni quadrate del pianeta, con incognite multiple. Ovunque la forza delle armi fonda il potere negoziale degli imperialismi, vecchi e nuovi. Ovunque il proletariato e i popoli oppressi sono merce di scambio o carne da cannone. Solo una rivoluzione socialista può rifondare il mondo su nuove basi.