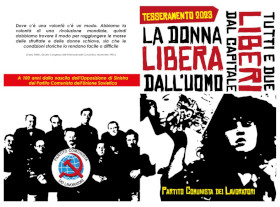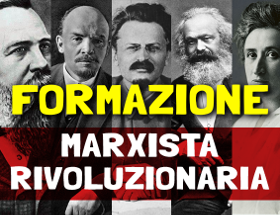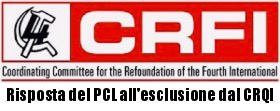Dalle sezioni del PCL
9 marzo 1985 a Trieste. Esecuzione di stato del compagno Pedro
10 Marzo 2025
Noi non dimentichiamo i frutti repressivi della “solidarietà nazionale” e delle sue leggi speciali.
È l'11 marzo 1980 quando viene spiccato un primo mandato di cattura che costringe alla latitanza il compagno Pietro Maria Walter Greco (Pedro), protagonista delle lotte proletarie e comuniste degli anni ’70 a Padova, e dell’Autonomia Operaia in particolare, nonché insegnante di matematica. Ipotesi di associazione sovversiva, banda armata e detenzione di armi. Pedro viene assolto in prima istruttoria per mancanza di prove, ma agli inizi del 1982 arriva un secondo mandato di arresto, interno a quello che fu definito il “blitz di quaresima”, ed inizia una nuova latitanza. Il mandato è ancora firmato da Pietro Calogero, magistrato in prima fila tra la fine degli anni '70 e inizio '80 contro i movimenti della sinistra extraparlamentare. È il processo del “7 aprile” 1979 contro l’Autonomia Operaia veneta.
Il processo è un’operazione repressiva su larga scala che ben interpreta il clima di legislazione speciale implementata in quegli anni di “solidarietà nazionale” generata dal compromesso del PCI di Berlinguer con il regime DC-NATO (”l'ombrello protettivo”).
Per la prima volta dalla fine del secondo conflitto mondiale è tornata la recessione economica generalizzata nel mondo capitalista avanzato. Pur se questa crisi economica ha posto il movimento operaio sulla difensiva e lo ha reso oggetto di un’imminente ristrutturazione feroce nelle relazioni di classe, la contestazione anticapitalista è ancora capace di politicizzazione di massa, specie tra i giovani. L’assenza di un partito rivoluzionario, e la contemporanea collocazione filogovernista del PCI (con relativa adesione della CGIL alla “politica di austerità”), rafforzano lo spazio di intervento per teorizzazioni e pratiche che esaltano lo spontaneismo e afflati lottarmatisti. In questo quadro si inserisce l’azione repressiva governativa, che reintroduce ordinamenti processuali penali del tribunale speciale fascista. L’obiettivo è colpire le avanguardie operaie e studentesche.
Di lì a poco si scatenerà l’attacco alla classe operaia della FIAT approfittando dell’indebolimento della “sinistra di fabbrica”, anche a causa della posizione del PCI e della crisi dei principali partiti e gruppi dell’estrema sinistra, i quali pagano la mancanza di un’adeguata tattica verso gli apparati riformisti (al fine di contestarne l’egemonia sulla loro base di massa) e l’assenza di un programma di rivendicazioni transitorie verso la prospettiva rivoluzionaria di un governo dei lavoratori in luogo di impostazioni massimalistiche o eclettiche.
A metà degli anni ’80 la borghesia è riuscita a normalizzare il conflitto e ad infliggere colpi decisivi al movimento operaio, alla tenuta della sua composizione sociale. Il PCI è di nuovo all’opposizione ma ormai è in fase discendente, e questo rende la sua tradizionale politica riformista ancora più interna alla governabilità capitalistica. Un’alternativa coerentemente marxista e rivoluzionaria alla sua sinistra stenta a svilupparsi: Democrazia Proletaria fa progressi organizzativi ma resta avvolta nell’ambiguità eclettica (non priva di tratti opportunistici) mentre le forze che fanno riferimento alla Quarta Internazionale sono troppo deboli.
La lunga fase di grandi lotte e di contestazione antisistemica iniziata con il ’68 studentesco e il ’69 operaio è finita; i nuovi movimenti come quello ecologista e contro il nucleare, seppur capaci di catturare settori giovanili, si pongono tendenzialmente su di un terreno esterno alla lotta di classe: un parametro della crisi di egemonia del movimento operaio.
Ma la macchina repressiva della legislazione speciale continua. La borghesia non vuole colpi di coda, e meno che mai l’innesco di nuove dinamiche di lotta di massa.
Nei primi giorni di marzo 1985 la Digos di Trieste riceve una segnalazione dal SISDE (il servizio segreto degli Interni) in merito alla presenza di Pietro Greco a Trieste. In quel tempo il questore di Trieste è Antonino Allegra. Sì, proprio colui che era a capo della squadra politica di Milano quando il compagno Giuseppe Pinelli “volò” fuori dalla finestra.
Sabato 9 marzo alle ore 11:00 Pedro esce dall'appartamento al terzo piano; giunto al pianoterra decide di rientrare. È già approntato un gruppo di fuoco delle forze dello stato borghese. Pedro viene ucciso da un commando formato dall’agente del SISDE Maurizio Nunzio Romano e da tre operatori della Digos di Trieste, il viceispettore Giuseppe Guidi e gli agenti Maurizio Bensa e Mario Passanisi, che gli sparano più di dodici colpi d'arma da fuoco, prima nell'atrio del palazzo e poi fuori, alle spalle, quando già stava agonizzando sul marciapiede. Greco sarà colpito da cinque o sei proiettili. Dopo essere stato ammanettato, viene fatto trasportare in ospedale con molto ritardo. Muore verso le 11:50.
L'agente Romano, del SISDE, non avrebbe dovuto prendere parte ad operazioni di polizia, eppure è proprio lui (perché in grado di riconoscerlo) a decidere di entrare nello stabile e a sparare per primo.
La stampa borghese farà da megafono alla dichiarazione della Questura della morte a seguito di un conflitto a fuoco. Un “pericoloso latitante”, un “capo guerriglia”, queste sono le descrizioni che i quotidiani danno di Pedro. I TG Rai parlano di “terrorista in fuga”, mentre il giornalista triestino della TV di Stato, Tullio Mayer (già PSI, poi Lista per Trieste), descrive l’appartamento di via Giulia come “covo di latitanti”.
Alla notizia della morte del compagno Greco in migliaia scendono nelle piazze, da Trieste a Padova, dalla Calabria a Parigi, per denunciare l’assassinio di stato. L’autopsia avverrà senza periti di parte. Gli esiti saranno tenuti secretati, ma emergerà il tentativo di tesi che la morte sia stata provocata dal ritardo dei soccorsi.
Al processo, sarà la teoria della presenza di un ombrello – che nessun testimone ha visto in mano a Pedro – scambiato dagli agenti per un mitra, a far da scusante alla loro scarica di fuoco per legittima difesa. Un ombrello che nel corso della ricostruzione processuale dei fatti scomparirà per poi riapparire nuovamente con colore e forma diversi! Fisicamente quell’ombrello non è mai apparso in aula. Ma ciò sarà sufficiente a giustificare l’assassinio politico di un proletario disarmato.
Guidi e Passanisi vengono assolti, Romano e Bensa condannati a 8 mesi, che non sconteranno mai. Nell’aprile 1986 i due coimputati nel processo di Pedro, che avevano le sue stesse imputazioni, saranno assolti, mentre il TAR del Veneto beffardamente decreterà il suo reintegro all’insegnamento e il riconoscimento degli emolumenti che Pedro aveva rivendicato dopo la prima latitanza.