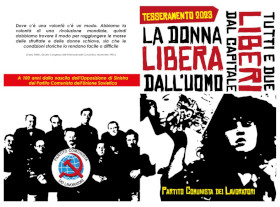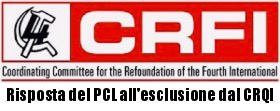Interventi
Classe, partito e consigli (prima parte)
Una riflessione su processo rivoluzionario e prospettiva comunista
2 Settembre 2021
Pubblichiamo in tre parti (la seconda la trovate qui, la terza qui) un corposo testo del compagno Luca Scacchi, di cui trovate in fondo la versione in pdf per l'eventuale stampa. Buona lettura!
Nelle discussioni degli ultimi due anni ci è capitato più volte, come tendenza Anticapitalismo e Rivoluzione del PCL, di sottolineare il rapporto contradditorio e dialettico tra classe e partito. L’esperienza del novecento ha infatti reso evidente l’importanza del partito, cioè di un’avanguardia organizzata in grado di darsi il progetto politico di costruire un nuovo modo di produzione, attraverso la presa del potere e l’uso dello Stato per modificare i rapporti sociali. Questo è in particolare il contributo teorico di Lenin e quello pratico del bolscevismo. Quest’esperienza storica, però, ha reso nel contempo evidente il ruolo fondamentale dell’antagonismo tra capitale e lavoro, che sorge e si organizza nei processi di produzione sviluppando una propensione anticapitalista nella classe lavoratrice. È infatti questa disposizione e questa radicalità di massa che apre la prospettiva di abbattere l’attuale ordine costituito: senza di essa la volontà politica di trasformare l’esistente rischia infatti di rimanere una semplice intenzione soggettiva, uno spirito che si fa interprete della storia sospinto da illusioni necessarie e tendenze avanguardiste. In ogni caso, proprio l’esperienza bolscevica ha mostrato come dopo la presa del potere una scorretta relazione tra classe e partito possa accompagnare possibili degenerazioni bonapartiste, come si è visto con la deriva termidoriana, l’instaurazione del regime staliniano, il consolidamento di uno stato operaio degenerato e dopo la seconda guerra mondiale la sua capacità di regolazione di tutte le esperienze rivoluzionarie. Questa relazione contradditoria e dialettica è quindi fondamentale per ogni processo rivoluzionario, prima e dopo la presa del potere. Tanto più lo è oggi, in una delle Grandi Crisi che segnano la storia del capitalismo, di fronte all’attuale scomposizione e debolezza dell’avanguardia, con rivolte e rivoluzioni che non innescano processi transitori.
LA CLASSE E LA SUA ARTICOLAZIONE
La lotta contro questo modo produzione si innesca infatti nella produzione. Nella società contemporanea si è oramai strutturato un mercato mondiale capitalista: questo rapporto sociale è quindi dominante sulle diverse formazioni sociali, sussunte (per larga parte realmente) nel suo sviluppo ineguale e combinato. Certo, una parte della popolazione è ancora impiegata in autoproduzioni o mercati locali (agricoli e artigiani), relativamente sganciati dai rapporti generali di produzione: una realtà significativa soprattutto nelle periferie (in formazioni sociali economicamente arretrate e spesso dipendenti), ma che talvolta si riproduce in nicchie e interstizi anche nelle metropoli capitaliste. In alcune formazioni, inoltre, possono ancora sopravvivere rapporti che hanno ancora forme apparentemente precapitaliste, parafeduali o semischiavistiche. In ogni caso, tutte queste diverse strutture sociali sono in-formate dalla produzione di merci e dagli scambi a livello mondiale, penetrati anche in queste realtà con prodotti necessari per la loro sopravvivenza o che comunque migliorano sostanzialmente la qualità della vita delle persone (dall’energia alle medicine, dai trasporti alle comunicazioni). Il nucleo centrale dei lavoratori e lavoratrici, nelle metropoli e nelle semiperiferie, è quindi integrato in processi di valorizzazione del capitale. Le merci realizzate dalla loro attività sono vendute per accumulare un profitto, cioè un di più rispetto a quanto si è investito per crearle. Attraverso lo sfruttamento della loro forza lavoro viene quindi accumulato nuovo capitale, in un sistema il cui equilibrio necessita di una perenne espansione, indipendentemente dalla materialità delle merci che si contribuisce a produrre [cioè, indipendentemente dal fatto che esse siano automobili, software, connessioni internet, lezioni universitarie o prestazioni sanitarie in strutture per l’appunto profit]. Il lavoro subisce quindi anche il movimento del capitale [boom, recessioni, onde lunghe espansive e depressive, Grandi Crisi], scontrandosi con le instabili tendenze e controtendenze di questo modo di produzione. Di conseguenza, in questo rapporto sociale i lavoratori e le lavoratrici ogni giorno sperimentano che le loro condizioni di vita dipendono da un conflitto diretto e continuo con il proprio padrone e, più in generale, con le regolazioni sociali che sostengono il loro sfruttamento [lo Stato, con le sue norme e i relativi apparati ideologici e repressivi]. Nella lotta quotidiana nella produzione (salari, orari, ritmi) e contro queste regolazioni (i governi e le loro politiche), lavoratori e lavoratrici sviluppano cioè la loro coscienza e la loro organizzazione o, al contrario, sperimentano stagioni di sconfitte, disorganizzazioni e involuzione politica. Da una parte, cioè, la consapevolezza del proprio antagonismo con le classi dominanti prende forma o si stempera attraverso il quotidiano scontro di classe. Dall’altra parte è proprio in questo conflitto che gli interessi del lavoro si organizzano, dando vita a comitati di lotta, consigli e coordinamenti dei delegati/e, sindacati e partiti. L’emersione di un’opposizione di massa contro l’attuale ordine sociale trova quindi una sua radice nel lavoro, strutturalmente contrapposto al capitale. Nella classe, cioè, risiede sia uno spirito che una prassi rivoluzionaria, indipendentemente dalla presenza e dal radicamento di un partito, come si è mostrato tante volte nella storia [basti pensare alla Russia nel 1905 o nel febbraio 1917, alla Germania nel 1918, alle tante insurrezioni improvvise ed impreviste da allora].
La classe però non è omogenea, è composta da diversi strati e diverse frazioni. Coscienza e organizzazione di classe si sviluppano diversamente a seconda dei settori (composizione tecnica del lavoro, professionalità, mansioni, titoli di studio), anche in relazione a divisioni sociali agite dal capitale (per esempio sulla base di genere, età, appartenenza etnica, condizioni contrattuali, cittadinanza e permessi di lavoro). Ad esempio, alcuni lavoratori e lavoratrici sono inseriti in processi produttivi in cui lo stesso capitale struttura una dimensione collettiva, come nelle fabbriche o nelle grandi aziende; altri sono invece dispersi in piccole realtà, dove subiscono una relazione diretta se non individuale con il proprio datore di lavoro (come nei laboratori artigiani o nelle piccole aziende); altri ancora sono isolati, talvolta gestendo autonomamente i propri strumenti di lavoro (l’antico Verlagssystem oggi riprodotto in alcune forme di contoterzismo, nei lavori su commissione, tra i raiders). Le diverse modalità produttive, inoltre, possono dare forma a diverse composizioni nel quadro delle stesse aziende (per esempio la catena di montaggio, che isola e nel contempo connette lavoratori e lavoratrici, o le isole produttive, che li struttura in squadre e li/le gerarchizza). Alcuni lavoratori e lavoratrici sono poi inseriti in processi produttivi segnati da particolari composizioni di genere (pensiamo al tessile da una parte, alla metallurgia dall’altra) o etnico-nazionali (pensiamo ai tanti migranti oggi nei macelli, nella logistica, in edilizia o tra le cosiddette badanti, ma anche negli anni sessanta/settanta ai meridionali nelle fabbriche torinesi, ai muratori bergamaschi, ai braccianti del basso veneto). Inoltre, ci sono lavoratori e lavoratrici che non sono inseriti in processi di valorizzazione del capitale, ad esempio i dipendenti pubblici: certo, subiscono gestioni aziendalistiche e sono subordinati alle più generali relazioni di classe del paese (in primo luogo su salari e orari), ma i loro processi di lavoro non sono determinati da un antagonismo diretto col capitale, bensì sono mediati dal quadro politico e dal suo sistema di regolazione (spesa pubblica e welfare). Non tutto il proletariato, infine, è classe lavoratrice (occupata e disoccupata): ci sono infatti settori inoccupati (ad esempio, nell’organizzazione familiare fordista centrata sul maschio lavoratore, le donne sono socialmente inquadrate nel ruolo di mogli e madri) e emarginati, che vivono di lavori informali, occasionali e illegali, se non di espedienti [il cosiddetto Lumpenproletariat]; senza dimenticare che nella società contemporanea ci sono condizioni transitorie, la cui radice di classe è ancora in formazione [gli studenti, adulti ma socialmente subordinati] o non è più operante [pensionati che ricevono un salario differito o sociale].
La società capitalista, infine, non è segnata da una semplice dialettica tra due classi sociali, ma fra tre soggetti: ogni seria analisi della situazione politica deve [infatti] prendere come punto di partenza le mutue relazioni tra la borghesia, la piccolo borghesia ed il proletariato [Trotsky, La sola via, 1932]. Nel mondo attuale ci sono cioè molteplici ceti intermedi e mezze classi, che si riproducono negli interstizi della produzione capitalista: condizioni di rendita (proprietari di terre, appartamenti, piccole concessioni), piccoli produttori diretti (artigiani, contadini, imprenditori indipendenti o inseriti in catene di subfornitura), commercianti autonomi (negozianti e venditori), persone che vendono le loro particolari competenze (professionisti vecchi e nuovi: notai, avvocati, informatici, veterinari, attori, farmacisti, ecc). In questo quadro possiamo anche far rientrare i manager e i dirigenti di impresa (spesso remunerati con percentuali dei profitti, ma non sempre), gli alti dirigenti dello Stato (prefetti, magistrati, funzionari e manager pubblici) e alcuni tecnici molto specializzati (che di fatto hanno un monopolio para professionale nelle proprie attività). Invece larga parte degli impiegati e dei tecnici, pubblici e privati, sono semplicemente forza lavoro più o meno qualificata (sebbene talvolta, nella propria autocoscienza, si rappresentino come classe media, aspirando a condizioni manageriali e professionali che percepiscono vicine). I ceti intermedi sono quindi compositi e multitudinari, avendo nature e configurazioni diverse: per larga parte, in ogni caso, non sono residui di altri epoche e in molte formazioni sociali non sono neppure residuali, ma anzi possono comprendere una parte significativa della popolazione. Diversamente da contadini e artigiani che hanno a lungo segnato le società capitaliste, inoltre, questi ceti intermedi contemporanei hanno una ridotta autonomia, essendo strettamente connessi ai processi produttivi: gettando in rovina certi strati piccolo-borghesi, il capitalismo ne creava altri; artigiani e piccoli bottegai attorno alle fabbriche, tecnici e impiegati all’interno delle fabbriche…più della metà del popolo tedesco [Trotsky, Cos’è il nazionalsocialismo? 1932]. Proprio per questo sono particolarmente instabili, in quanto ne subiscono direttamente il movimento e le conseguenti ristrutturazioni. Queste riorganizzazioni, infatti, talvolta aprono spazi per un’espansione quantitativa o per un ascesa di alcuni di questi settori, in altre occasioni invece avviano processi di proletarizzazione e quindi di loro dissoluzione. I loro confini, allora, sono fluidi e talvolta indistinti, con soggetti in transizione da una condizione all’altra.
La strutturazione del capitale, il suo movimento e la dinamica dello scontro di classe incidono quindi sulla configurazione e l’organizzazione del lavoro. Questa articolazione tra diverse organizzazioni produttive e differenti composizioni sociali non è per l’appunto statica, ma è in continua trasformazione in relazione alla dinamica ciclica ed alle tendenze di fondo del capitalismo. Boom, onde lunghe, depressioni e Grandi Crisi sospingono e modellano processi di concentrazione o di dispersione, ristrutturazione delle filiere, ridefinizione delle mansioni e delle professioni, movimenti migratori e relazioni tra i generi. L’organizzazione e la coscienza di classe dipende inoltre dalla dinamica ineguale e combinata del mercato mondiale, con le sue gerarchie nella divisione internazionale del lavoro e il loro progressivo mutare nel tempo. Così, negli ultimi decenni, il relativo declino degli imperialismi occidentali e la prorompente esplosione di quello cinese hanno modellato profonde riorganizzazioni produttive e sociali, con una scomposizione del lavoro nei primi e l’emergere di una nuova classe operaia nel quadrante asiatico (giovane, concentrata e di recente migrazione dalle campagne). In questo quadro, alcuni settori del proletariato assumono poi configurazioni ibride: per esempio, la grande espansione urbana degli ultimi decenni, soprattutto nelle periferie e nelle semi-periferie del mondo [da Lagos a Istanbul, da Karachi a San Paolo, dal Cairo a Mumbai] è segnata da masse di contadini sradicati, la cui definizione sociale è ancora instabile e magmatica. Infine, le vittorie e le sconfitte parziali che segnano i periodi di ascesa come le lunghe depressioni, la strutturazione di organizzazioni sociali e politiche, la cristallizzazione di immaginari ed aspettative sociali, influenzano le stesse trasformazioni economiche e plasmano le identità collettive. Nella società contemporanea, cioè, da una parte il rapporto sociale dominante è quello capitalista, dall’altra il proletariato è comunque frammentato e segnato da una continua composizione e scomposizione delle diverse consapevolezze del suo antagonismo con il capitale.
IL PARTITO E IL SUO RUOLO PER UNA TRANSIZIONE DI SISTEMA
Il partito, l‘avanguardia politica organizzata intorno ad un programma, ha in questo quadro un ruolo fondamentale. In primo luogo, nella costruzione di una progettualità transitoria. Anche se le classe ha un suo spirito ed una sua prassi rivoluzionaria, infatti, la prospettiva di una trasformazione del modo di produzione non può che definirsi attraverso un’avanguardia politica organizzata. A questo proposito, è importante distinguere tra processo rivoluzionario inteso come abbattimento delle classi dominanti e processo rivoluzionario inteso come presa del potere e suo uso per la trasformazione del modo di produzione capitalista. L’antagonismo di classe che si sviluppa nei processi produttivi, come il più generale sfruttamento dell’uomo e della natura determinato dal sistema capitalista, sospinge cioè conflitti e resistenze sociali che possono anche abbattere le classi dominanti: come abbiamo detto è già capitato tante volte in questi ultimi due secoli e lo abbiamo visto anche negli ultimi decenni in diversi paesi della periferia e della semi-periferia. La costruzione di una società diversa è però qualcosa che va oltre la conquista del potere ed interessa una profonda trasformazione delle relazioni produttive.
In realtà, riprendendo alcune pagine di Marx, c’è chi ritiene che le forme di un diverso modo di produzione siano già maturate all’interno dello sviluppo capitalista (anche grazie alla sua contestazione operaia) e debbano solo esser liberate dalle relazioni di dominio che attualmente le costringono. L’automazione e la produzione di macchine a mezzo di macchine avrebbe cioè da una parte frantumato e sussunto il lavoronella loro semplice supervisione, dall’altra spostato la produzione del valore nella conoscenza diffusa e nella prassi sociale (il cosiddetto general intellect). La cooperazione sociale si organizzerebbe quindi sempre più fuori dall’impresa e dai tempi di lavoro (infatti per loro dovrebbe esser remunerata attraverso un salario sociale). La sua attuale subordinazione alle classi dominanti sarebbe allora determinata semplicemente dalla sua oppressione politica (o meglio, biopolitica), non dall’organizzazione della produzione. È questa in fondo la matrice di quel composito movimento radicale, democratico e costituente che ritiene che queste nuove relazioni sociali possano affermarsi attraverso la rottura del comando politico del capitale [vedi ad esempio le Venti tesi sul comunismo di Toni Negri, 1989]. Però c’è anche chi ritiene che sia possibile costruire, nel quadro delle attuali formazioni sociali, forme estese di cooperazione a carattere mutualistico o comunitario: facendole crescere negli interstizi dello sviluppo capitalista, queste potranno progressivamente estendersi e quindi far germogliare diverse relazioni sociali [in sostanza, sono forme contemporanee di proudhonismo e anarchismo]. Alcuni riprendono questa impostazione intrecciandola con le Temporary Autonomous Zone (Hakim Bey, 1991), spazi autogestiti in grado di eludere temporaneamente le strutture e le istituzioni imposte dal controllo sociale. Infine, c’è anche chi ritiene che l’antagonismo del lavoro, sviluppando una dimensione politica democratica costretta a guardare all’interesse sociale complessivo, possa piegare la dinamica del capitale senza bisogna di spezzarlo, costruendo società che potremmo definire ibride (a capitalismo sotto controllo pubblico): il dilemma politico contemporaneo, da questo punto di vista, sarebbe tutto nella costruzione di forme statuali internazionali, capaci di imbrigliare la dimensione globale e neoliberale dell’attuale capitale (questa, al fondo, la matrice che domina l’attuale riformismo, spesso nella veste di teorie neokeynesiane, e che purtroppo funge da riferimento anche di diversi settori centristi).
Il movimento comunista, sin dalla teorizzazioni di Marx ed Engels, ritiene invece necessario l’uso del potere politico per cambiare processi produttivi e relazioni sociali. Marx, infatti, analizzando la formazione della società capitalista aveva individuato con precisione il ruolo determinante che il potere politico aveva assunto nella costruzione di quei rapporti sociali. Lo possiamo vedere in particolare nella sua analisi sull’accumulazione originaria (Libro I, capitolo XXIV, del Capitale). Da una parte è lo Stato che determina la formazione di un proletariato libero, attraverso l’espropriazione della popolazione rurale e la sua espulsione dalle terre, il disciplinamento della nuova forza lavoro con la legislazione sanguinaria contro gli espropriati (vedi le politiche su poveri e vagabondi), le leggi per l’abbassamento dei salari. [Così la popolazione rurale espropriata con la forza, cacciata dalla sua terra, e resa vagabonda, veniva spinta con leggi fra il grottesco e il terroristico a sottomettersi, a forza di frusta, di marchio a fuoco, di torture, a quella disciplina che era necessaria al sistema del lavoro salariato]. Dall’altra parte è lo Stato che permette la formazione del primo capitale necessario a sottomettere il lavoro, costruendo un sistema commerciale di selvaggia depredazione di altri popoli e proteggendo lo sviluppo di una propria industria nazionale. [I vari momenti dell’accumulazione originaria si distribuiscono ora, più o meno in successione cronologica, specialmente fra Spagna, Portogallo, Olanda, Francia e Inghilterra. Alla fine del secolo XVII quei vari momenti vengono combinati sistematicamente in Inghilterra in sistema coloniale, sistema del debito pubblico, sistema tributario e protezionistico moderni. I metodi poggiano in parte sulla violenza più brutale, come per esempio il sistema coloniale. Ma tutti si servono del potere dello Stato, violenza concentrata e organizzata della società, per fomentare artificialmente il processo di trasformazione del modo di produzione feudale in modo di produzione capitalistico e per accorciare i passaggi. La violenza è la levatrice di ogni vecchia società, gravida di una società nuova. È essa stessa una potenza economica]. Marx aveva svolto con rigore l’analisi del capitale e delle sue contraddizioni, ma si era rifiutato di teorizzare la futura società socialista: era cioè restio a prescrivere ricette per l'osteria dell'avvenire (prefazione alla prima edizione del Capitale). Nonostante questo, in diversi scritti (Manifesto, Lotte di classe in Francia del 1850, lettera a Weydemeyer del 1852, Critica del programma di Gotha del 1875) Marx ed Engels precisano che lo strumento necessario per riorganizzare i rapporti di produzione è il potere politico (il controllo della violenza e l’uso economico di questa violenza), come per la precedente transizione tra modi di produzione, attraverso un uso anticapitalista dello Stato e dei suoi poteri dittatoriali, sia per difendere la rivoluzione sia per riorganizzare nuove relazioni sociali (espropriazione della proprietà fondiaria, requisizioni di siti produttivi, statalizzazione dei mezzi di produzione e del credito, ecc.).
Nei primi del novecento si definisce con più precisione l’impostazione e il ruolo del partito. Kautsky [in diversi articoli sulla Neue Zeit, il principale quotidiano della SPD, 1901] e Lenin [Che fare?, 1902] sottolineano infatti come questo progetto transitorio debba necessariamente organizzarsi intorno ad un programma, raccogliendo un’avanguardia politica che lo condivide.Intendiamoci, nel movimento comunista e rivoluzionario c’erano (e ci sono) settori che ritengono che in realtà la classe lavoratrice abbia in sé non solo una forza antagonista in grado di abbattere le classi dominanti, ma anche la capacità di autorganizzarsi e sviluppare un processo transitorio, gestendo direttamente con comuni e forme consiliari di autogoverno la costruzione di un diverso modo di produzione (settori sostanzialmente consiliaristi, talvolta di matrice anarchica, spesso federalisti, ma non sempre). Le elaborazioni di Kautsky e di Lenin, però, sono state condotte in un preciso scontro politico contro altre e diverse tendenze del movimento operaio. La crescita dei partiti socialdemocratici alla fine dell’ottocento aveva infatti iniziato a porre al movimento socialista il problema di come usare quella forza nella politica quotidiana. In particolare, questo avvenne in Germania (dove era cresciuto un forte partito, la SPD, con le sue rappresentanze parlamentari e le sue organizzazioni sindacali) e in Francia, dove sebbene le organizzazioni operaie erano diverse e non particolarmente strutturate, nel quadro dell’ondata antimilitarista scatenata dall’affaire Dreyfus erano stato eletto nel 1898 un significativo gruppo parlamentare. Nel frattempo, in Russia si era sviluppata un’imponente concentrazione industriale ed erano emerse le prime grandi lotte operaie: in questi conflitti sociali si svilupparono allora tendenze che focalizzavano i compiti del movimento nella difesa degli immediati interessi di classe (a partire da salari e condizioni di lavoro).
La Germania e il bernestein-dibatte. Nell'estate del 1894 il gruppo SPD nella Dieta Bavarese, guidato da Georg Vollmar, decise di votare a favore del Bilancio annuale. La scelta cadde nel silenzio più o meno disattento del partito e, in particolare, del suo gruppo dirigente. Un giornalista socialdemocratico di Dresda, però, scrisse sulla Neue Zeit un articolo che denunciava la scelta bavarese (non un singolo uomo e non un solo centesimo per il governo borghese: il sostegno al bilancio è equivalente al sostegno dell'ordine politico predominante). L’articolo era firmato Parvus (uno dei primi con questo pseudonimo) e per certi versi diede il via a una discussione che dominò il decennio successivo. Il dibattito si scatenò in realtà solo nell’ottobre 1897, quando uscirono una serie di articoli sui problemi del socialismo a cura di Eduard Bernstein (uno dei principali e più conosciuti dirigenti della SPD insieme a Kautsky, Bebel e Liebknecht). Il sistema capitalista, sosteneva Bernstein, era tutt’altro che in crisi, a partire dal fatto che alcune sue evoluzioni non erano state previste da Marx: in particolare la diffusione dell'azionariato (in controtendenza alla concentrazione della proprietà), il diffondersi di nuovi ceti medi e intermedi (piccole imprese, tecnici, professionisti), la capacità delle politiche di trust di attenuare le crisi. Nel quadro del suffragio universale maschile, di una sempre viva minaccia reazionaria e di persistenti diseguaglianze economiche (bassi salari e insicurezza del lavoro), si apriva però la strada di una politica di difesa della democrazia e di progressiva socializzazione della produzione, attraverso riforme che avrebbero gradualmente inculcato nel capitalismo un diverso sistema sociale (il movimento è tutto, il fine è nulla). Come precisarono conseguentemente Bernestein e Vollmar sulla Petite republique (vedi punto successivo), se il principio della lotta di classe ci costringesse effettivamente a restare in disparte, con le braccia conserte e a guardare con indifferenza tutte le volte che la classe operaia non è direttamente coinvolta nella vicenda, il socialismo non sarebbe mai il movimento che abbraccia il mondo ed al quale appartiene l'avvenire, ma soltanto una setta limitata e sterile, presto messa al margine degli eventi: quindi si deve riconoscere che nell'evoluzione delle nazioni moderne possono presentarsi delle fasi in cui l'impossessarsi parzialmente del potere governativo può essere per il partito socialista, più che una cosa lecita, un dovere fondamentale. È la teorizzazione della compartecipazione a governi interclassisti. Le posizioni di Bernstein e Vollmar furono tema di ampia discussione, iniziata ancora una volta da Parvus con diversi articoli tra gennaio e marzo 1898 [Il rifacimento bernsteiniano del socialismo] e proseguita poi dalla Luxemburg nel 1899 in Riforma sociale o rivoluzione?, riprendendo ipotesi sull’attualità di una politica rivoluzionaria contro le politiche capitaliste ed i rischi reazionari già avanzati dallo stesso Parvus nel 1896 in Colpo di stato e sciopero politico di massa. Le tesi riformiste furono respinte come opportuniste al congresso di Stoccarda (1898), anche se Bernstein fu invitato ad approfondire le sue ipotesi (invito da cui nacque, nel 1899, I presupposti del socialismo e i compiti della socialdemocrazia). L’ala moderata della SPD, in particolare quella sindacale (che poteva contare sul sostegno di organizzazioni con molti più iscritti del partito, solide risorse finanziarie e un imponente apparato che gestiva anche cooperative, giornali e strutture mutualistiche), vide infatti in questa strategia la possibilità di focalizzare la politica del partito sul miglioramento delle condizioni di lavoratori e lavoratrici, senza mettere a rischio strutture e apparati conquistati nel quadro della società capitalista: per questo ne sostenne con sempre maggior determinazione l’approccio, mettendo sotto accusa nel successivo congresso di Lubecca (1901) proprio l’ala sinistra (e straniera) di Parvus e Luxemburg (la più polemica con Bernstein). In ogni caso, Kautsky intervenne con vigore contro l’impostazione riformista proprio dopo quel congresso, con il saggio Riforma e rivoluzione sociale (1902), in cui sottolineò come lo sviluppo capitalista aveva rafforzato il potere dello stato e il comando delle classi dominanti (contrastando quindi la visione di Bernstein di un progressivo allargamento della democrazia), il capitalismo finanziario accresciuto il proprio peso (contro ogni ipotesi di socializzazione con politiche antidemocratiche e spinte imperialistiche) e le trasformazioni economiche espanso la classe operaia e quindi il conflitto sociale (che ora si esprimerebbe attraverso lo sciopero di massa, anche con valenza politica).
La Francia e il riformismo pratico. Nel 1894 Alfred Dreyfus, ufficiale di artiglieria ebreo ed alsaziano, fu accusato di spionaggio e condannato all’Isola del Diavolo, in Guayana. Nel 1896 uscì L'Affare Dreyfus: un errore giudiziario e il 13 gennaio 1898 Emile Zola pubblicò il suo famoso J’Accuse. Il giorno dopo apparve la Petizione degli intellettuali, firmata tra gli altri da metà dei professori della Sorbona, Renard, Gide, Anatole France e il giovane Proust. L’affaire tracciava cioè un solco politico generale tra democratici e reazionari. Le elezioni del maggio 1898 videro un buon risultato dei primi e un consolidamento del gruppo socialista (oltre una sessantina di deputati su 586). Alla precedenti elezioni c’era già stata una notevole affermazione (più di 40 deputati), anche se il movimento era diviso trail Partito operaio francese di Lafargue e Guesde (d’area marxista), il Partito socialista rivoluzionario di Vaillant (blanquista e nel Consiglio della Comune), il Partito operaio socialista rivoluzionario di Allemane (altro comunardo, scissione della Federazione dei lavoratori socialisti di Brousse) e soprattutto i cosiddetti indipendenti (cappeggiati da Millerand e Viviani, tra cui ci sarà anche Briand, tutti poi con importanti incarichi di governo nel corso della prima guerra mondiale). Queste formazioni svilupparono però un’unità d’azione, sancita da Millerand al congresso dei Comuni socialisti tenutosi a St. Mande il 30 maggio 1896: un movimento politico che si propone la sostituzione necessaria e progressiva della proprietà capitalista, da perseguirsi con lo strumento necessario e sufficiente del suffragio universale, inteso come mezzo per la conquista dei pubblici poteri, e con quello dell'intesa internazionale dei lavoratori. Come si vede, era in sostanza la prospettiva poi teorizzata da Bernstein. Allora passò comunque inosservata e le divisioni sorsero con la precipitazione dell’affaire Dreyfus, che tra 1898 e 1899 vide dispiegarsi complotti monarchici, pronunciamenti militari e un aspra lotta per la presidenza della Repubblica (vinta alla fine da Loubet, dreyfusista). Il POF, infatti, denunciò il rischio di una subordinazione alle politiche borghesi e sin dal luglio ‘98 fece venir meno il sostegno al campo dreyfusista. La frattura fu però successiva. ll 3 giugno 1899 la Corte di Cassazione decise la ripetizione del processo, il giorno successivo Loubet fu aggredito ad Auteuil e a fronte di manifestazioni contrapposte il governo si dimise. In quel contesto, segnato da timori di colpi di mano reazionari, il presidente affidò l’incarico per un governo di coalizione a Waldeck-Rousseau, un senatore dreyfusista e repubblicano. Millerand accettò allora di farne parte a titolo personale, nonostante la presenza di un generale dell’esercito che aveva guidato la repressione della Comune. Il POF denunciò questa scelta e il gruppo parlamentare si spaccò. Lo scandalo era innescato più dalla presenza di quel generale e dalla decisione individuale di Millerand più che dalla sua impostazione strategica: bisogna infatti notare che già nel novembre 1895 quasi tutti i deputati socialisti, guesdisti compresi, avevano votato a favore del governo radicale di Leon Bourgeois (l'episodio però era passato inosservato, in Francia come in Europa). In ogni caso, la discussione nel socialismo francese portò ad un ampio dibattito internazionale, promosso dalla Petit republique (il giornale degli indipendenti) su due quesiti (possono le forze socialiste intervenire nei conflitti tra i partiti borghesi per salvare la libertà politica? e in quale misura il proletariato socialista può partecipare al potere borghese?). Ad intervenire (tra gli altri) furono i tedeschi Bebel, Kautsky, Liebknecht, Schohlank, Bernestein e Vollmar; gli inglesi Hardie, Mann, Hyndman e Quelch; gli italiani Ferri e Labriola; i belgi Bertrand e Vandervelde, il russo Plechanov. I socialisti indipendenti voteranno negli anni successivi più volte a favore del governo, tra polemiche e aspre discussioni: Jean Jures sostenne con convinzione la scelta ministeriale, mentre POF, blanquisti e anarchici guidarono il fronte intransigente. Nel 1900 si tenne proprio a Parigi il congresso della seconda internazionale, che fu dominato dalla discussione sul nono punto all'ordine del giorno (conquista dei pubblici poteri e alleanze con i partiti borghesi): in quell’occasione si affermò una mozione unitarista redatta da Kautsky (contro una versione intransigente), che pur affermando che la lotta di classe non permetteva qualunque sorta di alleanza con qualsiasi frazione della classe capitalista, ammetteva che le coalizioni possano rendersi necessarie in situazioni eccezionali, da valutarsi in sede nazionale, con l'assenso del partito e le dimissioni quando il governo dia evidenti prove di parzialità nel conflitto capitale/lavoro.La mozione cioè, pur contestando la possibilità di una conquista graduale del potere, apriva di fatto la possibilità a partecipazioni governative (non a caso fu sostenuta da Bernstein, Vollmar e Jures, ritenendo che potesse esser il punto di partenza di un’azione riformatrice di vasto respiro). Vaillant si chiese pubblicamente come Kautsky, che in Germania aveva lottato contro Bernstein, potesse capitolare di fronte alle stesse tesi. La mozione, infatti, era il tentativo di evitare una spaccatura, in particolare nella SPD, ed evidenziava da una parte la particolare preoccupazione del leader tedesco per l’unità del movimento socialista, dall’altra le sue future evoluzioni politiche. Lo stesso Kautsky, comunque, subito dopo il congresso ne diede una lettura più intransigente sulla Neue Zeit: le alleanze tra forze socialiste e liberali, precisò, sono un indizio della forza della reazione e sono possibili solo in funzione difensiva, escludendo ogni possibilità di usarle per delle riforme o che i partiti operai si facciano promotori di vasti schieramenti popolari. Non a caso l’articolo innescherà un’aspra risposta di Vollmar e quindi una replica della Luxemburg, di fatto segnando un cambio di atteggiamento della SPD nei confronti di Millerand e quindi il suo progressivo isolamento. La risoluzione di Parigi non rimase però senza effetti: nel 1901, ad esempio, il PSI votò la fiducia al governo Zanardelli-Giolitti (anche se, ricordiamolo, nel 1912 Bissolati, Bonomi e Cabrini furono espulsi per la scelta di partecipare alle consultazioni per un nuovo governo: fonderanno il Partito Socialista Riformista Italiano ed entreranno nell’esecutivo di guerra del 1916, come gli indipendenti francesi). Il VI congresso della seconda Internazionale, tenutosi ad Amsterdam nel 1904, in ogni caso portò a bocciare esplicitamente le strategie riformiste di Bernstein e le tattiche di difesa repubblicana di Jures, adottando di fatto la stessa risoluzione che la SPD aveva approvato l’anno prima al suo congresso di Dresda. [Da notare che lo stesso Jures, in un articolo del 1903 sull’italiana Critica sociale, aveva delineato con abbastanza precisione la parabola kautskyana della SPD: quando il socialismo tedesco, malgrado la ristrettezza pedantesca di taluni suoi dottrinari, avrà assunto, nello stesso interesse del proletariato e della rivoluzione sociale, il compito di un grande partito di democrazia, Kautsky ostinato a rimanere il teorico ufficiale di un'evoluzione che non avrà potuto impedire, saprà ben trovare qualche combinazione arbitraria di concetti astratti per accomodare alla vita nuova le massime di Marx].
La Russia e l’economicismo. La Russia si trovava allora in una condizione alquanto diversa. Era una dittatura autocratica che vedeva fuori legge tutte le organizzazioni politiche, anche quelle liberali e conservatrici. Una formazione sociale sostanzialmente rurale che, nel quadro dello sviluppo del mercato mondiale innescato dalla grande depressione del 1873/95 (la prima globalizzazione che terminerà con la prima guerra mondiale), aveva visto l’emergere di importanti concentrazioni industriali, con processi produttivi anche avanzati. Una situazione analizzata da Lenin in una delle sue prime opere (Lo sviluppo del capitalismo in Russia, 1899) e ancor di più da Parvus negli anni successivi (con una serie di saggi ed articoli, pubblicati sulla Neue Zeit e poi sull’Iskra sul mercato mondiale, la spinta a costruire blocchi economici sempre più grandi, il destino di una prossima contrapposizione tra USA e Russia a fronte di un Europa divisa, le contraddizioni russe tra fame e sviluppo capitalista, le conseguenza della guerra russo-giapponese e la probabilità dello scoppio di una rivoluzione nel paese). In questo quadro, negli anni novanta dell’ottocento si svilupparono in Russia le prime grandi lotte operaie: nel 1893 un primo imponente sciopero a Rjazan, un centinaio di chilometri da Mosca; nel 1894 a San Pietroburgo, Mosca, Minsk, Vilna e Tiflis; nel 1895 le officine Putilov, seguiti prima dalle industrie delle calzature e del tabacco della capitale e poi da realtà in tutto il Paese; nel 1896 infine gli scioperi scossero San Pietroburgo, anche con manifestazioni di massa, e si ripeterono poi a Rostov nel 1902 e in Russia meridionale nel 1903. In questo contesto, mentre diversi gruppi si stavano unificando nel Partito Operaio Socialdemocratico Russo (POSDR, primo congresso a Minsk nel 1898 e secondo a Bruxelles/Londra nel 1903), alcuni di questi circuiti si definirono in stretta relazione con questi movimenti di massa (in particolare, quelli aggregati intorno a due giornali: Rabociaja Mysl' e Raboceie Delo, il Pensiero Operaio e la Causa operaia): la lotta per una posizione economica, la lotta contro il capitale sulla base dei quotidiani interessi essenziali e gli scioperi come mezzo di tale lotta, ecco il motto del movimento operaio; questa lotta rimane comprensibile a tutti, tempra le forze e unisce gli operai. Il profilo ed il programma di questi circuiti, cioè, consisteva nello sviluppare le rivendicazioni economiche di lavoratori e lavoratrici, nel quadro dei loro conflitti nei processi di produzione. Veniva quindi respinta ogni ipotesi di impegno politico, sia quello immediato contro la dittatura sia quello in prospettiva per cambiare il modo di produzione. L’iniziativa doveva invece rimanere strettamente connessa all’aumento dei salari, la riduzione della giornata lavorativa, lo sviluppo di sindacati, casse di mutuo soccorso e centri ricreativi. L’idea di fondo era che lavoratori e lavoratrici dovevano autorganizzarsi, costruendo da soli le proprie strutture, perché l'emancipazione degli operai è compito degli stessi operai. In questo quadro, la Rabočee Delo sviluppò un gradualismo programmatico sostanzialmente coincidente con il riformismo pratico francese e con quello teorico di Bernstein, pur in un quadro totalmente diverso. Lenin quindi, nel percorso di formazione del POSDR passerà dalla polemica contro i gruppi populisti (in particolare Narodnaja volja, la Volontà del popolo, che si poneva l’obbiettivo politico di abbattere il regime tramite una vasta azione terrorista, interrompendo così lo sviluppo capitalista guidato dallo Stato e sviluppando un diverso modo di produzione centrato sull’obščina, la comunità contadina russa) a quella contro questi nuovi settori economicisti (che al contrario rifiutavano qualsiasi rivendicazioni politica, l’obbiettivo della conquista del potere e quindi anche ogni progetto politico socialista).
Kautsky e Lenin, nei primi anni del novecento, arrivarono quindi a precisare la necessità dell’organizzazione di un partito di avanguardia in relazione a questi scontri. Il ruolo del partito, organizzato intorno ad un programma, è stato cioè precisato contro l’emergente tendenza di altri settori del movimento operaio che si focalizzavano sulla difesa ed il miglioramento delle condizioni del lavoro, sul movimento piuttosto che sull’obbiettivo. Sia Kautsky sia Lenin, cioè, hanno sottolineato la differenza tra antagonismo della classe [la classe operaia con le sue sole forze è in grado di elaborare soltanto una coscienza tradunionista, cioè la convinzione della necessità di unirsi in sindacati, di condurre la lotta contro i padroni, di reclamare dal governo questa o quella legge necessaria agli operai,..] e progetto politico transitorio [la coscienza socialista è un elemento importato nella lotta di classe del proletariato e non qualche cosa che ne sorge spontaneamente … il compito della socialdemocrazia è di introdurre nel proletariato la coscienza della sua situazione e della sua missione], contro chi sosteneva che questo passaggio si sarebbe sviluppato più o meno spontaneamente, sostanzialmente per limitare la propria azione nei confini di una linea riformista (difesa degli interessi di classe nella società capitalista).
Lenin, nel Che fare? tenderà come spesso gli capita a piegare il bastone, cioè a radicalizzare le sue argomentazioni per meglio contrapporsi all’oggetto della sua polemica. Nello specifico, lo fece sottolineando eccessivamente il ruolo degli intellettuali e in fondo del partito, cioè di una coscienza esterna alla classe. Lo riconobbe già nel 1903 [tutti noi sappiamo che gli economisti avevano piegato il bastone da una parte, per raddrizzarlo era necessario curvare dalla parte opposta], lo ribadì contro gli uomini dei comitati nel 1904 [contro chi voleva escludere gli operai dai comitati di partito, in nome di quella presunta mancanza di coscienza della classe] e infine ancora più nettamente nel 1908 [la classe operaia si distingue, grazie a cause economiche oggettive, da tutte le classi...Senza questa condizione, l’organizzazione dei rivoluzionari di professione sarebbe stata un giocattolo, un’avventura, una vacua insegna…solo quando esiste una classe veramente rivoluzionaria che spontaneamente si leva alla lotta ha un senso l’organizzazione che esso propugna].