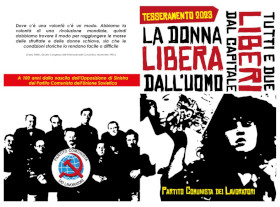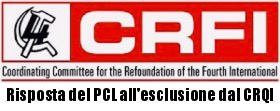Prima pagina
Il Partito Comunista d'Italia e le origini del fronte unico
8 Luglio 2021
#Livorno21
1921, i delegati italiani al terzo congresso del Comintern
ORIGINE DEL PARTITO E DEL SUO MINORITARISMO
In Italia la formazione del Partito Comunista d'Italia fu diversa rispetto ad altri paesi dell’Europa occidentale.
La rappresentanza della classe operaia era fin dall’inizio del ventesimo secolo nelle mani del Partito Socialista Italiano, che controllava completamente la Confederazione Generale del Lavoro e che, con la posizione di neutralità assunta nel corso della Prima guerra mondiale, aveva visto, alla fine del conflitto, enormemente aumentata la sua influenza e il suo peso politico e nella classe e nell’ambito della società nel suo complesso, tanto da arrivare ad ottenere nelle elezioni politiche che si tennero nel novembre del 1919 più del 33% dei voti.
Nello stesso anno il partito socialista, su iniziativa della direzione serratiana, aveva aderito all’Internazionale Comunista e partecipato al secondo congresso di quest’ultima con voto deliberativo.
Il PSI era un partito organizzato in varie correnti. Le più forti ed organizzate erano quella riformista, guidata dai vecchi fondatori del partito, con Turati e Treves in testa, che controllava il gruppo parlamentare e dirigeva la Confederazione Generale del Lavoro; quella massimalista – o, come sarà chiamata, dei “comunisti unitari” – che governava formalmente il partito, controllandone la direzione e l’organo di stampa, l’Avanti, che faceva capo a Giacinto Menotti Serrati e a Costantino Lazzari; ed infine quella cosiddetta astensionista, o intransigente rivoluzionaria, i cui aderenti si richiamavano ad Amadeo Bordiga, che vedeva nell’eccessivo elettoralismo del PSI una delle basi del gradualismo riformista di cui era artefice soprattutto il gruppo parlamentare, e proponeva quindi la non partecipazione del partito alle competizioni elettorali.
Accanto a queste correnti nazionali ne esisteva un’altra di carattere locale, quella della rivista Ordine Nuovo pubblicata a Torino e che, guidata da Antonio Gramsci e da Angelo Tasca, diventerà un punto di aggregazione e di richiamo per la sinistra torinese soprattutto giovanile e studentesca.
Quando il secondo congresso dell’Internazionale Comunista stabilì l’approvazione completa dei 21 punti per la piena adesione all’Internazionale, solo i seguaci di Bordiga e dell’Ordine Nuovo si dichiararono per la loro totale accettazione, mentre i massimalisti, con Serrati e Lazzari in testa, sollevarono una serie di questioni, soprattutto sui punti sette e ventuno (quelli che prevedevano la rottura definitiva coi riformisti e l’esclusione dal partito di quelli che rifiutavano le condizioni), e pertanto li accettarono sì, ma con riserva.
Inoltre nel dibattito Serrati si dichiarò esplicitamente contro l’espulsione della componente turatiana, argomentando che Turati aveva sempre rispettato la disciplina di partito e non c’era quindi motivo per espellerlo.
La delegazione tornò dal congresso con forti divergenze tra chi propendeva per l’adesione con la piena approvazione dei punti e chi voleva, al contrario, una certa elasticità nell’accettazione delle condizioni.
Per risolvere la disputa si decise la convocazione di un congresso straordinario per deliberare sulle decisioni prese dall’Internazionale.
Nell’attesa, tra i forti contrasti che le attraversavano, le varie frazioni del partito si organizzavano.
Agli inizi di ottobre del 1920, durante una riunione della direzione del PSI, viene approvato un ordine del giorno che sanciva l’accettazione delle 21 condizioni e prevedeva l’esclusione dal partito dell’ala riformista, secondo i criteri che sarebbero stati stabiliti nel corso del prossimo congresso ma, nella sorpresa generale, il capo riconosciuto del partito, quel Giacinto Menotti Serrati che in quel periodo godeva ancora della fiducia di Lenin, votava contro, dichiarando che le condizioni di ammissione andavano adeguate alla situazione italiana, cercando così di preservare l’unità del partito. Chiaramente questa presa di posizione di Serrati avrebbe notevolmente influenzato il grosso del corpo del partito.
I turatiani, da parte loro, in un convegno tenutosi a Reggio Emilia ribadivano per l’ennesima volta che il periodo apertosi nel primo dopoguerra non fosse rivoluzionario e che la fase acuta dello scontro di classe fosse ancora lontano dal manifestarsi. Riaffermando la loro adesione all’Internazionale, richiedevano autonomia nell’interpretazione della fase e flessibilità nell’applicazione delle condizioni.
Anche i comunisti, che accettavano incondizionatamente i criteri stabiliti per l’adesione all’Internazionale, nel novembre del 1920 organizzano un convegno a Imola, in vista della battaglia congressuale. A questo incontro erano presenti il gruppo del Soviet di Napoli, che faceva capo ad Amadeo Bordiga, il gruppo dell’Ordine Nuovo dei torinesi Gramsci e Tasca, e alcuni massimalisti di sinistra che cominciavano a demarcarsi dalla frazione di Serrati.
Qui fu decisa la costituzione della frazione comunista del PSI, che si poneva come obiettivo di preparare la struttura del vero partito comunista, che si poteva realizzare solo attraverso la rottura da operare tra chi si riconosceva compiutamente con le decisioni di Mosca e tutti gli altri, in primis i turatiani ed eventualmente anche con i seguaci di Serrati, sempre più recalcitranti ad accettare il percorso deciso dall’Internazionale.
Fu in questo contesto che si stabilirono i primi obiettivi che il futuro partito avrebbe dovuto perseguire: 1) preparazione della struttura organizzata per assicurare il successo all’azione rivoluzionaria del proletariato; 2) radicale cambiamento nelle relazioni con la Confederazione Generale del Lavoro, la cui direzione non rappresentava in modo adeguato e conseguente gli interessi della classe operaia; 3) partecipazione del futuro partito alle competizioni elettorali, sia nazionali che locali, non più nel senso socialdemocratico, mirante all’esclusiva occupazione dei posti per la gestione dell’ordinarietà borghese, ma secondo la tradizione leninista, ovvero utilizzo delle istituzioni al fine di compiervi propaganda ed agitazione rivoluzionaria, per accelerare la rovina dello Stato del capitalismo.
Al congresso di Livorno ogni frazione ripresentò il suo punto di vista. I seguaci di Serrati, ribadendo fedeltà all’Internazionale, chiedevano la flessibilità geografica, ovvero l’adattamento alla situazione italiana dei ventuno punti. I comunisti di Bordiga riaffermavano la necessità del partito indipendente, che potesse guidare il proletariato alla presa del potere, e quindi l’espulsione dei seguaci di Turati.
I risultati del congresso determineranno i rapporti di forza delle future organizzazioni politiche del movimento operaio italiano: su 172.487 voti validi, i massimalisti otterranno 98.028 voti, i comunisti 58.783, i riformisti di Turati 14.695.
LA SCISSIONE DI LIVORNO NEL DIBATTITO DELL'INTERNAZIONALE
Il risultato del congresso deluse profondamente il gruppo dirigente dell’Internazionale Comunista, che sperò fino all’ultimo che almeno il settanta per cento dei membri del PSI avrebbe seguito i comunisti nella nuova avventura, e nonostante gli sforzi fatti dai suoi inviati Rákosi e Kabakchiev, che provarono in tutti i modi di convincere Serrati ad allontanare Turati e i suoi dal partito, e quindi far nascere un partito comunista di notevoli dimensioni, il risultato non fu raggiunto. Pertanto, grazie all’atteggiamento dei centristi serratiani, il PCd'I nacque come partito minoritario, con una più che buona capacità di attrarre a sé l’avanguardia più sensibile e combattiva della classe ma con un’influenza abbastanza limitata sul resto del movimento operaio italiano, come fu testimoniato dal congresso CGL del febbraio del 1921, dove la componente comunista otterrà all’incirca 430.000 voti, mentre quella composta dalla lista unitaria massimalista-riformista ne conquisterà 1.400.000.
La minore influenza del PCd'I sulla classe operaia sarà certificata anche dalle elezioni politiche del mese di maggio, dove il giovane partito raccoglierà circa 300.000 voti, contro il 1.600.000 del partito socialista.
Le attese dell’Internazionale erano andate in parte deluse. In Italia il partito era nato ma era minoritario, e per giunta si trovava ad operare in una situazione dove il conflitto di classe, esaurito il periodo del Biennio rosso, era entrato in una fase discendente, dove il padronato riprendeva vigore e cominciava ad affidare i suoi destini al nascente fascismo, che da lì a poco personificherà il desiderio di rivalsa del capitalismo italiano, che non dimentico delle paure che aveva vissuto durante l’esperienza del 1919-'20, si preparava a presentare il conto alla classe operaia. Un conto salato.
Dopo Livorno un grande dibattito si svilupperà tra le file del comunismo internazionale per stabilire se era stata corretta la scelta di fondare la sezione italiana dell’Internazionale Comunista con una minoranza del PSI.
Le opinioni erano molto variegate: tra chi considerava l’esperienza di Livorno come la soluzione ideale per rompere coi centristi, così da dare omogeneità programmatica al partito del proletariato al fine di preparare la conquista del potere, e chi, al contrario, la considerava un grave errore, perché riduceva notevolmente la base operativa su cui doveva muovere il nuovo partito, indebolendo così la potenzialità del suo intervento all’interno della stessa classe operaia.
In linea di principio la soluzione di Livorno veniva considerata corretta, ma già nel corso del 1921 emergevano in seno all’Internazionale i primi dubbi tra chi riteneva un “regalo” alla reazione la nascita del partito su basi minoritarie e chi, al contrario, pensava che il partito avrebbe potuto intraprendere un percorso che lo avrebbe portato ad erodere la base sociale del PSI e diventare così il partito di riferimento della classe operaia italiana.
Ma, al di là delle polemiche che attraversano il movimento comunista internazionale, l’obiettivo della formazione della nuova direzione politica della classe operaia italiana era raggiunto. Si trattava adesso di vederlo all’opera.
Il partito nasce quando ormai la spinta rivoluzionaria del primo dopoguerra si era esaurita e già cominciavano a manifestarsi i primi segnali revanchisti dei padroni, che utilizzando le bande fasciste cominciavano a colpire le strutture organizzate del movimento operaio italiano per cancellare quelle timide conquiste che gli operai avevano ottenuto con le lotte del Biennio rosso. In questa situazione, particolarmente infuocata, il partito muove i suoi primi passi.
Ma che tipo di partito era il Partito Comunista d'Italia? Il lavoro di frazione operato da Bordiga fin dal 1912, col "circolo Carlo Marx" di Napoli, aveva dato i suoi frutti. Nel corso degli anni Bordiga aveva selezionato attorno a sé un gruppo di compagni ben strutturato, sia sotto l’aspetto ideologico-programmatico sia sotto quello organizzativo. Quadri giovani e maturati nel corso della scontro di classe del 1919-'20 – che avevano vissuto da protagonisti – inseriti in alcune delle categorie fondamentali della classe operaia: metallurgici, edili, ferrovieri, postelegrafonici. A questa struttura si aggiungerà quella dei giovani compagni torinesi dell’Ordine Nuovo, che sebbene meno strutturata di quella cosiddetta astensionista del compagno Bordiga, aveva fin dal primo dopoguerra intrapreso una battaglia, soprattutto ideologica, contro l’eccessivo economicismo e determinismo della direzione serratiana del PSI, ma soprattutto, attraverso il compagno Gramsci, l’inizio della riflessione sui consigli di fabbrica, visti come nuove strutture con cui organizzare la lotta di classe.
Un partito di minoranza sì, ma qualitativamente migliore di quello maggioritario; un partito minoritario sì, ma organizzato su basi leniniste; un partito che come obiettivo si proponeva la conquista della dittatura di classe, il potere operaio.
Ma il PCd'I, come abbiamo visto, iniziava la sua azione politica autonoma in un momento di riflusso dell’ascesa rivoluzionaria. Un partito rivoluzionario può affermare il suo programma solo se incrocia la fase ascendente delle lotte, come aveva dimostrato il partito bolscevico nel corso dell’esperienza russa. Quindi il partito nato per la rivoluzione dovrà affrontare una nuova situazione, caratterizzata e dalla relativa stabilizzazione economica, che garantirà dopo la tempesta rivoluzionaria del primo dopoguerra un periodo di respiro al capitalismo internazionale, e dalla reazione politica che la stessa borghesia, con le sue bande armate, si preparava a scatenare in quasi tutta Europa.
La sezione italiana dell’Internazionale si trovava ad operare in una fase totalmente diversa da quella sperata. Il momento della radicalizzazione delle masse era passato. La fase di relativa e temporanea stabilizzazione esigeva lo sviluppo di una nuova tattica. Quella “dell'offensiva”, elaborata nel corso del primo e del secondo congresso, che aveva visto in molti paesi europei i partiti comunisti battersi per abbattere il dominio della borghesia, si era rivelata infruttuosa, anzi a partire dal 1920 una serie di sconfitte avevano arrestato l’ondata rivoluzionaria, determinando così un cambio di fase, che bisognava affrontare con un adeguamento della tattica.
LO SCONTRO SULL'ADEGUAMENTO DELLA TATTICA ALLA NUOVA FASE
All’interno dell’Internazionale si aprì un acceso dibattito tra chi considerava, temporaneamente, spostata in avanti la prospettiva della rivoluzione in Occidente, e chi al contrario continuava a teorizzare la tattica dell’offensiva, per cui bisognava mettere in campo tutta la forza necessaria per abbattere il capitalismo ovunque fosse possibile ed alleviare così le sofferenze della classe operaia, esportando anche, ove fosse possibile, la rivoluzione “sulla punta delle baionette”.
Il primo orientamento coincideva col punto di vista di Lenin e di Trotsky che, data la nuova fase, ritenevano necessario che i giovani partiti comunisti, vista la “temporanea” stabilizzazione del sistema capitalistico, si sforzassero per lo più di allargare la loro influenza, legandosi alle masse proletarie piuttosto che provare sterili colpi di mano che, oltre ad essere facilmente reprimibili, li avrebbero isolati dalle masse dei lavoratori.
Il secondo era sostenuto soprattutto da Bucharin e da Zinoviev, che credevano fosse compito dei partiti comunisti, oramai liberi dai condizionamenti centristi e riformisti, provare a sollecitare il processo rivoluzionario, anche ricorrendo ad azioni di forza che avrebbero suscitato entusiasmo nelle masse, spingendole alla radicalizzazione.
La posizione di Bucharin e di Zinoviev era condivisa da molti partiti occidentali, che si erano formati proprio sull’idea della crisi generale che, nel dopoguerra, attraversava il capitalismo internazionale, e dell’inevitabilità dell’imminente sbocco rivoluzionario. Per di più il fatto che questi partiti influenzassero solo una parte minoritaria della classe operaia rafforzava ancora di più la loro inclinazione verso la tattica dell’offensiva.
Quando nel giugno del 1921 veniva convocato il terzo congresso dell'Internazionale, nel movimento comunista internazionale si esprimevano due posizioni nettamente contrapposte sulla tattica da applicare nella nuova fase: da una parte i fautori dell’offensiva, che avevano una forte presenza in molti partiti (da quello tedesco a quello italiano, da quello cecoslovacco a quello austriaco); dall’altra parte avevamo la direzione del Partito Bolscevico, tutta ricollocata da Lenin, dopo un duro scontro con Zinoviev e Bucharin, su posizioni che condannavano apertamente la tattica dell’offensiva, contrapponendo a quest’ultima la necessità per i partiti occidentali della conquista della maggioranza attiva della classe operaia.
Per raggiungere questo obiettivo era necessario che tutti i partiti comunisti facessero propria la tattica della “lettera aperta”, elaborata ed applicata dai comunisti tedeschi all’inizio del 1921, con cui si proponeva a tutte le organizzazioni politiche e sindacali della classe operaia (tedesca) iniziative comuni di lotta per difendere e migliorare le condizioni di vita dei lavoratori e per contrastare, unitariamente, la reazione borghese che andava via via organizzandosi con la formazione di gruppi paramilitari.
La discussione congressuale fu particolarmente accesa. Un numeroso gruppo di partiti comunisti, tra cui quello italiano, sollevò una dura opposizione contro la nuova tattica, che veniva interpretata come un’inversione di tendenza che avrebbe annacquato di fronte alla classe operaia la radicalità che esprimevano i nuovi partiti, nati, nella testa dei tanti giovani dirigenti, come stati maggiori che avrebbero dovuto continuamente spingere la classe all’insurrezione per la conquista del potere, e quindi vedevano nella nuova tattica una specie di tradimento verso il programma comunista.
Nel dibattito congressuale questo stato d’animo fu rappresentato soprattutto dall’intervento di Umberto Terracini, che a nome degli oppositori illustrò dalla tribuna congressuale gli emendamenti alle tesi sulla tattica presentate da Radek: «[...] non si deve proclamare che la maggioranza del proletariato deve essere necessariamente organizzata nel partito comunista, perché in tal modo si dà ai riformisti un’arma potente contro di noi. I riformisti hanno sempre sostenuto che non si può cominciare la lotta rivoluzionaria prima che la maggioranza dei proletari sia organizzata nel partito. Si vuole qui applicare al partito comunista un principio democratico. Ma è un principio che si adatta solo ai riformisti, non alle tesi proposte dalla III Internazionale [...] non è affatto necessario per la lotta rivoluzionaria che la maggioranza delle masse lavoratrici sia già organizzata e conquistata dal partito comunista. Importante è solo che i partiti comunisti siano in grado, dal momento della lotta, di trascinarsi dietro le masse» (intervento al terzo congresso, 1 luglio 1921).
Da questo intervento, come da tutto il resto della discussione, si capisce come l’applicazione di questa nuova versione della tattica sia stata particolarmente complicata, complicanza che nasceva inoltre per via dei deliberati congressuali, che ribadivano che i partiti comunisti, nell’ambito dello sviluppo della tattica del fronte unico (come si chiamerà da lì in poi) avrebbero dovuto mantenere intatta la denuncia contro l’atteggiamento conciliante della socialdemocrazia, che grazie alla sua collaborazione aveva permesso alla borghesia di superare la crisi del primo dopoguerra.
Diventava quindi chiaro che l’attuazione della nuova tattica si sarebbe rivelata complicata per i giovani partiti, perché lottare fianco a fianco, criticando i potenziali alleati del momento, era alquanto complicato, e nessuno dei giovani partiti aveva l’esperienza che il Partito Bolscevico aveva acquisito in più di vent’anni di costruzione autonoma e attraverso la prova di tre rivoluzioni.
Le difficoltà che le sezioni occidentali incontravano nel mettere in pratica la nuova tattica continuarono ad animare una forte resistenza da parte di molte direzioni, fra tutte quella italiana, che con gli interventi di Terracini in ambito congressuale era quella che più di tutte faceva resistenza contro l’adeguamento della tattica alla nuova fase.
La direzione del PCd'I riteneva particolarmente importante lo smascheramento dei centristi e dei riformisti di fronte alla classe operaia, per evitare che i lavoratori potessero riacquistare un minimo di fiducia verso le direzioni che li avevano traditi. Inoltre Bordiga e il gruppo dirigente, tutto, pensava che l’avanguardia della classe operaia guidata dai comunisti avrebbe avuto la possibilità di sviluppare lo scontro sociale e aprirsi la strada verso la conquista del potere.
L'ESTREMISMO
Questa posizione imbevuta di estremismo, di cui la direzione della sezione italiana aveva già dato prova sulla questione elettorale, fu aspramente criticata da Lenin, che ricordava alla direzione della sezione italiana che i centristi e i riformisti erano sì da espellere, in quanto nemici dei comunisti, ma una volta espulsi e costruito il partito, il suo compito principale era quello di imparare a preparare la rivoluzione, e non quello di continuare a polemizzare con centristi e riformisti, e soprattutto ricordava che il partito bolscevico era sì piccolo, ma aveva con sé, oltre alla maggioranza attiva della classe operaia industriale, una grossa parte dell’esercito e soprattutto il movimento dei contadini, conquistato non sul programma agrario bolscevico, ma su quello dei Socialisti Rivoluzionari.
Lenin spesso diceva che la vittoria dei bolscevichi è consistita nell’attuare il programma dei Socialisti Rivoluzionari. Quindi senza le masse o senza la loro maggioranza attiva, secondo Lenin, qualsiasi possibilità di successo per la rivoluzione è improponibile, e un partito comunista (che si rispetti) deve trascinare nel processo rivoluzionario non solo la sua parte attiva (iscritti e area d’influenza) ma soprattutto l’enorme massa dei senza partito, di quella parte passiva della classe operaia che entra in lotta solo in particolari momenti e senza la quale la rivoluzione non può trionfare. Quindi per vincere è necessario che il partito, anche piccolo, abbia la capacità di usare metodi adatti per conquistare la maggioranza della classe operaia, perché senza di essa la rivoluzione non è possibile. Non basta sostituire, come riteneva Terracini, la staticità della direzione col suo dinamismo, per accelerare la rivoluzione e farla vincere.
Il problema fondamentale, dopo aver costruito il partito, era quindi quello di conquistare le masse sfruttate e oppresse al progetto rivoluzionario, ed era possibile farlo solo attuando la tattica del fronte unico.
La direzione del PCd'I, sebbene al terzo congresso avesse votato le nuove tesi sulla tattica, nella sua attività quotidiana continuava ad opporre una forte resistenza alla sua applicazione nel campo politico, tanto da indurre più volte l’Esecutivo dell’Internazionale ad intervenire nel suo dibattito interno, fino al punto di arrivare a “censurare” i documenti congressuali, le famose Tesi di Roma del 1922, che riproponevano le stesse posizioni che erano già state, a suo tempo, respinte dal congresso: nessuna collaborazione sul terreno delle lotte col PSI, riproposizione del fronte unico solo sotto l’aspetto sindacale, divergenze sulla parola d’ordine del governo operaio.
Quello che il giovane gruppo dirigente del PCd'I non riusciva ancora a comprendere era che, superata la fase della formazione del partito sulle basi del marxismo rivoluzionario – e tali erano quelle del partito nato a Livorno, grazie soprattutto all’opera del compagno Bordiga – la lotta che era necessario sviluppare non era più solamente quella della denuncia davanti alla classe delle malefatte e dei tradimenti dei centristi e dei riformisti, ma quella di conquistare all’influenza del partito comunista la maggioranza degli operai organizzati nelle varie strutture politiche e sindacali, per la realizzazione di obiettivi comuni nella lotta per il miglioramento delle condizioni di vita e contro le scorribande dei fascisti, per provare così ad arrestare il profondo sconforto che in quei mesi stava vivendo la classe operaia, sottoposta all’azione violenta della reazione borghese.
La tattica del fronte unico era esclusivamente lo strumento che avrebbe dovuto sottrarre le masse proletarie italiane all’influenza dei centristi e dei riformisti, e contemporaneamente allargare quella comunista, senza metterne in discussione l’oramai acquisita autonomia.
Nessuno nel gruppo dirigente dell’Internazionale ha mai pensato che la nuova tattica dovesse mirare ad una ricomposizione con le vecchie organizzazioni socialiste, e, per evidenziarlo, si raccomandava ai partiti che la attuavano di mantenere intatta la vis polemica contro tutte le organizzazioni politiche e sindacali che partecipavano alle lotte con posizioni diverse da quelle del partito comunista.
UN POSSIBILE MOTIVO DELL'ESTREMISMO
Data questa premessa, è difficile comprendere come mai la direzione del partito italiano sia stata così fortemente contraria alla nuova tattica. La motivazione va forse ricercata e nella natura stessa delle organizzazioni italiane a cui veniva proposta, nelle caratteristiche dei gruppi dirigenti di queste organizzazioni, e infine, ma non ultimo, nella situazione venutasi a creare con la controffensiva reazionaria del capitalismo italiano.
È cosa risaputa che il movimento socialista italiano, fin dal suo nascere, esclusa la figura di Antonio Labriola, era stato guidato da dirigenti che non si erano formati sulla base del materialismo storico e dialettico, ma erano per lo più seguaci delle teorie positivistico-evoluzioniste, tipiche della fine del diciannovesimo secolo, che avevano fatto breccia in molti settori della socialdemocrazia internazionale. Il partito italiano era stato uno di quelli più influenzati dalle teorie revisioniste, e l’azione politica dei suoi massimi dirigenti, da Turati a Treves a Mondolfo, aveva evidenziato compiutamente le caratteristiche del socialismo “nostrano”, che più avanti sarà attraversato dall’ubriacatura mussoliniana, fino ad arrivare ai Lazzari e ai Serrati quali esponenti di punta del socialismo nazionale artefici, con le loro politiche, delle sconfitte del Biennio rosso.
Era con questi dirigenti che bisognava interloquire per realizzare la nuova tattica.
Tutta l’esperienza storica del socialismo nostrano dell’anteguerra e del primo dopoguerra dimostra in maniera inconfutabile che sicuramente i vari Turati, Treves, Serrati, Lazzari non sono stati dei buoni maestri per i futuri quadri del PCd'I, e da ciò si può anche comprendere, ma non del tutto giustificare, l’estremismo che fin dalla sua fondazione ha accompagnato la sezione italiana dell’Internazionale.
È un fatto storico accertato che l’acquisizione del marxismo e la sua applicazione nella quotidianità della lotta di classe richiede grande esperienza politica, che si acquisisce attraverso un duro e lungo lavoro, per lo più controcorrente, a contatto con la classe. Ma quale altro partito, al di là di quello bolscevico, passato attraverso periodi di feroce repressione durante lo zarismo e protagonista principale di ben tre rivoluzioni, poteva dire di avere l’esperienza necessaria per dirigere la classe alla presa del potere e all’esercizio della dittatura?
La nuova tattica proposta dal gruppo dirigente di quel partito, quello bolscevico, che più di ogni altro nel fuoco della lotta di classe aveva avuto la possibilità di sperimentarla, cercava di far capire ai giovani dirigenti del Partito Comunista d’Italia che qualsiasi processo rivoluzionario per vincere ha bisogno di mobilitare le masse, e che queste ultime non vivono in una specie di Iperuranio a contemplare lo spirito assoluto, ma sono collocate in organismi di riferimento politici e sindacali di vario tipo, ed è lì che è necessario indirizzare l’azione per conquistarle. In Italia nel partito socialista e nella CGL militavano centinaia di migliaia di operai; era verso di loro che si doveva indirizzare l’azione politica del partito comunista, partendo non dalla superiorità programmatica del comunismo, ma dall’elaborazione di una piattaforma di rivendicazioni materiali, dal salario alla riduzione delle ore di lavoro, dal controllo sui prezzi all’autodifesa contro i fascisti, che dimostrasse l’incapacità delle organizzazioni tradizionali di essere in grado di lottare per il soddisfacimento dei bisogni materiali e di aprire quindi un cuneo tra la base operaia e le sue vecchie direzioni, allargando e rafforzando così l’influenza del partito.
Pertanto il fronte unico doveva servire al giovane partito come strumento per staccare le masse operaie al controllo riformista e contemporaneamente allargare la propria area d’influenza, senza mettere minimamente in discussione il patrimonio storico acquisito nel corso dei suoi primi anni di vita. E anche quando l’Internazionale approvò una risoluzione che invitava il PSI ad espellere dal suo seno i turatiani e i centristi, per arrivare a una ricomposizione col PCd'I e formare così una sezione unica in Italia dell’Internazionale Comunista, l’obiettivo era esclusivamente quello di conquistare al partito comunista le masse che seguivano il PSI, senza fare la benché minima concessione sotto l’aspetto teorico e programmatico. Come si sa, la fusione non andò a buon fine, ma se si fosse realizzata, il ruolo del PCd'I ne sarebbe uscito sicuramente rafforzato, perché, a differenza di quanto pensava la sua direzione, Livorno aveva segnato definitivamente l’inizio di un nuovo stadio nella storia del movimento operaio italiano, quello della conquista da parte del nuovo partito dell’avanguardia della classe operaia su posizioni effettivamente marxiste e rivoluzionarie. Perché tale era il partito che si apprestava all’opera, ma per conquistarla era necessario apprestarsi alla nuova fase, segnata dall’offensiva del capitalismo italiano, con una grande capacità tattica che il giovane partito ancora non aveva e faceva resistenza ad accettare, quella che il partito internazionale aveva deliberato con il suo terzo congresso, cioè quella del fronte unico.