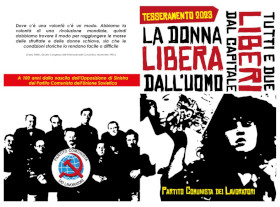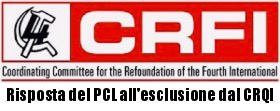Prima pagina
...e invece io divento trotskista
Ricordi di un marxista rivoluzionario
6 Aprile 2021
L'Unità, luglio 1966
Pubblichiamo questi ricordi di Silvio Paolicchi, raccolti a Milano nel 2002, già apparsi sul numero 29 dei Quaderni del Centro di Iniziativa Politica e Culturale di Cuneo con il titolo "Com'era bella la mia Quarta". In essi il compagno Paolicchi rivive le esperienze politiche e personali della sua vita di militante comunista, dall'infanzia durante il fascismo ai ricordi di adolescente sulla Spagna, alla guerra, la Liberazione, il PCI, gli scontri con Togliatti, Amendola e i secchiani, la battaglia nel partito, l'adesione alla Quarta Internazionale, fino alle vicende a cavallo del 1968-1969. Le sue condizioni di salute non consentirono purtroppo la continuazione dell'intervista, che avrebbe dovuto approfondire altri temi e periodi successivi. Ringraziamo il compagno Sergio Dalmasso per averci gentilmente concesso di riproporli sul nostro sito.
LA GIOVENTÙ, LA GUERRA
Sono nato a Pisa nel 1921. La mia è una famiglia di mezzadri, anzi sono due famiglie di mezzadri, entrate in crisi per ragioni produttive (vino, grano...). Mio padre nella prima guerra mondiale è militare, quindi è prima bracciante agricolo, poi impiegato alle imposte di consumo fino al 1932 quando viene licenziato. È un dramma. Io voglio andare a scuola. Mia madre tenta di guadagnare il più possibile, lavorando come operaia tessile in una fabbrica di Pisa.
I miei non hanno alcuna militanza o idea politica. Si può dire che non siano fascisti. Mio padre è un debole, ma un uomo libero. Poi ha un cedimento politico e si iscrive al fascio, come ex combattente. Non me lo ha mai detto, ma io l’ho sempre sospettato. Così ritrova lavoro.
Frequento l’Istituto magistrale e mi diplomo nel 1939, prima che scoppi la guerra. Trovo, quindi, lavoro ai contributi unificati in agricoltura. Sono impiegato avventizio; mi danno cinque lire a nome.
Quando scoppia la guerra, nel 1940, non finisco su nessun fronte. Sono tra quelli che fanno, apparentemente, rinuncia all’esonero come studente. Avevano mandato una cartolina agli studenti universitari, in cui esaltavano questa rinuncia. Così partono prima quelli della classe 1921, poi del 1920, poi i laureati.
Io mi trovo ad essere allievo ufficiale, ho una fortuna indecente perché finisco a Sanremo dove arrivo nel gennaio 1941, quando la guerra contro la Francia è finita e non c’è più alcun pericolo.
Sono allievo sergente in Fanteria. La fortuna indecente continua perché vengo inviato alla scuola di Arezzo, mentre altri partivano per altre scuole di allievi ufficiali. Non parto, quindi, per la campagna di Russia, il che ha significato salvarmi, perché là sono morti in molti, molti sono rimasti là, alpini che ho visto partire da Rivoli, gente che mi era vicina, allievi ufficiali, sottotenenti.
Sono così allievo ufficiale e cerco di stare lontano dalla guerra, facendo domanda per la Valle d’Aosta. Vengo trasferito, invece, a Rivoli. Avevo chiesto di fare la Guardia di frontiera perché era uno dei modi per stare lontani dai “punti difficili” e invece mi mandano a Rivoli come insegnante agli allievi ufficiali, cioè a quelli che erano arrivati dopo di me, anche se alcuni erano più vecchi.
Lì ho iniziato a prendere in giro i maestri di scuola. Quando qualcuno diceva una bischerata grossa, gli chiedevo: «sei un maestro?». Finché dopo un paio di mesi si accorgono che ero maestro anch'io e allora devo fare un po' di autocritica.
Poi passo da Rivoli a Susa, poi sul Moncenisio. Finché, il 25 luglio 1943, Mussolini se ne va.
Il periodo che corre tra il 25 luglio e l'8 settembre 1943 è decisivo per molti: chi è avvilito e umiliato, chi coraggioso, chi vuol continuare la guerra ad ogni costo, chi cerca un’alternativa. Madonna! Che mondo è stato quello dal 25 luglio all’8 settembre!
COMUNISTA, PARTIGIANO, IL CARCERE. IGNAZIO VIAN
Io sono incerto sulla prospettiva per una ventina di giorni. Rimango a Rivoli, poi sono a Bussoleno. In questa zona si può parlare con i soldati. Molti vogliono andare a casa, ma non sanno come fare. Finché mi decido e vado in bicicletta a Pisa. Da Susa a Pisa, in tre giorni, con tre tappe. Non ho certo una bici da corsa. Quando arrivo a Pisa, faccio sangue dalle chiappe.
È un fatto molto importante, decisivo per la mia vita. Arrivo a Pisa e scopro la distruzione della città, per il bombardamento avvenuto in agosto. Ma soprattutto incontro gli operai, che avevo lasciato bambini, compagni di scuola. Ne avevo avuto notizie da lontano: uno era rimasto ferito, l’altro era morto in Africa... Mi trovo all’interno di una discussione che coinvolge operai, studenti...
Inizio subito a lavorare per il PCI. Ormai ho fatto una scelta.
Negli anni precedenti avevo ascoltato. Da studente avevo subito l’influenza da una parte della propaganda fascista, dall’altra di quella anarchica. Queste erano state le due componenti della mia formazione all’età di sedici-diciassette anni. Il fatto più importante era stata la guerra di Spagna, iniziata quando avevo quindici anni. Fino alla terza-quarta superiore sono stato profondamente legato all'ambiente anarchico, mentre l’influenza della propaganda fascista influiva attraverso i giornali ufficiali. Non riuscivo a capire le critiche al governo spagnolo. I giornali, i preti...
Durante il servizio militare scopro altri filoni politici, il movimento operaio. A Rivoli avevo incontrato dei comunisti. Operai. Ero sottotenente e li avevo incontrati dopo averli cercati. Attraverso loro, avevo stabilito rapporti con i comunisti, di Collegno, Torino, della cintura operaia.
A Rivoli ero arrivato come ufficiale dell’esercito regio e ne sono uscito come Capo di stato maggiore della Terza Divisione Garibaldi, comandata da un artigiano meridionale, Ugelle, arrivato in Italia da Marsiglia. Non sono stato un grande comandante partigiano.
A Pisa dal PCI ho il primo incarico ufficiale. Ma commetto degli errori. In un bar partecipo ad una discussione pubblica e appaio chiaramente come uno che difende posizioni comuniste. Questo fatto mette in guardia i compagni di Pisa che mi chiedono di allontanarmi e di andare nei monti grossetani. Io, invece, decido di ripartire per il Piemonte. Parto il 25 settembre 1943.
Torno a Rivoli e prendo contatto con due operai che già avevo conosciuto. Ho due appuntamenti con loro. Si discute del tema centrale: se si dovesse aspettare, andare in città o in montagna. Su questo c’era un dibattito intenso di cui si trova traccia persino negli ambienti ufficiali del PCI, nelle lettere di Amendola. Uno degli episodi di questo dibattito è la discussione sulla famiglia Cervi. Ne esistono ancora documenti che si possono trovare a Roma o a Reggio Emilia. Ma ve ne sono molti altri; di alcuni ho avuto notizia solo molti anni dopo. Manca una direzione, non c’è guida.
In queste discussioni si sente, però, che inizia a manifestarsi una direzione: quella dei quadri del PCI usciti dal carcere (tra il 25 luglio e l'8 settembre erano riusciti a tirarne fuori qualche migliaio).
Per questo, in poco tempo, il PCI assicura una direzione di tre, quattro, cinque, sei quadri per ogni provincia, avendoli tirati fuori dalle varie prigioni o dal confino.
Mi sposto da Rivoli ad Arnese, dove mi rapporto con le organizzazioni che si stanno rimettendo insieme. Ho incontri in collina, sopra ad Avigliana. Ho il dubbio che il padre dell’attuale segretario dei DS, Fassino, fosse uno degli organizzatori e dei combattenti, ma non ne sono sicuro.
Costituiamo una brigata, la diciassettesima. La prima azione ha una grande importanza nella mia vita. È un’azione notturna per rifornirci di viveri. Si parte da sopra... al comando di uno dei due fratelli Kovacic. Uno, il minore, è morto durante la Resistenza, in uno scontro armato, il maggiore, in seguito, di tumore. Ho saputo della sua morte dalla Stampa.
Obiettivo dell’azione è prelevare farina. Ci sono cose strane, per esempio io sono disarmato. «Non posso venire senza armi», dico a Kovacic. «Te le presto io», risponde. Così vado a prelevare grano a Brugherio (?), alle porte di Torino, armato solamente di una pistola. Quest’atteggiamento verso di me Kovacic ha tenuto anche nei confronti di altri. Era uno che dava l’esempio.
La seconda azione è al seminario di Rivoletto, occupato da una divisione delle SS. Lo attacchiamo senza risultato rilevante.
I tedeschi organizzano una controffensiva che dura, con vari rastrellamenti, per tutto il mese di giugno. Cado sotto i colpi di una mitragliatrice, ferito alla testa, alla spalla e alla mano destra. Siamo a fine giugno, primi di luglio. Accade qualcosa di avventuroso. Mi dicono che sarò interrogato e fucilato. È una giornata terribile. I torturatori mi danno calci e mi dicono che sono finito. Ci sono due alti ufficiali tedeschi. L'interprete è un altro tedesco, allievo ufficiale medico.
Mi interrogano fino alle undici di sera. Dopo le undici inizio ad avere l’atteggiamento di chi vuol chiudere la partita. Mi pare finito tutto. «Va beh, allora? Perché mi fate aspettare?».
Arrivata la mezzanotte, questo allievo ufficiale medico che parla italiano, mi dice (sembra incredibile): «Stia calmo, stia calmo. Passerà dalle mani dell'esercito a quelle della Gestapo e sarà processato». Non rispondo una parola. Così accade.
In carcere vengo processato. Dopo due mesi vengo trasferito in Germania, in un campo di lavoro.
In questo lasso di tempo, incontro Ignazio Vian. Lo portano in cella, ferito, il 2 luglio. Ha un vestito beige, un bel vestito. Scopro che si era tagliato le vene. Aveva creduto di tagliarsi le arterie, invece si era tagliato le vene. Il medico del carcere gli aveva fatto una trasfusione, salvandogli la vita. Rimango con lui in cella, fin dopo l’attentato a Hitler, il 26-27 luglio del 1944.
Sappiamo dell’attentato a Hitler quasi subito, attraverso una sorta particolare di alfabeto Morse, attraverso i muri. Lui è convinto che io me la caverò. Tutte le volte che il discorso cade sul fatto che vivremo ancora un giorno, due giorni, forse una settimana, lui mi dice: «No, tu te la caverai». Si basa su quanto gli ho raccontato del mio processo. Per venticinque giorni cerca di convincermi. Mi dà l’indirizzo della madre. Io andrò da lei solamente due anni dopo, per raccontarle tutti i miei ricordi di questa vita in comune, durata un mese.
Vian discute con me. È monarchico, cattolico, difende le sue idee, mi aiuta a difendere le mie. Qualche volta mi modifica la domanda, la questione, il problema. Sulla guerra partigiana io sono scettico sulla prospettiva. Vedo il rischio di perdere tanti compagni per i rapporti di forza e anche per i tradimenti dei militari. Vian sostiene che la scelta è giusta, che il sacrificio è giustificato.
Giochiamo a dama e a scacchi. Lui è forte a dama, imparata da bambino.
Questo sino alla sua impiccagione, a fine luglio.
Quando andrò dalla madre, però, avrò dimenticato molte cose. Mi turberanno particolari che “non tornavano”. Ad esempio non mi torneranno i discorsi su una fidanzata, sui gradi, sul corpo degli alpini di cui faceva parte. All’incontro parteciperanno anche alcune donne.
Così avrò una reazione emotiva che mi porterà a dimenticare tutto, tranne quanto riguardava sua madre. Ma anche di questa avrei dimenticato l’indirizzo subito dopo, il mese dopo. Un indirizzo che avevo tenuto a mente per due anni.
Vengo mandato a lavorare ad Hannover. Siamo nella soffitta di un palazzo, ad Hammer Strasse. Produciamo motori. Resto li dall’agosto 1944 al maggio 1945, quando finisce la guerra. Alcuni che lavorano con me muoiono per i bombardamenti al fosforo, altri per il tabacco; fumano tutti molto. Sono riuscito a far smettere di fumare almeno quattro o cinque, a convincerli a non scambiare più il pane con le sigarette.
Io sono conciato male: lavoro in un bunker con un martello pneumatico; ancora due o tre giorni e non ce l’avrei più fatta. Nel campo, dove ci sono molti soldati italiani, molti se la cavano perché vanno a lavorare fuori, presso i contadini. In aprile, a Belsen, pochi chilometri fuori Hannover, incontro molte donne con il tifo, senza mestruazioni. Le giornate successive all’apertura dei campi sono terribili.
Inizio ad organizzare il rimpatrio degli italiani. Apro un ufficio ad Hannover ed inizio ad occuparmi del rientro in Italia dei prigionieri civili e militari. E mi impegolo in modo tale che a maggio sono ancora lì e così a giugno e a luglio... Torno a Pisa solo ad ottobre, in modo buffo.
Decido di tornare con un prete piemontese. Facciamo un accordo con un rappresentante del Vaticano che ci dà quattro targhe di automobili. Ho quindi tutti questi mezzi per rimpatriare italiani dalla Germania. Si attraversa tutta la Germania liberata. Quando si arriva a Verona: «Voi non passate. Dove avete preso le automobili? Queste servono a noi. Dobbiamo fare una cooperativa partigiana».
Così si prendono le automobili e devo continuare in treno, da Verona a Pisa. In tutto, per il viaggio, attraverso Norimberga, ho impiegato cinque giorni.
PISA, LA LOTTA POLITICA, IL PARTITO
A Pisa ritrovo i miei parenti che erano sfollati sui monti. Nel PCI ho immediatamente incarichi: prima responsabile dei giovani, poi del lavoro di massa. Nel 1948 divento responsabile della federazione. In quegli anni ero stalinista, sempre da sinistra.
Conduco la battaglia per le elezioni del 1948. Ci sono trionfalismi, baggianate. Mi limito a scherzare, a fare battute su questa illusione di vincere le elezioni. Entro in una fase critica. Sono considerato “poco in linea”. D'Onofrio mi considera un mezzo titoista. Dinucci dice: «Paolicchi ha troppe donne. Da una parte vuol fare il segretario della federazione, dall'altra va in giro alle manifestazioni più critiche nei nostri confronti». In effetti divento, gradualmente, sempre più critico. Per cui sto per anni con un piede nell’apparato del PCI e con un piede fuori. È un mestiere difficile.
Per citare un episodio, negli anni ’50 torno da un “giro politico” in Calabria e in Basilicata. Al quarto piano delle Botteghe Oscure incontro Giorgio Amendola, circondato da tutti i suoi “governatori”. Mi dice: «Sentiamo, sentiamo, che cosa hai trovato in Lucania». E crea una suspense, come sa fare quando vuol tenere l’attenzione. Gli rispondo «Tutti in fila dietro...» e dico il nome di un deputato liberale che era stato eletto nel PCI su pressione di Amendola. Siccome io non avevo partecipato a questa discussione, lui si incazza, diventa una belva, e me ne dice di tutti i colori, tanto che dopo due o tre giorni la Segreteria mi manda a chiamare e mi domanda se mi è sufficiente che Amendola mi chieda scusa. Rispondo che è sufficiente qualunque cosa. Però non era animoso, nei rapporti personali aveva un atteggiamento liberalizzante.
Il mio dissenso nel PCI si manifesta su singole questioni, politiche ed organizzative, ma non investe la strategia complessiva del partito. La questione più grossa è quella del 1956. Partecipo a quella discussione con gli intellettuali che sostenevano i moti ungheresi, ma con un atteggiamento meno radicale, più di partito. Escono dal PCI numerosi intellettuali. A Pisa soltanto due o tre. In Toscana Diaz che aveva già manifestato una tendenza radicale, da radicale classico, e sarebbe stato subito solidale con Antonio Giolitti.
Il caso Diaz è oggetto di discussione fra me e Togliatti. Siamo a pranzo, Togliatti ed io con altri. Sostengo che Diaz ne ha già dette troppe e mi sono sempre meravigliato che gli siano stati pubblicati tanti articoli. Agli occhi di Togliatti appaio come un dirigente pericoloso perché in quel momento ha bisogno di solidarietà e non di dirigenti che approfittino delle sue difficoltà. Tanto che reagisce dicendo: «Tu parli così perché non hai letto quello che non gli ho pubblicato».
IL DISSENSO
In questi anni nasce il mio dissenso sui fatti di Polonia, d'Ungheria, sull’URSS. I primi dubbi sul socialismo dell’Est erano nati già precedentemente, sul piano culturale, contro le posizioni di Sereni che sosteneva la linea politica dell’URSS, nei suoi articoli su Critica Marxista e in testi in cui difendeva lo stalinismo.
Dissento dalle posizioni culturali che vengono dall’URSS. Mi sento vicino alle posizioni degli intellettuali critici (Giolitti, il manifesto degli intellettuali romani...); mi distinguo, però, perché loro hanno la tendenza a rompere con il partito, tendenza che si manifesta immediatamente, mentre in me apparirà più tardi. Alcuni di loro, in particolare Reale, hanno posizioni confuse, anticomuniste. Sono segretario della federazione pisana per dieci anni. Nel 1953 si pone l’ipotesi di una mia candidatura alla Camera. Il Comitato Federale mi designa come candidato, ma D'Onofrio, e quindi altri, dicono che per candidarmi debbo lasciare la segreteria. Io rifiuto, forse anche sbagliando, perché voglio mantenere la segreteria. Sono un ragazzino, ho 32 anni. Scopro, poi, che quella non è una posizione ufficiale, tanto che uno della mia età, amico carissimo di Amendola e Napolitano, viene eletto parlamentare a Napoli.
A Pisa viene eletto il parlamentare che designo io. Ho forza sufficiente per farlo. Ne “faccio eleggere” addirittura tre: Raffaelli, un candidato di Carrara e un mezzadro.
L'atteggiamento di D’Onofrio è sufficiente a creare una tendenza di opposizione su questioni politiche generali: una tendenza contraria a quello che facevo io, non all’azione del partito. Per esempio, sulla questione di Tito, lui criticava il fatto che io rifiutassi di tenere comizi contro Tito, dicendo che era fascista. Una cosa ridicola.
In Toscana era allora segretario regionale Vittorio Baldini. Era “secchiano” e si circondava di funzionari che la pensavano come lui. Non perché fossero “più a sinistra”, ma perché erano più obbedienti, cosa che ha creato confusione per un po’ di anni. Alcuni si consideravano a sinistra, ma erano semplicemente antidemocratici, avversi alla vita democratica nel partito. Si manifestavano contraddizioni. Amendola appariva il più democratico, ma in realtà era il “più destro”.
Questo cambiamento all’interno del partito è largamente avvertito dagli iscritti, che non sanno però assumersi una responsabilità propria, nel cambiamento e per il cambiamento; sono disposti a seguire l’uno o l’altro dirigente.
Ad esempio, la prima volta che a Roma metto piede al quarto piano delle Botteghe Oscure incontro un bravo compagno, Colombino, che si era sempre comportato benissimo, aveva dato al partito l’eredità ricevuta e questi mi dice: «Sono uno svoltista».
Rimango segretario della federazione di Pisa sino al congresso del 1960. Sono io a scegliere di smettere e di fare, dopo oltre un decennio, un’esperienza nuova. Diviene segretario uno che non conta nulla, un sardo. Io vado a Roma, dove sono assistente di Enrico Berlinguer all’ufficio organizzazione, dove aveva sostituito Amendola. Non riesco a capire se gli vado bene o no.
A Pisa sono sposato. Ho un figlio che poi perderò: la batosta più grande della mia vita. Nel 1960 a Roma conosco Adriana.
Un giorno Berlinguer mi chiede se vorrei fare il segretario in Toscana. Gli rispondo che non mi va, ma che sono disposto ad accettare, se è necessario. Siamo nei primi anni '60. Sono un po’ incerto: so che i fiorentini sono contrari, ma non ho notizie delle altre federazioni. In realtà c’è opposizione a questa ipotesi di vecchi e nuovi, di innovatori e di secchiani. Gli uni e gli altri si oppongono alla mia nomina. E Berlinguer si comporta da signore. Non se ne lava le mani, però non si impegna. È un liberale, in questo senso.
La proposta di Berlinguer non viene accettata e quindi la mano passa ad Amendola il quale mi fa diventare presidente della Lega delle Cooperative. Sono nominato a questa carica senza aver fatto alcuna battaglia. Il precedente presidente, dal 1953-54 era stato Cerreti, uno allevato nelle cooperative, ma aveva rovinato tutto e quindi, al congresso, si erano liberati di lui.
È il periodo in cui agli occhi di molti sono riformista perché presidente della Lega. È invece il momento in cui divento trotskista.
Nella scoperta di Trotskij un aiuto mi viene da Giorgio Galli, il primo che affronta la storia del PCI. Il suo libro è del 1958, ha una impostazione bordighista, però io che bordighista non sono mai stato ne ricavo moltissimo. Poi leggo La rivoluzione tradita e cerco di farla leggere ad Adriana.
Prendo contatti. Incappo in disavventure. La prima è quella di considerare organizzazione un gruppo di cento sconosciuti. L'altra è quella di accettare, pur non essendo d’accordo, l’entrismo. Non sono d’accordo perché non riesco ad accettare che, in quelle condizioni, si possano tenere nascoste le proprie scelte.
Come presidente della Lega delle Cooperative vado in URSS, in Polonia, in Romania, in Jugoslavia, ma pesa in me la lettura della Rivoluzione tradita, un testo fondamentale edito dalla casa editrice di Schwarz che era diventato trotskista in Egitto. E pesano altri testi ancora. Quindi, quel mascalzone, insegnante di russo a Venezia, fa una scelta importante: pubblica tutte le opere letterarie di Trotskij, nelle edizioni Einaudi. Esistono altre edizioni in francese, inglese, spagnolo. È un momento positivo per l’influenza del pensiero trotskista, soprattutto sui giovani.
LA ROTTURA, MILANO, COMUNISTA RIVOLUZIONARIO
Nel 1966 decido di rompere con il partito e trovo lavoro a Firenze alla casa editrice Sansoni. È una scelta politica. Alcuni insistono perché io continui ad essere funzionario, ma non è più possibile. La mia posizione è conosciuta, all’interno del PCI, quando io, presidente della Lega, inizio a passare libri ai miei collaboratori. Fra questi, molti sono onesti, ma molti non lo sono e vanno a denunciarmi agli uffici preposti alla disciplina. Lascio, quindi, il funzionariato, anche perché poco convinto della scelta entrista, per la quale avrei dovuto tener nascoste le mie idee. Invece, io non le nascondevo mai. Coloro che non le hanno tenute nascoste sono quelli che hanno reclutato di più. Ad esempio Samonà che, giornalista all'Unità ha iniziato a parlare apertamente, come trotskista, come leninista, e ha fatto a Roma un sacco di reclutati. Così Mario Mineo a Palermo. In quel periodo, in Francia, Krivine rompe con il PCF.
Nel partito, nessuno vuole discutere con me sulle mie posizioni. Sono critico sul Vietnam dove si sta operando una guerra distruttiva, sull’URSS, sui paesi dell’Est, sul XXII congresso del PCUS. Nel Comitato Centrale nessuno difende le mie posizioni.
Nel dibattito congressuale per l'XI congresso del PCI, la battaglia di sinistra viene condotta con argomenti non di sinistra. Vado a parlare con Ingrao per sentire quali intenzioni ha, se vuole organizzare una tendenza nei circoli per condurre una battaglia di sinistra, oppure lasciare le cose come stanno. Mi dice: «Tu la pensi così, ma vi sono altri compagni che la pensano diversamente». È la frase che, in queste situazioni, usano tutti, anche di altre matrici culturali e politiche.
L’alluvione del novembre 1966 mi costringe a lasciare la Sansoni. Tramite conoscenze di chi ha lavorato con me a Firenze, vengo assunto alla Mondadori, dove sono assistente del direttore delle vendite. Un destro... Cerco di imparare un nuovo mestiere.
Nel 1966 vengo invitato a presentarmi alla Commissione di Controllo e vengo espulso per non aver raccontato la mia posizione trotskista.
Scrivo relazioni. Bandiera rossa ne pubblica una sulla situazione politica. Mi firmo Puntoni e, per anni, qualcuno mi conosce con questo nome. Quando, nel 1969, Magri a Milano presenta Il Manifesto e io intervengo subito dopo di lui, qualcuno nella sala mi saluta così.
Quando arrivo a Milano, esiste una struttura della Quarta Internazionale. Ma per la Quarta la crisi più grossa è data dal maoismo. C’è un movimento degli studenti che non ha precedenti e sull’onda di questo si viene travolti. Iniziano le defezioni. Nel luglio del ’68 se ne va Brandirali. Parte con tutti i suoi per un seminario sul Lago Maggiore, o di Garda, non ricordo, e ritorna gridando «Viva Mao!». Tutti invasati. In un mese e mezzo. È terribile. C’è una forza esterna a loro, devastante.
L'ultimo colpo arriva da Luigi Vinci e Massimo Gorla che distruggono tutto. Gorla è il più autorevole. È membro della segreteria internazionale, con Krivine, Maitan, Mandel. Rimango solo. Se ne vanno anche coloro che avevo portato a resistere allo scioglimento.
Siamo nel 1968. Alla fine dell’anno sono solo. E mi arriva una lettera di uno studente del Volta, di diciassette anni, Gigi Malabarba, che mi contatta attraverso la sede nazionale di Roma.
Ha una teoria strana che conosco già, ma che è difficile combattere: la cultura proletaria consisterebbe nel raccogliere prodotti proletari e valorizzarli. Così raccoglie poesie, racconti, scritti da operai e li stampa con un altro studente del Volta, Rossi, con cui ha fondato le Edizioni Malabarba. Tento di non farlo perseverare su queste scelte.
Poi Elia Eskenazi: le ultime notizie che ho di lui vengono dagli Stati Uniti.
Il tentativo quotidiano è quello di inserirsi in qualsiasi gruppo, di provocare la discussione.
Vinci fa così. Mi propone anche di fondare il Comitato di base, il CUB, alla Mondadori. Aveva lasciato la Quarta portandosi dietro la parte operaia dell’organizzazione, lavoratori della Pirelli, Cipriani. Continuiamo a discutere. La sua parola d’ordine è: andare alle masse. E questo significa andare alle masse staliniste, maoiste. Lui pensa di poterle orientare e dirigere. Ma io perché devo diventare favorevole al maoismo?
C'è un'influenza maoista sulla sinistra, già nel 1967. Le prime cose che leggo di Natoli sono maoiste. E anche Rossana Rossanda, la fanciulla dai capelli bianchi del Manifesto, dov’è se non nella linea del maoismo?
Contemporaneamente al maoismo, quindi al settarismo, emergono posizioni liberaleggianti. Nel 1975, quando la borghesia militare andrà al potere in Portogallo, lei partirà per andare a leccare gli stivali ai capitani. Solamente uno di questi avrà una posizione più avanzata, Otelo de Carvalho; Oggi è libero o è in carcere? Credo che sia libero.
Alcuni tendono ad avvicinarsi a Lotta Continua. La parte della Quarta più influenzata da Torino, ad esempio Moscato, la penserà così. Il Manifesto si avvicina a Potere Operaio. C’è una specie di congresso che sì svolge a Milano, nel tendone del circo Medini. Insisto per due ore per convincere Magri a non fondersi.
Io, invece, cerco di ricostruire a Milano la Quarta. Due compagni, tre compagni alla volta. In un primo tempo, teniamo le riunioni in una soffitta di proprietà di Rossi, poi a casa mia; poi troviamo una sede, vicino a corso Buenos Aires.