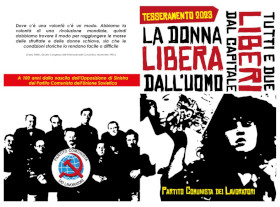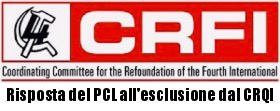Prima pagina
La rabbia e la paura: classe e sindacato nella pandemia
5 Maggio 2020
Dal sito dell'area Riconquistiamo tutto - il sindacato un’altra cosa
Quando finirà l’emergenza sanitaria sarà necessario, e doveroso, ricostruire la dinamica che ha condotto il covid19 a colpire così duramente l’Italia. Denunciando le relative responsabilità, con intransigenza, a partire da quelle politiche e padronali. In questi mesi, comunque, sono emersi evidenti limiti istituzionali e palesi incapacità. L’organizzazione regionalista dello Stato, a partire da quella del Servizio Sanitario Nazionale, ha reso contraddittoria e talvolta inefficace l’azione di contenimento (come mostrato da un primo rapporto dell’Harvard Business School). Nonostante ci sia un Piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (risalente a ben il 2006, che tra le altre cose prevedeva la verifica della disponibilità dei DPI sin dalla notizia della trasmissione da uomo a uomo del nuovo virus, cioè dal dicembre 2019), le sue indicazioni non sono state seguite (a partire proprio dai DPI e la loro distribuzione al personale sanitario). Nelle prime cruciali settimane di diffusione del virus nel paese si è dispiegata una linea contraddittoria di limitazioni parziali e riaperture, con una surreale retorica della ripartenza nella prima settimana di marzo ("Bergamo is running"). Nonostante l’esplicita indicazione dell’Istituto Superiore di Sanità, si è evitato di chiudere alcune aree (vedi la Val Seriana), per compiacere le pressanti richieste confindustriali. Le comunicazioni al paese sono ripetutamente avvenute in modo cialtronesco, con anticipazioni o videomessaggi prima che i provvedimenti fossero definiti (non solo ai primi di marzo, ma ancora con il DPCM del 26 aprile che traccia i primi passi del processo di riapertura): il contrario cioè di quella comunicazione semplice, inequivocabile e precisa, indicata nella letteratura scientifica come indispensabile nel caso di rischi ambientali che coinvolgono la popolazione.
Proprio questa gestione confusa, contraddittoria e anche criminale ha attivato una grande richiesta di iniziativa. Le organizzazioni sindacali sono diventate un punto di riferimento. In prima fila, ovviamente, ci sono stati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le RSU, le RSA: quel tessuto diffuso di attivisti e delegati che caratterizza la dimensione di massa del sindacalismo italiano. Una reazione sospinta dalle scelte di moltissimi datori di lavoro, larga parte delle imprese private come molte amministrazioni pubbliche (le cui direzioni sono oramai impregnate da logiche aziendalistiche). A lungo si è infatti preteso di tener aperto la produzione o le sedi, come se nulla fosse o con minime precauzioni, talvolta anche contro ogni logica. Ai sindacati, ai delegati ed alle delegate, ci si è quindi rivolti in tutti i posti di lavoro ed in tutti i territori. Non solo nelle realtà sindacalizzate, ma anche dove sinora il sindacato era distante, talvolta estraneo e talvolta tenuto a distanza (nelle realtà che io pratico, dalla docenza universitaria alle scuole private, dai tanti lavoratori e lavoratrici degli appalti alle tante forme precarie della didattica e della ricerca). Una domanda urgente e molteplice: si voleva capire cosa stesse succedendo, quale fosse il rischio reale, come proteggere la salute individualmente e collettivamente, come interpretare la messe di decreti contraddittori, come reagire alle scelte delle direzione aziendali (pubbliche e private), come andare in lavoro agile, come configurare il proprio lavoro agile, come limitare richieste e obblighi nel lavoro agile, come stare a casa se non si può andare in lavoro agile, come stare al lavoro se la propria attività è indifferibile, come difendere nell’emergenza i propri diritti e le proprie garanzie contrattuali (stipendi, ferie, indennità, congedi, buoni pasto, ecc), come difendere salario o occupazione, come accedere agli ammortizzatori sociali o alle indennità straordinarie previste per la quarantena.
In questo quadro, in molte realtà il sindacato c’è stato. In particolare, ovviamente, dove era più strutturato, con un tessuto di rappresentanza sindacale, delegati/e e RSU in grado non solo di dare risposte, ma anche di organizzare collettivamente un’azione sindacale. Un’azione non solo diretta alla tutela degli interessati, ma spesso capace di farsi interprete di una difesa generale del lavoro, capace di farsi carico delle diverse condizioni provando a ricomporre fratture e divisioni che proprio l’emergenza sanitaria, e poi la crisi conseguente, rischiavano di esacerbare. Ad esempio, i primi ad esser stati travolti dalla sospensione delle attività sono stati i lavoratori e le lavoratrici nell'istruzione. Nelle prime settimane, nei settori pubblici si è aperta una vera e propria divaricazione tra le sue due principali componenti, sospinta dalla gestione ministeriale e da quella di tanti dirigenti scolastici: da una parte i docenti, messi in lavoro a distanza e con stipendio garantito (8/900 mila nella scuola, anche precari; 50 mila nell’università); dall’altra tecnici e amministrativi, spesso tenuti a presentarsi nelle sedi (anche inutilmente), soggetti in alcuni casi a riduzioni di stipendio o anche al rischio di perdere il lavoro (nella scuola il personale ATA, di ruolo, e quello legato ad appalti e servizi, come gli educatori, spesso totalmente instabile, in tutto 150/200 mila; nell’università circa 50 mila dipendenti diretti, a cui si aggiungono appalti e servizi, oltre che il vario precariato di docenza e ricerca, probabilmente oltre 30 mila). Questa faglia è da sempre una caratteristica del settore: oggi rischiava di evolvere in una contrapposizione diretta tra le diverse componenti del lavoro. Così in larga parte non è stato, per una diffusa reazione di RSU e sindacati in scuole e atenei: si sono fatti carico di ricomporre il lavoro, hanno chiesto e sviluppato interventi di protezione per tutti/e, hanno imposto soluzioni contrattuali e normative per presidiare solo i servizi indifferibili (invocando e ottenendo, anche nelle circolari ministeriali, prima l’articolo 1256 del codice civile, poi l’articolo 87 comma 3 del DL 18/2020; curando la loro applicazione nei quasi 70 atenei, nelle ottomila scuole, nelle centinaia di realtà formative pubbliche). Un’azione più difficile e solo molto parziale, purtroppo, si è sviluppata verso i settori più marginali: gli appalti e le mutevoli forme del precariato instabile (educatori, bibliotecari, portinerie, borsisti e giovani ricercatori con le configurazioni più svariate). Anche se in più di una realtà si è segnalata un’inedita azione del sindacato anche nei loro confronti (da Firenze a Padova).
La risposta più significativa ed importante, inaspettata e capace di assumere un valore generale, è stata quella di alcune fabbriche, della logistica e in parte della grande distribuzione: la risposta dello sciopero.
La prima rondine è stata la FCA di Pomigliano. Il pomeriggio del 10 marzo alcune decine di operai hanno incrociato le braccia in una linea di montaggio Panda, per protestare contro la mancanza di misure di sicurezza e la carenza di mascherine. Lo sciopero è stato spontaneo, tanto che solo successivamente la FIOM ha coperto l’iniziativa, mentre questa si diffondeva lungo la linea. FCA, colta in contropiede ma che ben conosce la capacità di incendiarsi della sua classe operaia nei grandi stabilimenti del sud (la lezione di Melfi), ha reagito velocemente, per interrompere ogni ulteriore protagonismo: ha chiuso subito (prima per sanificazione e poi a lungo in cassa integrazione) gli stabilimenti di Pomigliano, Melfi e Cassino (e poi la maggior parte degli stabilimenti europei). Le prime riaperture stanno avvenendo soltanto oggi.
La diffusione degli scioperi. Quella rondine non è passata inosservata. È stata ripresa dai media ed è passata di social in social nei posti di lavoro. Ha dimostrato come si può scioperare anche in emergenza e anche che lo sciopero ottiene dei risultati. Su quell’esempio, quindi, in particolare dal 12 marzo sono stati innescati una serie di scioperi, più consapevoli perché lanciati da RSU in fabbriche con una certa organizzazione di classe. Ed è così che la notizia ha sfondato sui media, con l’apertura di diversi quotidiani on line (rabbia nelle fabbriche aperte: non siamo carne da macello), e diventando da una parte un fattore politico generale, dall’altro un fattore di ulteriore estensione e generalizzazione degli scioperi. Questo impulso è partito soprattutto da due realtà: il Piemonte e Brescia. Due aree non casuali: nella storia recente (anni ‘90 e primi duemila) qui si è spesso segnato il primo livello di attivazione operaia (in difesa dell’art 18 come delle pensioni). In realtà, a ben guardare, a partire non è stato tanto quel tradizionale tessuto storico (l’immediata cintura torinese, l’Iveco e le acciaierie bresciane), quanto una pattuglia di piccoli e medi stabilimenti: la Mtm e la Dierre di Asti, l’Ykk Vercelli, la Trivium di Cuneo, la Pasotti di Brescia e altre 3/4 fabbriche. Gli scioperi si sono rapidamente diffusi anche a grandi stabilimenti: in primis l’AST di Terni (lo stesso 12 marzo) e poi nei giorni successivi Ferrari, Electrolux di Susegana e Forlì, Piaggio di Pontendera, Whirlpool di Cassinetta (Varese), Fincantieri di Venezia, Muggiano, Ancona e Palermo. In rete e sui social si trova notizia di una loro diffusione in diverse realtà: Ilva di Novi Ligure, Valeo di Mondovì, Sct-Hme di Serravalle Scrivia, Site di Borzoli, Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto, Bitron di Cormano, Corneliani di Mantova, Somec di Treviso, Toyota e Bonfiglioli a Bologna, Marcegaglia di Ravenna, GKN di Firenze, Hitachi Rail di Pistoia, Cnhi Vallesina (Jesi). Scioperi che non si sono limitati al nord, ma hanno anche coinvolto il centro sud: Passo Corese (Rieti), Hydro alluminio (Atessa), LFoundry (Avezzano), Leonardo (Grottaglie), Avio Areo (Pomigliano d’Arco), Sider (Potenza). Scioperi che non si sono limitati alle fabbriche. Sono stati coinvolti anche supermercati (come Unes Torino, Orvea di Trento, Lidl della Puglia) come l’articolato mondo della logistica, con un diretto protagonismo dei sindacati di base che hanno segnato il ciclo di lotte dell’ultimo decennio (SiCobas, ADL e USB, che hanno persino collaborato in alcune occasioni): in primo luogo i grandi stabilimenti Amazon (Piacenza e Torrazza Piemonte), ma anche BRT, TNT, UPS, DHL, XPO; in particolare la SDA (blocco delle sedi Brescia, Bergamo, Bologna, Genova, Milano 4, Modena, Torino 1 e 2, Varese) e GLS (Bergamo, Albino, Cividino, Ivrea 4, Milano M1 e M104, Rho M4, Genova G1 e G103, Monza M6, Ardeatina R3). Una collaborazione tra sindacati di base che non si è limitata alla logistica, ma che a Bologna ed in Emilia Romagna si è estesa a tutto il mondo degli appalti pubblici, sino a sviluppare un vero e proprio percorso unitario di diversi sindacati di base. Mobilitazioni e prese di posizione che non si sono limitate a fabbriche e imprese, ma che in alcune realtà hanno coinvolto anche categorie e strutture (Filctem Brescia, SLC Bergamo, Area postale SLC Liguria; Filcams, Fisascat e Uiltucs Liguria, Toscana, Marche e Abruzzo nella grande distribuzione per le domeniche).
Questa reazione è stata straordinariamente importante. Sia per la difesa dei lavoratori e delle lavoratrici, sia per il suo significato politico. Ma non nascondiamone i limiti. Per quanto questo sommario elenco mostri l’estensione delle lotte, ne indica anche i confini. Ad esser protagonisti sono stati pochi settori classe, spesso i più organizzati (fabbriche e logistica in particolare). In molte realtà sono stati scioperi di tutti/e (per ottenere chiusura dell’azienda e/o contrattare le coperture stipendiali), in altre utilizzati solo come copertura individuale per assenze precauzionali (in aggiunte a permessi e congedi straordinari). In molte realtà sono stati massicci, in altre limitati. In molte realtà hanno retto a lungo, in altre realtà si sono sfrangiati. In alcune realtà si è vinto (ottenendo la chiusura dell’azienda e talvolta coperture stipendiali complete), in altre si è perso (non reggendo uno sciopero prolungato e quindi dovendo trattare un ritorno alla produzione), in altre ancora è stata l’azienda stessa a chiudere (anche per riduzione delle forniture o delle commesse).
In tutte queste realtà, gli scioperi hanno avuto due valenze: da una parte una reazione sindacale di autoprotezione, dall’altra la rivendicazione politica di un provvedimento per tutti. Due aspetti che nelle lotte si sono accavallati, reciprocamente influenzandosi. Passando i giorni, però, il rischio di frammentazione tra diverse condizioni e realtà è cresciuto, con diverse realtà che inevitabilmente si sono sfilate da questa dinamica, talvolta perché non si è retto il prolungarsi dello sciopero, ma talvolta anche perché si è vinto e quindi si è ottenuto la sospensione della produzione. Per questo era importante lo sviluppo di una direzione, capace di generalizzare e tener insieme la mobilitazione, politicizzandola contro il governo.
Sarebbe cioè servito generalizzare gli scioperi ed arrivare ad uno sciopero generale, in grado di rivendicare ed ottenere provvedimenti generali, sia relativamente alla sicurezza sia relativamente alla protezione del salario. Cambiando così i rapporti di forza fra le classi e aprendo così, inevitabilmente, una diversa dinamica sociale e politica in tutta la gestione dell’emergenza (e oltre). Questa direzione però è sostanzialmente mancata. A condurre l’iniziativa è stato un tessuto disperso di delegati/e, senza esperienze recenti di autorganizzazione (come furono in parte i coordinamenti negli anni Novanta), senza capacità di darsi un ruolo generale, in una stagione segnata dalla marginalità, dalla divisione come dalla debolezza politica di tutto il sindacalismo conflittuale.
In questo quadro, la risposta della CGIL è stata imbarazzante. Proprio nei giorni in cui gli scioperi si diffondevano, proprio quando la rabbia stava diventando un nuovo ed importante fattore sociale e politico, le centrali sindacali si sono attivate. CGIL CISL e UIL hanno subito firmato con governo e associazioni padronali il protocollo del 14 marzo (il giorno dopo i titoli dei giornali sugli scioperi nelle fabbriche del nord). Un protocollo vuoto, senza nessun particolare impegno da parte del governo (se non un generico riferimento al fatto che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo), una serie di obblighi e doveri del lavoratore, una serie di facoltà e valutazioni in capo alle aziende (ottima l'analisi di Dario Salvetti, CC FIOM e RSU GKN). Un protocollo utile soprattutto ad instradare questa dinamica nell’alveo della gestione governativa dell’emergenza, spegnendo ogni estensione ed ogni generalizzazione delle lotte. Come ha dichiarato lo stesso Landini, l’azione della CGIL (il protocollo come la richiesta al governo di un rapido decreto di chiusura) è stata improntata ad evitare che la paura di lavoratori e lavoratrici diventi rabbia. Quando il decreto è arrivato, dopo giorni di attesa ed un continuo suk di sottogoverno (uscendo oltre 24 ore dopo il suo annuncio, con trattative sino all’ultimo minuto), era chiara l’impronta di Confindustria (dalla lunga lista di codici Ateco alle larghe maglie dei permessi in Prefettura). Nonostante questo, la CGIL ha scaricato su delegati e strutture territoriali la scelta sulla continuazione di scioperi e mobilitazioni (rinunciando al ruolo generale che è proprio di ogni sindacato generale): a scioperare in quei giorni cruciali dopo il DPCM, sostanzialmente, è stato il comparto aerospaziale (Leonardo, Ge Avio, Fata Logistic System, Lgs, Vitrociset, MBDA, DEMA, CAM e DAR). Quindi ha sospinto le proprie strutture lombarde ed emiliane ha diradare lo sciopero a qualche giorno di distanza (il 25 marzo), per provare una trattativa in extremis e quindi strappare la chiusura di qualche codice Ateco in più (senza scalfire l’impianto di quel decreto). Così ha contribuito a spegnere ogni mobilitazione, togliendo spazio alla rabbia e lasciando campo libero alla paura.
Queste scelte della segreteria della CGIL non sono casuali. Sono la conseguenza diretta di una strategia che si è sempre più consolidata nell’ultimo decennio. Come scrivevamo nell’introduzione del nostro documento congressuale, "l'ultimo congresso della Cgil ha confermato la linea del precedente: gestire la crisi cercando il compromesso con imprese e governo". Come con la svolta dell’EUR nel 1978 o la stagione della concertazione inaugurata con gli accordi del ’92/93, la segreteria CGIL si è fatta guidare dalla volontà di esser un sindacato generale che si assume le responsabilità del paese (e quindi si assume in prima persona la responsabilità di rispondere alle esigenze del suo sistema produttivo), più che un sindacato di classe che si assume in primo luogo la difesa degli interessi generali del lavoro. Come scrivevamo nel nostro documento congressuale, "questa strategia è [..] fallimentare, perché si [scontra] con la realtà. [..] Davanti a questa crisi, la strategia della Cgil non [può] che arenarsi nel vuoto. In questi processi epocali, serve un punto di vista autonomo. Serve cioè rompere con la logica delle compatibilità, per cui diritti, salario e sicurezza vengono sempre dopo gli interessi dell’impresa, il profitto e il debito pubblico".
Questa strategia è stata interpretata da Maurizio Landini con protervia e moderazione. Landini, quando più di un anno fa è stato eletto segretario generale della CGIL, ha acceso le speranze di molti, nel sindacato e non solo. Ricordando le sue tradizioni sabattiniane, il ruolo della FIOM nel difendere partecipazione e conflittualità (dal convegno di Maratea nel 1996 e Melfi nel 2004, da Genova 2001 alla stagione degli accordi separati e dei precontratti) si sperava in un nuovo protagonismo della CGIL: un sindacato di strada e di movimento, capace di protagonismo politico e di riconquistare spazi di contrattazione. La sua elezione e la sua segreteria hanno fin qui avuto un altro segno. In particolare, con la scorsa crisi politica estiva, Landini e la CGIL hanno assunto, sin da subito e con un ruolo cruciale, una linea di sostegno alla nascita del Conte bis e la sua maggioranza 5 Stelle-PD-IV-LeU. Da allora, la CGIL non solo ha perseguito una linea di accordo con il padronato, ma si è anche mostrata sempre attenta a non intralciare un governo che contro le destre ha voluto sostenere sin dalla sua nascita. L’emergenza non ha per nulla cambiato questo atteggiamento e questa prassi da parte della segreteria CGIL, che anzi è sempre stata particolarmente attenta al rapporto con il Conte bis.
In questo quadro, Landini e la segreteria CGIL sono stati responsabili. In italiano, l’aggettivo responsabile ha però due accezioni. Da una parte indica come ci si sia comportati responsabilmente (si è assunto consapevolmente un impegno, in modo prudente, equilibrato e giudizioso), dall’altro come si sia responsabili delle scelte effettuate (si sia chiamati a rispondere delle proprie azioni e dei proprî comportamenti). Landini e la CGIL, in un momento cruciale, sono state quindi responsabili, avendo guardato in un momento di emergenza agli interessi generali del paese, ma sono stati anche responsabili, avendo scelto di non contribuire a trasformare la paura dei lavoratori e delle lavoratrici in rabbia. Una grande responsabilità. La paura, infatti, è un sentimento dominante (una volta innescato è difficile da controllare, perché è strettamente connesso ai nostri istinti di sopravvivenza, in grado di esplicitare risposte automatiche e spesso irrazionali) e nel contempo è un sentimento passivizzante, perché paralizza il pensiero e l’azione, producendo ansia e panico. La paura, cioè, isola. La rabbia invece è un sentimento attivo, che attiva psicofisiologicamente le persone per reagire ad una minaccia: è cioè quel sentimento che si innesca quando ci sentiamo defraudati o non accettiamo un'ingiustizia, che ci aiuta a reagire, che ci predispone all’attacco, che ci permette di uscire dai guai.
La paura e la rabbia sono stati i sentimenti dominanti dell’ultimo decennio. La Grande Crisi innescata nel 2008/'09, la disoccupazione e l’aumento dello sfruttamento, la radicale messa in discussione di aspettative e speranze, la precipitazione delle tensioni internazionali e le migrazioni, le guerre ai confini e le nuove improvvise mobilità sociali: tutto questo ha sviluppato paura nelle classi subalterne, rabbia nei ceti medi e nei piccoli produttori. Quella paura e quella rabbia che Renzi non ha mai capito e interpretato, contro cui si è infranta la sua politica bonapartista. Quella paura e quella rabbia che hanno invece alimentato, in Italia e nel mondo, processi di nazionalizzazione delle masse e di sviluppo di movimenti reazionari. La paura nelle classi subalterne, la rabbia nei ceti medi e nei piccoli produttori. In maniera inaspettata, la confusione governativa e l’arroganza padronale hanno invece improvvisamente destato una reazione rabbiosa nel lavoro, in alcuni settori organizzati del lavoro, che sono riusciti ad interpretare un sentimento ed una risposta collettiva: non siamo carne da macello, questa emergenza sanitaria non può esser pagata sempre dagli stessi. Una reazione importante, soprattutto a fronte di un’incipiente recessione che nel perpetuarsi delle attuali politiche di gestione capitalistica della crisi rischia di esser nuovamente pagata, e pesantemente, dal lavoro e dalle classi subalterne. La CGIL ha però contribuito a spegnere questa rabbia, preservando così la paura.
Oggi allora tutto è più difficile. Il governo sta gestendo la riapertura esattamente come la chiusura: con la stessa confusione, inettitudine e subordinazione al padronato. Le centrali sindacali, a partire dalla CGIL, stanno seguendo a ruota, a partire dalla sottoscrizione del nuovo protocollo del 24 aprile, identico nell’impianto e in larga parte nella lettera a quello del 14 marzo. La paura, nel frattempo, ha scavato. Non solo la paura per la salute, ma anche quella della crisi. Oggi pesano i due mesi di cassaintegrazione, le prospettive di pesante recessione [un crollo previsto del PIL italiano del 8-9% (nel 2009 fu -5,5%), di quello mondiale oltre il 3% (nel 2009 fu -0,1%)], l’angoscia per futuri licenziamenti, l’orizzonte di una possibile miseria. Pesa la frammentazione delle condizioni e delle situazioni, tra settori differenti, contratti diversi, prospettive divergenti. Soprattutto, pesa un sindacato generale che ha evitato di mobilitare l’insieme del lavoro, limitandosi anche questa volta ad affrontare l’emergenza e la crisi realtà per realtà, azienda per azienda, stabilimento per stabilimento. Non tutto, certo, si è spento, anche se qua e là emergono anche scioperi falliti e sono evidenti le difficoltà a riprendere le mobilitazioni. Ancora la scorsa settimana, alla prima riapertura, è scesa in sciopero la Fincantieri di Riva, come altre realtà. Mentre diversi percorsi sono rilanciati oggi anche dai sindacati di base, talvolta anche unitariamente (vedi il comunicato sulla ripresa dei trasporti CAT, CUB, Cobas e SGB, l’appello in Emilia Romagna di SiCobas, SGB e ADL, le due giornate di mobilitazione e sciopero lanciate dall'ADL, dal Sicobas e dall’assemblea da loro promossa).
Serve però un salto di qualità. Servirebbe una svolta in CGIL, il cambio di questo gruppo dirigente responsabile, l’assunzione di una diversa strategia e responsabilità, in primo luogo nei confronti della classe. Serve la capacità di estendere e generalizzare le lotte, innescando nuovamente una dinamica di sciopero generale a arrivando a proclamarlo; per contrastare governo e padronato, per una diversa gestione dell’emergenza e della crisi; per sviluppare con l’emergenza un nuovo controllo del lavoro da parte di delegati/e e RLS, cioè un nuovo modello sindacale di lotta per la salute (come tracciamo due anni fa a Viareggio); per cambiare cioè i rapporti fra le classi.