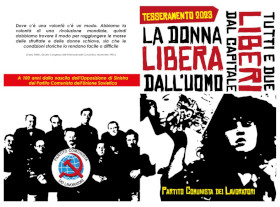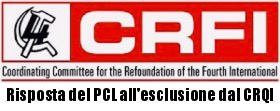Dalla tragedia alla farsa. Lo stalinismo ieri e oggi
La Cina del Grande Timoniere (prima parte)
Mao e il maoismo italiano: una politica opportunista e fallimentare da archiviare per sempre, anche nel mito
4 Febbraio 2021
Il fraintendimento della Rivoluzione culturale e dell’esperienza cinese, vista come novità radicale e libertaria nel panorama del comunismo mondiale. Millenarismo e ascetismo messi al servizio degli scontri di potere all’interno della burocrazia cinese. La ricezione del maoismo in Italia e le principali differenze col marxismo rivoluzionario (prima parte)
Leggi qui la seconda parte
Il maoismo è stato il riferimento dominante dell’estrema sinistra italiana per oltre un decennio, dalla fine degli anni ‘60 alla fine degli anni ‘70. Si è trattato del periodo di più acuta radicalizzazione degli ultimi decenni, in cui era presente nel nostro paese una molteplicità di organizzazioni “rivoluzionarie” militanti e composte ciascuna da diverse migliaia di attivisti. Del resto, anche nei decenni successivi l’influenza del maoismo si è mantenuta, come vago riferimento ideologico, sempre più in calo, ma con alcune delle sue categorie teorico-politiche ancora in vigore nel dibattito della sinistra. Questo dominio dell’ideologia maoista o maoisteggiante sull’estrema sinistra ha marginalizzato a lungo la presenza e l’influenza trotskista nel nostro paese.
Le ragioni di questo sviluppo del maoismo non sono senza causa storica. Fino alla vigilia del ‘68, benché esistessero in nuce varie delle correnti che avrebbero avuto uno sviluppo significativo negli anni seguenti, la principale organizzazione dell’estrema sinistra era rappresentata dalla sezione italiana del cosiddetto Segretariato Unificato della IV Internazionale: i Gruppi Comunisti Rivoluzionari (GCR), diretti da Livio Maitan e che pubblicavano il giornale Bandiera Rossa.
I GCR erano impegnati da circa 15 anni in un’azione di entrismo cosiddetto sui generis all’interno del PCI. Si trattava infatti di un’azione tesa non alla costruzione di un partito rivoluzionario (come nella storica accezione dell’entrismo trotskista in partiti riformisti o centristi negli anni ‘30), ma ad una politica di pressione sulle direzioni staliniste (in Italia come in altri paesi), ed in particolare sui loro settori di sinistra vera o presunta. Nell’Italia degli anni ‘60 questo si esprimeva nell’adattamento all’ingraismo. Pietro Ingrao equivaleva allora, per i nostri revisionisti del trotskismo, al Bertinotti di prima dell’aperta svolta governista. Era il punto di riferimento di ogni prospettiva politica. Si teorizzava che dall’ingraismo sarebbe nato un partito “centrista” (chiamando, da centristi, centrismo il riformismo di sinistra). Nella fase preparatoria del congresso del PCI del gennaio ‘66 – il primo dopo la morte di Togliatti – Ingrao, in lotta per la possibile leadership con il destro Amendola, presentò una serie di distinguo, neppure in forma di veri emendamenti. Tuttavia, nel clima di un partito burocratico e totalmente privo di democrazia interna, la battaglia rappresentò un momento significativo di dibattito. Ingrao si ritirò rapidamente lasciando in “braghe di tela” i suoi sostenitori. I più accesi nel dibattito erano stati ovviamente i militanti dei GCR e della larga tendenza che si era creata intorno a loro. Le conseguenze furono che nel 1966-‘67 la maggioranza di questi militanti fu esclusa dal partito. Nel frattempo, emergevano le prime spinte ad una radicalizzazione giovanile che avrebbe portato alla rivolta del ‘68. Le condizioni sia oggettive che soggettive spingevano a prospettare la costruzione di un’organizzazione indipendente. Ma il gruppo dirigente dei GCR, intorno a Livio Maitan e Sirio Di Giuliomaria, si rifiutò semplicemente di porsi il problema. Ancorato al revisionismo strategico e teorico del “pablismo”, per esso le questioni di costruire un’organizzazione trotskista indipendente era improbabile. La strategia era quella di sviluppare un partito centrista con una presenza in esso dei trotskisti, che lo avrebbero aiutato a sviluppare una politica più o meno rivoluzionaria sotto la pressione delle masse. In altre parole, nonostante le botte prese, bisognava continuare ad attendere Pietro Ingrao. Che ovviamente non venne mai.
In questo quadro un settore sempre più ampio dei GCR e della loro periferia, e poi dello stesso gruppo dirigente, cominciò a sentirsi a disagio in tale politica. Ma confrontando il trotskismo col pablismo, da questo formati e incapaci quindi di un’alternativa strategicamente conseguente, essi fecero la classica operazione di “buttare via il bambino con l’acqua sporca”, abbandonando il riferimento al trotskismo. Il punto di riferimento alternativo per la maggior parte di questi militanti non poteva che essere in quegli anni il maoismo. Contribuivano a ciò l’esistenza della rottura internazionale tra burocrazia dell’URSS e cinese e le critiche da sinistra di quest’ultima alla prima. Ma soprattutto contribuiva il fatto che fosse in corso la cosiddetta “Grande rivoluzione culturale proletaria”, movimento delle masse cinesi che poteva apparire un riferimento di democrazia “di popolo” e di radicale ricostruzione antiburocratica del socialismo. Così il trotskismo italiano, come detto alla viglia del ‘68 la più forte corrente dell’estrema sinistra, uscì da quell’anno di grande ascesa rivoluzionaria distrutto. I GCR avevano infatti perso oltre il 90% dei propri militanti e simpatizzanti attivi, e si ridussero a un piccolo gruppo di qualche decina di militanti senza reale periferia politica.
Dalla diaspora nacquero due organizzazioni maggiori. La prima, Avanguardia Operaia, diretta da Massimo Gorla, Luigi Vinci e Silverio Corviseri (tutti già tra i principali dirigenti dei GCR). La seconda, l’Unione dei Comunisti Italiani (marxisti-leninisti), più nota col nome del suo giornale Servire il Popolo, diretta dall’attuale (futuro) ciellino Aldo Brandirali, già principale dirigente giovanile a Milano dei GCR, passato dal trotskismo alla rivendicazione di Stalin. Accanto ad essi vari gruppi locali come quelli di Franco Russo o Flores D’Arcais a Roma, o scelte individuali o di piccoli nuclei che li portavano in organizzazioni di matrice maoista anche chiaramente richiamantesi a Stalin.
L’insieme delle organizzazioni nate dall’esplosione dei GCR non esaurisce certo le forze che allora si richiamavano al maoismo. Accanto ad esse sussistevano altre correnti. La prima era quella “maoista ortodossa” delle cosiddette organizzazioni “m-l” provenienti da rotture col PCI negli anni ’60, in collegamento con lo sviluppo dello scontro tra il Partito comunista dell’URSS e quello cinese. Si trattava di organizzazioni fortemente ideologizzate, richiamantesi allo stalinismo e in riferimento diretto alle scelte della burocrazia cinese e della sua alleata minore Tirana. La principale di esse era il Partito Comunista d’Italia (marxista-leninista), che rapidamente si divise in varie organizzazioni in aspra lotta e polemica tra di loro. Il settarismo ideologico, le divisioni settarie, un rozzo populismo (più che operaismo), ed una struttura d’adesione non militante (come il PCI ma con un millesimo delle forze o poco più), resero questa corrente, così come in altri paesi, incapace di svilupparsi stabilmente di fronte all’ascesa del ’68 e degli anni seguenti, ed il suo declino in effetti cominciò rapidamente, lasciando il passo, anche sul terreno del maostalinismo, ad organizzazioni più eterodosse come appunto Servire il Popolo o il Movimento Studentesco di Mario Capanna e Salvatore Toscano (poi Movimento dei Lavoratori per il Socialismo, sotto la direzione di Luca Cafiero e dell’ex giovanissimo militante dei GCR Alfonso Gianni).
Un’altra corrente era quella del “maospontaneismo”. In essa la predominanza assoluta era dell’organizzazione a livello militante la più ampia dell’estrema sinistra, cioè Lotta Continua, diretta da Adriano Sofri. Assolutamente aliena da ogni riflessione storico-politica, il riferimento di questa organizzazione al maoismo rappresentava esclusivamente il richiamo di una grande rivoluzione e a un grande paese “socialista”, lontano e idealizzato, senza un vero riferimento alla concreta politica della burocrazia maoista. Tuttavia, l’influenza “ideologica generica” e il richiamo evocativo di Lotta Continua al maoismo influenzò largamente l’immaginario collettivo di una generazione di attivisti e simpatizzanti dell’estrema sinistra, anche al di là dei confini dell’organizzazione.
Infine, si richiamò al maoismo anche il gruppo de Il Manifesto, diretto da Magri, Rossanda, Castellina, Pintor, Caprara e Natoli. Questo gruppo di dirigenti del PCI, esclusi alla fine del ‘69, costituiva la sinistra della corrente ingraiana. Essi portarono nell’estrema sinistra le loro tradizioni politiche-culturali molto ideologiche, idealiste ed astratte. Da questo punto di vista approcciarono il rapporto con il maoismo e la Cina, recuperando in maniera astratta alcune concezioni tra le più formali della Rivoluzione culturale e riproducendo il loro sostanziale riformismo di sinistra in una specie di ipotesi di transizione al pieno comunismo senza rottura rivoluzionaria.
Come si vede, una gamma assai variegata di posizioni, unite solo dal richiamo, anche lì assai differenziato, al maoismo e all’esperienza cinese. Ma quale è stata allora la matrice comune del maoismo italiano, se mai è esistita? Una sola.
Negli anni ‘60 il carattere sempre più apertamente riformista del PCI spingeva un settore sempre più ampio di militanti auspicanti una prospettiva anticapitalista, soprattutto giovani, a cercare un’alternativa a sinistra del vecchio partito. Nella terminologia del marxismo rivoluzionario, tra esso e il riformismo si trova il terreno di quello che dai tempi di Lenin si chiama “centrismo”. Cioè l’insieme delle posizioni assai diversificate intermedie tra riformismo e rivoluzione proletaria e tra le ideologie del primo e la teoria e il programma del marxismo conseguente. Come insegna Trotsky, il centrismo è spesso il terreno di passaggio necessario per settori di militanti (“centrismo progressivo”). A condizione di trovare un punto di riferimento conseguente e non cristallizzarsi in teorie e organizzazioni consolidate sui propri limiti politici. Se al contrario tale cristallizzazione avviene, il centrismo si trasforma in un blocco per l’evoluzione verso il marxismo rivoluzionario (“centrismo reazionario”), come fu fin dall’inizio per le sette “m-l” ortodosse.
Un settore ampio di quei giovani militanti cui ci riferiamo, su posizioni centriste all’interno del PCI, si indirizzarono verso il trotskismo, trovando però non quello conseguente, ma quello revisionista del pablismo, con le conseguenze che già abbiamo visto. Ma anche le altre correnti del maoismo poterono evolversi e rafforzarsi come fecero per la mancanza di un’alternativa trotskista.
La grande rivolta studentesca del ’68, che portò così tanti militanti all’estrema sinistra, e quella operaia del ‘69, che ne diede certo di meno, ma tuttavia un settore non insignificante, videro nelle varie organizzazioni maoiste il punto di riferimento per la debolezza e l’incapacità del trotskismo. In altri paesi non lontani da noi, come Gran Bretagna e Francia, la relativa forza delle organizzazioni trotskiste fece sì che il maoismo restasse una corrente minoritaria nell’estrema sinistra. Vero è che lì la maggior parte della corrente trotskista era rappresentata da organizzazioni a sinistra dei pablisti locali. Nella stessa Francia, dove un ruolo importante ebbe quella che doveva divenire la Lega Comunista Rivoluzionaria, essi furono spinti a sinistra dalla presenza di organizzazioni trotskiste meno revisioniste, che minacciavano di surclassarli politicamente. Questo mostra che ciò che accadde in Italia non era inevitabile. Come affermava un grande del pensiero marxista, Antonio Labriola, “le idee non cadono dal cielo”. E si può aggiungere “nemmeno le idee maoiste”.
Il trionfo del maoismo nell’estrema sinistra del ‘68 non era inevitabile ma fu il prodotto della sconfitta politica del trotskismo italiano a causa della sua politica revisionista e della sua incapacità di porsi sul terreno della costruzione del partito rivoluzionario. I giovani soggettivamente rivoluzionari che cercavano un’alternativa conseguente al riformismo del PCI trovarono al suo posto varie forme di centrismo cristallizzato. Erano giunti all’indirizzo sbagliato e l’avanguardia di classe ne pagò le conseguenze per decenni.
CHE COSA ERA IL MAOISMO NELLA REALTÀ?
Ma che cosa rappresenta dunque nella realtà il maoismo cui queste forze si riferiscono?
Al di là delle illusioni di una parte di esse, non una novità radicale e libertaria del panorama del comunismo mondiale, ma un settore dello stalinismo internazionale. Un settore di sinistra, certamente, ma pur sempre legato a una politica che, pur con tutte le sue contraddizioni, restava dal punto di vista della rivoluzione socialista mondiale e del potere dei lavoratori sostanzialmente quella di una forza controrivoluzionaria, al pari del resto dello stalinismo mondiale. La storia futura della politica cinese, tanto interna che internazionale, si sarebbe incaricata di dimostrarlo. Ma il punto che ovviamente sfuggiva all’estrema sinistra nostrana, lontana dal metodo di analisi marxista, era il fatto che la politica maoista, come ogni altra, non era solo una serie di idee astratte, le si valutassero positivamente o negativamente, ma l’espressione di interessi sociali. Nel caso concreto quelli di una burocrazia parassitaria che dominava uno Stato basato su forme di proprietà proletarie, cioè socializzate, espropriando però il proletariato del potere politico e godendo, sulla base del monopolio di quest’ultimo, di grandi privilegi materiali.
Noi abbiamo analizzato in varie occasioni la natura della burocrazia cinese e della sua politica, e non è qui possibile riprendere l’insieme del contenuto di quegli articoli. Ci limiteremo quindi a indicarne i tratti essenziali.
Il Partito Comunista Cinese, portato dalla rivoluzione del 1925-‘27 alla direzione della grande maggioranza del proletariato e di una parte importante del movimento contadino, subì le conseguenze disastrose della politica di subordinazione al partito della borghesia nazionale – il Kuomintang –, politica imposta ai dirigenti del PCC, in particolare al suo segretario Chen Duxiu, dalla direzione dell’Internazionale Comunista nelle mani di Bucharin e Stalin. La rottura del Kuomintang (prima la sua ala destra capeggiata da Chiang Kai-shek, poi anche quella sinistra) con i comunisti e le conseguenti sanguinose repressioni colpirono duramente il PCC. Il brusco passaggio ad una politica avventurista di insurrezione nelle città (comune di Canton) aggravò ancora la crisi del PCC. Progressivamente il centro del partito si spostò dalla direzione di origine cittadina al gruppo militare a base contadina raccolto intorno a Mao Tse-tung, che dirigeva le zone rurali rosse. Qui si erano rifuggiate e riorganizzate, con l’appoggio dei contadini, le forze militari del PCC scampate alla repressione governativa delle rivolte avventuriste della fine del 1927. La vittoria definitiva di Mao Tse-tung all’interno del Partito si ebbe alla conferenza di Tsunyi (gennaio ‘35) tenuta durante la Lunga marcia. Qui egli viene nominato presidente del Comitato Centrale, nomina che sanciva la sconfitta di Wang Ming, un militante formatosi a Mosca ed accusato di deviazionismo di sinistra.
Contrariamente a quanto affermato da molti esaltatori antistalinisti del maoismo, il passaggio della direzione del partito dai militanti formatisi in URSS a Mao non rappresentò affatto una rottura e nemmeno una differenziazione dallo stalinismo. Il PCC rimane un partito staliniano, anche se di tipo particolare, cioè a base contadina. Questa caratteristica avrà un’importanza enorme per gli avvenimenti successivi. Infatti, la politica e le scelte del PCC sono state determinate da un lato dalla sua politica staliniana, dall’altra dai rapporti con la sua base di massa contadina. Sarà sulla base di una potente rivolta contadina che l’esercito maoista potrà vincere la guerra civile del 1946-’49. Sarà intorno al problema della riforma agraria che cadranno le ultime possibilità di accordo col Kuomintang. Sarà infine sulla base della rivolta contadina che si caratterizzeranno i tratti distintivi del regime creato dalla rivoluzione del 1949.
Quanto al carattere staliniano e controrivoluzionario, pur in una versione di “sinistra” del PCC, può essere dimostrato da una analisi non superficiale della sua politica.
In accordo con le direttive del VII congresso dell’Internazionale comunista (1935), che lanciò la prospettiva di coalizione con la borghesia (fronti popolari), il PCC liquidò nelle zone del nord, in cui aveva trasferito le sue basi, ogni forma sovietica. Nel febbraio del 1937 il PCC propose al Kuomintang la costituzione di un “fronte unito patriottico” e accettò, almeno formalmente, le sue richieste: scioglimento dell’Armata Rossa, con l’inquadramento delle sue forze nell’esercito regolare, e cessazione della propaganda comunista. È di questo periodo la teorizzazione maoista sulla “nuova democrazia” [1]. Se nei fatti l’integrazione delle zone liberate delle armate rosse contadine nell’amministrazione politica e militare del regime non si realizzò, ciò fu dovuto in buona parte alla politica del Kuomintang che, sotto la pressione delle forze più reazionarie, ostili ad ogni compromesso, violò ogni accordo intercorso tra i due partiti. Così nel gennaio 1941 le truppe del Kuomintang attaccarono a tradimento la “Nuova IV Armata” (comunista) infliggendole gravi perdite. Questo bloccò, per il resto della guerra, ogni ulteriore approfondimento dell’inserimento del PCC e del suo apparato amministrativo e militare nello Stato borghese.
Alla fine delle guerra (1945), nonostante il PCC avesse enormemente aumentato la sua forza militare, la sua influenza e le zone sotto il suo controllo, sotto gli auspici del governo americano si giunge ad un nuovo accordo con il Kuomintang, alla “Conferenza politica consultiva” del gennaio 1946. In base a tale accordo si sarebbe dovuto creare un Consiglio di Stato (governo) provvisorio di quaranta membri, scelti interamente da Chiang Kai-shek, metà tra le file del Kuomintang e metà negli altri partiti, non solo nel PCC ma anche la Lega democratica (il nuovo partito dell’ala “progressiva” della borghesia nazionale) ed altri partiti minori. Si sarebbe convocata un’assemblea costituente non elettiva, ma formata da rappresentanti delle regioni, delle varie professioni e dei partiti più o meno con la stessa proporzione del Consiglio di Stato, quindi con il PCC in netta minoranza nei confronti della borghesia. Inoltre, era prevista la drastica riduzione delle forze militari. Un accordo del 25 febbraio tra il Generale Marshall (rappresentate americano), il generale Chan Chin Chung (Kuomintang) e Chou En-lai precisava che le forze governative sarebbero state ridotte a 90 divisioni (più tardi 50) e quelle comuniste a 18 (più tardi 10), ciascuna di 14mila uomini. Nonostante tali accordi fossero di sostanziale capitolazione del PCC, le forze più reazionarie – in particolare i militari del Kuomintang – contrarie ad ogni accordo con il PCC e che temevano lo stabilirsi di un regime di democrazia borghese, li fecero fallire. Nell’estate del ‘46 il governo lanciò quindi un’offensiva generale contro le zone controllate dal PCC, nonostante il parere contrario del governo americano. Il PCC continuò però a mantenere la sua politica precedente, limitandosi sostanzialmente a difendersi e a cercare le vie di un accordo. È solo dopo la caduta di Yenan, capitale delle zone liberate, nel marzo del ‘47 e dopo aver compreso che ogni possibilità di accordo era venuta a cadere, che il PCC si lanciò in una politica offensiva, tra l’altro portando avanti una politica di riforma agraria che, per quanto moderata, trascinò sotto le sue bandiere milioni di contadini entusiasti.
È a proposito di queste scelte che molti, in particolare tra le forze revisioniste del trotskismo, hanno parlato di rottura con lo stalinismo, in quanto il PCC avrebbe violato con la sua offensiva gli ordini di Stalin. Tale valutazione è a nostro avviso scorretta, anche se è vero che il PCC ha seguito in quelle scelte decisioni autonome e, almeno in parte, diverse da quelle di Stalin e del PCUS, che sono intervenuti più volte – ancora nell’aprile del 1949 – per cercare di moderare l’azione del PCC. Infatti:
1) Nonostante le divergenze non c’è stata rottura con Stalin. Il 1947 è l’anno in cui esplode la guerra fredda. Sottoposta alla pressione imperialista, la burocrazia russa inizia a realizzare il processo di trasformazione, con mezzi burocratico-militari, degli Stati dell’Europa orientale e della Corea del Nord occupati dall’Armata Rossa, da Stati capitalisti sotto tutela russa quali li aveva mantenuti sino ad allora in Stati operai deformati. Dovunque lo stalinismo è costretto ad una svolta a sinistra. Per il PCC, lanciare un’offensiva generale per rovesciare il regime del Kuomintang nel 1946 avrebbe probabilmente comportato una rottura con Stalin ed il PCUS: nel 1947 non è più così. Se Stalin cerca di moderare il PCC è soprattutto perché da un lato vuole probabilmente saggiare sul terreno della Cina la possibilità di ritrovare una politica d’intesa con l’imperialismo, in particolare USA, dall’altro lato teme che la conquista del potere con un’azione autonoma in un paese con 500 milioni di abitanti, da parte di un partito comunista, possa produrre un fattore di crisi nello stalinismo mondiale. In particolare, gli ultimi interventi moderatori, nel 1948-‘49 arrivano dopo la rottura con Tito, che Stalin teme possa ripetersi su più vasta scala con Mao.
2) La natura stalinista del PCC era determinata certo dal legame con la burocrazia URSS, ma non esclusivamente da ciò. Anche se il PCC avesse rotto completamente con Stalin, la sua natura sarebbe stata caratterizzata dalla sua politica nella costruzione della nuova Cina. Da questo deriva la sua natura staliniana. Una volta lanciata l’offensiva il PCC riesce a liquidare, in poco più di due anni, un regime corroso fino alle midolla, odiato dalla grande massa della popolazione e i cui eserciti in buona parte si sbandano al momento delle battaglie decisive. Tuttavia, la presa del potere da parte del PCC non segna la distruzione della presenza politica ed economica della borghesia. Di nuovo in questo momento si rivela il carattere staliniano controrivoluzionario della direzione del partito. In accordo con la propria teoria sulla natura democratico-borghese della rivoluzione, il PCC si sforza di legare la borghesia al proprio regime. Mentre si denunciano le “rivendicazioni eccessive” della classe operaia e i comitati di fabbrica, sorti in molte grandi città all’arrivo dell’Esercito rosso, sono costretti a sciogliersi (il PCC vi vedeva chiaramente il pericolo per il proprio dominio), si invitavano i capitalisti fuggiti a rientrare per “riprendere il proprio posto”. Il governo non viene preso in mano dai soli comunisti ma vi si inseriscono diversi esponenti dei partiti borghesi e piccolo borghesi, in particolare della Lega democratica (naturalmente il controllo effettivo era nelle mani del solo PCC). Il programma generale della Repubblica Popolare Cinese dichiara, all’articolo 3, che la Repubblica “tutela la proprietà dello Stato e delle cooperative e protegge gli interessi economici e le proprietà private degli operai dei contadini, della piccola borghesia e della borghesia nazionale” e, all’articolo 26, che lo Stato “coordina e regola l’economia di proprietà dello Stato, l’economia cooperativa, l’economia individuale dei contadini e degli artigiani, l’economia capitalistica e l’economia capitalistica dello Stato nelle rispettive sfere d’azione”.
3) Fino al 1952 si mantiene questa politica di accordo con la borghesia che però fallisce per molteplici motivi. Intanto buona parte dei capitalisti erano fuggiti a Formosa, a Hong Kong o in altri paesi al momento della caduta del regime del Kuomintang e non molti accettarono di rientrare in Cina. Poi la situazione mondiale è dominata dalla guerra fredda. La Repubblica Popolare Cinese si trova fin dall’inizio isolata dal mercato mondiale, cosa che non facilita certo il mantenimento dei rapporti borghesi di proprietà. La Cina si deve appoggiare completamente al blocco degli Stati operai degenerati o deformati (URSS e paesi dell’Est), ulteriore incentivo a mutuarne la struttura sociale. La guerra di Corea e la necessaria mobilitazione interna spingono ad una maggiore pianificazione statale dell’economia che cozza con l’anarchia classica del capitalismo privato. Molto importante inoltre è il dato che la riforma agraria generalizzata iniziata nel 1950 non poteva non essere in parte minacciata dall’oggettiva tendenza del capitale privato a penetrare nelle campagne, creando nuove tensioni sociali.
In definitiva, si può affermare che l’insieme dei fattori derivanti dalle esigenze dello sviluppo economico, dalla situazione creata dalle misure democratico-borghesi radicali realizzate (riforma agraria, etc.), dall’isolamento e dalla pressione imperialistica, non potevano che cozzare sempre più con l’elemento di anarchia e squilibrio inserito nella situazione cinese dal mantenimento della presenza del capitalismo privato.
Ciò è un ulteriore dimostrazione della validità della teoria della rivoluzione permanente [2] e della falsità della teoria menscevica e staliniana della rivoluzione a tappe. Non completare l’esproprio della borghesia avrebbe significato rimettere potenzialmente in discussione le conquiste democratico-radicali della rivoluzione e con ciò anche il potere del PCC. Su questa base il governo maoista assume sempre più chiaramente le caratteristiche di un governo operaio e contadino, cioè di un governo che si pone lo scopo della distruzione del potere, sia politico sia economico, della borghesia. Dal 1952 al 1956 la percentuale della produzione nelle industrie di Stato e miste passa dal 61% al 99,62% della produzione industriale totale. La borghesia è eliminata. Ma ciò che viene così creato non è uno Stato operaio gestito da un regime di dittatura del proletariato, ma uno Stato operaio deformato, qualitativamente non diverso dall’URSS staliniana, in cui, mentre i rapporti di produzione e quindi di proprietà hanno un carattere proletario, non solo i rapporti di distribuzione hanno un carattere borghese, ma in più il proletariato è espropriato del potere politico da una casta burocratica piccolo-borghese. Questa esercita la propria dittatura sulle masse e si serve del suo potere politico per mantenere e rafforzare i vantaggi materiali di cui gode in virtù dei rapporti di distribuzione borghesi. La burocrazia dominante è un ostacolo fondamentale per ogni ulteriore progresso verso il socialismo – cioè l’abolizione delle classi sociali – e la difesa dei suoi interessi materiali e del suo potere politico ne fa un elemento fondamentale di perturbazione e blocco dello sviluppo dello Stato operaio e di ripercussione su di esso della pressione del capitalismo mondiale.
Per questo, mentre deve difendere i rapporti di proprietà dalla reazione capitalista internazionale, il proletariato ha necessità di rovesciare, tramite una rivoluzione politica, la burocrazia dominante, il cui potere tende in definitiva a mettere in causa le stesse basi sociali dello Stato. La storia successiva della Repubblica Popolare Cinese darà un’evidente conferma di questa analisi trotskista.
IL PRIMO PIANO QUINQUENNALE, IL “GRANDE BALZO IN AVANTI” E LE COMUNI POPOLARI: FALLIMENTO ECONOMICO E SUE CONSEGUENZE
La trasformazione definitiva dell’economia cinese avviene con il primo piano quinquennale (1953-1957). Questo è direttamente mutuato dalla classica politica staliniana di sviluppo dell’industria pesante, in larga parte basata sul surplus derivante dall’agricoltura, che veniva aumentato con la collettivizzazione. Il primo piano quinquennale permise alla Cina di ottenere grandi successi con un aumento del PIL di circa l’8-9% l’anno e soprattutto un poderoso aumento della produzione industriale di materie base. Per di più, a differenza della Russia degli anni ‘30, la collettivizzazione può realizzarsi in maniera sostanzialmente pacifica, grazie al grande prestigio che il PCC gode tra le masse contadine. Ciononostante, soprattutto verso la fine del piano, si manifestarono vari limiti. Il ritmo di incremento della produzione industriale scese drasticamente. In linea generale questi limiti sono il prodotto oggettivo della situazione di arretratezza dell’economia cinese, ben al di sotto dei livelli, già di per sé bassi, dell’URSS alla fine degli anni ‘20. Così, nonostante lo sviluppo, i livelli di produzione rispetto alla scala mondiale restano bassi. In più si manifesta un certo scollamento tra l’industria e l’agricoltura.
Per lo sviluppo della Cina era certamente necessario cercare di accrescere il tasso di sviluppo della produzione sia industriale che agricola. Ma la risposta che la burocrazia dà a questa necessità è il lancio di una folle politica avventurista. Viene annullato il secondo piano quinquennale, già programmato: al suo posto si lanciano il cosiddetto “Grande balzo in avanti” e le “Comuni popolari”. In pratica si tenta di realizzare lo sviluppo della Cina in tempi brevissimi (“pochi anni per raggiungere l’Occidente e quindici per raggiungere il comunismo”). Si decide così di conglobare le cooperative contadine (740mila) in 26mila gigantesche Comuni agrarie, le quali dovevano essere autosufficienti e in più partecipare allo sviluppo generale della produzione industriale, che a sua volta avrebbe dovuto crescere potentemente nelle città. Tutto ciò sulla base di una volontaristica mobilitazione delle masse, in particolare contadine, con l’ausilio di incentivi puramente morali. In pratica si tratta del più ampio ed incredibile tentativo di militarizzazione del lavoro che sia mai stato tentato. I contadini, praticamente trasformati tutti in lavoratori salariati, sono costretti a turni di lavoro massacranti (il plenum del Comitato Centrale del PCC del 28 novembre - 10 dicembre 1958, che apporta le prime rettifiche “moderatrici” al “Grande balzo”, dichiara in una sua risoluzione: “Ma in ogni caso, otto ore per dormire e quattro ore per mangiare e per la ricreazione, cioè in tutto 12 ore, devono essere garantite e non devono essere ridotte”).
Questa politica, utopistica e reazionaria, di costruzione di un “comunismo della povertà” sotto controllo della casta burocratica dominante, tramite una propaganda millenaristica che sostanzialmente invitava ad accettare l’inferno oggi promettendo il paradiso a breve termine, fallisce completamente. Numerose sono le cause di tale fallimento. I contadini reagiscono fin dall’inizio ai turni massacranti rallentando il ritmo di lavoro. Buona parte della forza lavoro impiegata in attività che non danno alcun frutto positivo (ad esempio i forni di famiglia per la produzione di acciaio) viene sottratta ad altre occupazioni fondamentali. Risulta impossibile far funzionare le Comuni come organi vitali, a causa del loro carattere mastodontico e dell’enormità degli obiettivi posti, che sono impossibili da rispettare. Tutti i ridicoli tentativi di aumentare la produzione di beni industriali con metodi artigianali applicati su larga scala falliscono. Infine, ma come cause secondarie, sono da aggiungere disastri naturali (inondazioni, etc.) ed il ritiro nel 1960 dei tecnici sovietici a causa della rottura tra Pechino e Mosca. Non è possibile indicare dati precisi, perché dal 1960 il governo cinese ha smesso di pubblicarne. Tuttavia, si può affermare sulla base di vari elementi di analisi, che la produzione agricola è calata del 15-20% nel periodo 1958-‘60 e quella industriale del 30-40% dal 1959 al 1962.
Questo disastro senza precedenti non poteva che avere ripercussioni politiche al più alto livello. Benché tutto si svolga nel chiuso dei livelli più alti dell’apparato senza che niente filtri ufficialmente all’esterno, i fatti possono ugualmente essere ricostruiti. A mano a mano che il totale fallimento della politica del “Grande balzo” risulta evidente, si rafforzano nel partito le tendenze a un riequilibrio. Questo si realizza nel 1961-‘62. Poiché Mao era stato fino all’ultimo il difensore del “Grande balzo” e probabilmente tendeva a perpetuare tale politica, pur con alcuni correttivi, i mutati orientamenti colpiscono duramente la sua posizione. Durante la Rivoluzione culturale verrà più volte affermato che la direzione del partito dal 1959 al 1965 era caduta nelle mani della “linea” nera e che Mao era stato esautorato. Benché questa affermazione sia parzialmente esagerata, è certo che dal 1959 al 1961 si forma e infine si afferma un centro del partito che acquista la maggioranza in seno all’Ufficio Politico e relega in ruolo secondario Mao e i suoi sostenitori (Lin Piao, Chen Po-ta). La gestione del partito passa nelle mani di un gruppo non omogeneo ma allora sostanziale unito, diretta da Liu Shao-ch’i (Presidente della Repubblica), Deng Hsiao-ping (sindaco di Pechino) e Chou En-lai. Tale gruppo gode del sostegno certo della grande maggioranza dei quadri burocratici dell’apparato e dello Stato ed è l’artefice del mutamento della linea economica.
Per il momento Mao, rimasto per l’esterno il leader carismatico, deve accontentarsi di attaccare i suoi avversari su aspetti secondari, aspettando il momento della rivincita. Qui stanno le basi di quella che sarà chiamata la “Grande rivoluzione culturale proletaria”.
LA “GRANDE RIVOLUZIONE CULTURALE PROLETARIA”
Dopo la vittoria su Mao, il gruppo Liu-Deng abbraccia in campo economico una politica moderata tendente a riequilibrare la situazione. Le Comuni, benché formalmente non abolite, sono scomposte. Viene frenata ogni ipotesi di rapido sviluppo industriale. In questo periodo si completa la rottura con Mosca. Proprio mentre il PCC è nelle mani di Liu e Deng la crisi dei rapporti con l’URSS si acutizza fino alla completa rottura con Mosca, nel 1964.
Solo su un aspetto particolare si sono manifestate divergenze: l’atteggiamento verso l’URSS in rapporto alla guerra del Vietnam. A partire dallo scontro su questo problema la frazione di Mao e Lin Piao prepara il terreno per la propria rivincita. Durante il 1965, infatti, mentre si intensifica l’azione militare americana con l’inizio dei bombardamenti sulla Repubblica Democratica del Vietnam, una frazione dell’apparato militare, diretta dal Capo di Stato maggiore Lo Jui-ch’ing e che gode dell’appoggio sostanziale di Liu Shao-ch’i e Peng Zhen, cerca di fare prevalere la linea della ricerca di un accordo tattico di fronte unico militare con l’URSS in appoggio al Vietnam. Contro questa posizione Lin Piao lancia la propria offensiva proponendo di rigettare ogni ipotesi di accordo con l’URSS e di evitare ogni rischio di ripetizione dell’“incidente coreano”. Le famose teorizzazioni sulla “guerra di popolo” contro la “guerra tradizionale” non sono che la copertura ideologica di questa politica moderata e rinunciataria. Dopo un’aspra lotta le posizioni di Lin Piao trionfano. Nel gennaio 1966 si riunisce una “conferenza sul lavoro politico nell’esercito” in cui questa vittoria trova la sua consacrazione. Lo Jui-ch’ing e i suoi sostenitori nell’esercito vengono purgati. Nessuno dei maggiori leader del centro del partito sembra aver adottato una politica di scontro frontale con Lin Piao.
È probabile che nessuno di loro si rendesse conto che, per la frazione maoista, la conquista del controllo dell’esercito non era che l’inizio di un’offensiva generale. Invece nei mesi successivi essa si lancia all’attacco dei suoi avversari su tutti i piani. Il 16 maggio 1966 l’Ufficio Politico approva una circolare che attacca duramente Peng Zhen, nomina un “gruppo centrale della Rivoluzione culturale” (con Chen Po-ta presidente e la moglie di Mao, Chiang Ch’ing, vice) e fa appello alla lotta contro “i rappresentanti borghesi che si sono infiltrati nel partito, nel governo, nell’esercito e in tutti i settori del campo culturale”. Il 3 giugno Peng Zhen viene destituito dalle sue cariche.
Come è stato possibile questo rovesciamento di posizioni? Conoscere precisamente quello che è avvenuto è ad oggi impossibile. Ciononostante, si può affermare che di fronte a una sostanziale unità della frazione Mao-Lin Piao, il centro del partito si è diviso.
Così come Liu Shao-ch’i e Peng Zhen avevano abbandonato al suo destino Lo Jui-ch’ing, così di nuovo Liu e Deng Hsiao-ping abbandonano Peng Zhen. Inoltre, è probabile che in questo momento Chou En-lai cominci a differenziarsi dai suoi alleati. Certo sulle decisioni del 16 maggio la frazione maoista fa pesare il controllo acquisito sull’esercito. Il 16 maggio si realizza però anche un compromesso. Se il gruppo centrale della Rivoluzione culturale è integralmente nelle mani dei maoisti, il compito dell’intervento nelle università viene assunto dai “gruppi di lavoro” controllati da elementi legati a Liu (tra cui sua moglie). Lo scontro decisivo è solo rinviato. L’intervento dei “gruppi di lavoro” provoca duri scontri con la massa degli studenti ribelli, i cui dirigenti sono spinti alla resistenza dallo stesso gruppo della Rivoluzione culturale, con cui sono in diretto contatto. La massa studentesca è mobilitata sulla base di una propaganda millenaristica, falsamente egualitaria e antiburocratica, centrata intorno alla mitizzazione del pensiero di Mao. Nell’agosto del ‘66 si riunisce, per la prima volta dal 1962, un plenum del Comitato Centrale.
Qui lo scontro è completamente aperto. Alla fine della riunione Mao riesce ad ottenere la vittoria (con una debole maggioranza, come preciserà lui stesso più tardi). Il Comitato Centrale vota un documento sulla “Grande rivoluzione culturale proletaria”. Si fa appello alle mobilitazioni delle masse intorno al pensiero di Mao per combattere gli elementi che, “si sono impegnati nella via capitalista”. Naturalmente è possibile raccogliere intorno alla “linea giusta” il 95% dei quadri, mentre i “destri antipartito e antisocialisti” devono essere liquidati. Si fa poi appello alla costituzione di comitati per la “Rivoluzione culturale alla base”. Le stesse masse devono educarsi “rivoluzionandosi”.
L’XI Plenum apre la via allo sviluppo più completo di quelle che prendono il nome di “Guardie rosse”. La gioventù studentesca scende in massa in strada. Prende di mira i simboli di quelli che considera i costumi borghesi da abbattere. In realtà, al di là delle apparenze, questa mobilitazione è strettamente controllata. Dovrebbe essere la fase finale dell’operazione maoista. Estendendosi da Pechino al resto del Paese essa avrebbe dovuto portare all’epurazione del 5% di “quadri irrecuperabili” e, soprattutto, alla messa in riga dell’apparato burocratico in disfacimento attorno alla frazione maoista. Per quanto riguarda il vertice del partito, questo avrebbe allora potuto essere ristrutturato sulla base di un adattamento della frazione Liu-Deng all’asse Mao-Lin Piao, come del resto era avvenuto, almeno parzialmente, per Chou En-lai (quanto agli irrecuperabili al vertice del partito, l’epurazione di Lo Jui-ch’ing e Peng Zhen poteva essere più che sufficiente).
A questo punto, però, l’ipotesi maoista viene sconvolta da un atteggiamento imprevisto. Invece di capitolare, la frazione liuista contrattacca. Interviene nel movimento delle masse studentesche e sempre sotto la copertura del “pensiero di Mao” e della lotta contro i “quadri che hanno imboccato la strada capitalista”, organizza le proprie formazioni di Guardie rosse. A partire da settembre le università e le città di trasformano in teatri di sanguinose battaglie tra le diverse organizzazioni di Guardie rosse, mentre la situazione favorisce un pullulare di gruppi studenteschi rivali la cui lotta si svolge a volte in maniera slegata dallo scontro tra le diverse frazioni del partito.
Note:
[1] La “nuova democrazia” era la teoria sulla base della quale Mao superava “concettualmente” il potere sovietico e la prospettiva socialista, in nome di un nuovo modello “popolare” di potere e di società, né borghese né proletario, in un quadro di collaborazione tra le classi, ad eccezione di quella feudale e della “borghesia compradora”, ma inclusa la borghesia nazionale. Questa utopia piccolo-borghese esprimeva in realtà la dichiarazione del gruppo dirigente del PCC di disponibilità ad una intesa di collaborazione di classe in un quadro “progressista”, segnalando inoltre che anche in caso di propria vittoria non avrebbe preso una via radicale anticapitalistica. In realtà quando, in un quadro certo inatteso dieci anni prima, il PCC prese il potere liquidando il Kuomintang, tentò effettivamente di applicare questa politica, ma si scontrò con la realtà sia interna che internazionale.
[2] La teoria della rivoluzione permanente è quella che Trotsky elaborò nel 1905 in relazione alle prospettive della Rivoluzione russa. Riprendendo la concezione (e il termine) applicati da Marx ed Engels alla Germania della metà del secolo precedente (ed espressi in particolare nell’