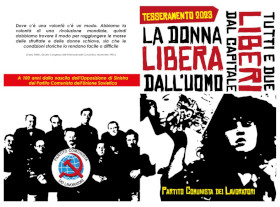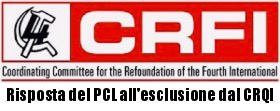Internazionale
Orbán. Un despota in Europa
Una recensione marxista
2 Febbraio 2020
UN LIBRO DA LEGGERE
È appena uscito per i tipi della Salerno Editrice l’ultimo libro di Stefano Bottoni, Orbán. Un despota un Europa. Perché questo libro è importante? Di cosa parla? Chi è l’autore e perché è importante? In questa recensione cercherò di dare risposta a queste domande.
Stefano Bottoni è uno storico italo-ungherese di provata fede anticomunista, che ha scritto diverse opere sul comunismo ungherese e rumeno. Ha vissuto a Budapest per diciassette anni, dei quali gli ultimi dieci ha lavorato per l’Accademia delle Scienze Ungherese, prima di trasferirsi all’Università di Firenze. Il trasferimento di Bottoni, è importante sottolinearlo, è conciso con la stretta di Orbán sull’Accademia, che era rimasta una delle ultime istituzioni libere dal suo controllo politico. Ora non è più così, in quanto il governo ha messo sotto controllo diretto sia i centri di ricerca sia i fondi, ponendo di fatto fine all’indipendenza dell’istituzione.
Venendo al libro, perché è importante? Perché dei comunisti interessati a capire meglio l’Ungheria di Orbán dovrebbero leggerlo?
Come si accennava sopra, Stefano Bottoni è noto per il suo anticomunismo viscerale, che emerge anche dalle pagine del libro. È anche necessario far notare che in passato simpatizzò per Orbán, anche se del fatto non c’è traccia nella prefazione del libro (e invece avrebbe potuto essercene, perché ciò avrebbe potuto dare al lettore un elemento di spiegazione, oltre che essere un’occasione di autocritica). Eppure, è difficile classificarlo politicamente. Certamente lo possiamo classificare all’interno dello spettro borghese. Ma anche lì, la sua collocazione è molto particolare. Temendo di sbagliare, mi sento di classificarlo un nazionalista moderato, democratico.
Per tornare alla domanda di cui sopra, perché ci dovrebbe interessare un libro sull’Ungheria di Orbán scritto da un nazionalista ungherese, per quanto moderato? I motivi sono presto detti. Stefano Bottoni ha scritto un ottimo libro sull’Ungheria di Orbán, storicizzando con grande competenza storica sia il passato più lontano sia quello recente, e collegandoli. Il libro è scritto con una metodologia ineccepibile e facendo ampio uso di fonti, sia pubblicate che primarie. Tra quelle primarie, oltre all’abbondante uso della stampa ungherese, ci sono molti file Wikileaks, utilissimi per esplorare i rapporti dell’Ungheria con gli Stati Uniti. L’autore si è inoltre servito di interviste condotte personalmente a molte persone informate sui fatti (non di tutte ha potuto scrivere il nome) e della sua lunga esperienza di residenza a Budapest (quasi vent’anni, come si diceva).
Il risultato è davvero sconcertante, nel senso che Bottoni ci dà un ritratto di Viktor Orbán come un genio politico, un maestro dal cinismo calcolatore, un opportunista pronto a cogliere ogni occasione. Il ritratto che ne fa Bottoni è sicuramente più realistico di quello, sostenuto da tanti, di un giovane ben intenzionato finito male a causa del troppo potere. Più realisticamente, l’autore ci fa vedere come alcune premesse ideologiche dell’orbánismo erano presenti già dall’inizio. Si è trattato di un lungo processo che ha portato un ragazzo di campagna a gestire un potere quasi autocratico, e ad essere tanto sicuro di sé da programmare le sue attività al governo fino al 2030. Dopo aver eliminato o cooptato con vari mezzi quasi tutti i mezzi d’informazione indipendente, si può dire che Orbán sia diventato una figura comica, se non fosse tragica. Non partecipa a dibattiti televisivi, non si confronta pubblicamente con gli avversari, non si fa intervistare da giornalisti sgraditi. Comunica regolarmente col popolo attraverso un programma radio del venerdì, con il quale espone i piani per la prossima settimana.
CHI È ORBAN?
Ma come è potuto avvenire tutto ciò? Il libro di Bottoni è in parte anche una biografia di Orbán.
Come spiega l’autore, Viktor Orbán nacque il 23 maggio 1963 a Székesfehérvár, ma passò l’infanzia e parte dell’adolescenza fra Alcsútdoboz e Felcsút, due villaggi a soli 40 chilometri dalla capitale, una “distanza geograficamente trascurabile ma culturalmente abissale” (p. 20). Il piccolo Viktor crebbe in una casa senza bagno né acqua corrente, cosa normale per i villaggi di allora. Una parte carente della prima parte della biografia di Orbán è quella dedicata alla violenza subita dal padre, che Bottoni definisce infatti un “padre padrone”, prendendo in prestito il titolo del famoso libro di Gavino Ledda. Sembra che i violenti pestaggi subiti dal padre abbiano contribuito a formare un carattere duro e coriaceo, ma personalmente esiterei a cadere nella banalizzazione psicologica. Nelle famiglie rurali di allora picchiare i figli era cosa del tutto comune (senza contare che questa banalizzazione è stata fatta da qualche biografo anche per Stalin). Sia come sia, il giovane Orbán si trasferirà poi a Budapest per studiare, venendo a contatto con un mondo più ampio e con la politica, sino a fondare il partito Fidesz (all’origine un movimento giovanile) del quali oggi è il leader assoluto.
Ma come si formò l’ideologia del giovane Orbán? Come è giusto notare, nessuna ideologia nasce dal vuoto, nel senso che anche quelle ideologie che si presentano come le più nuove e dirompenti hanno sempre radici in qualcosa di precedente. Il Fidesz delle origini era certamente fortemente anticomunista, e voleva farla finita con la dipendenza sovietica dell’Ungheria. Lo si potrebbe definire liberale, ma un liberalismo diverso da quello noto, più nazionale. Tant’è che, come ebbe a dire Orbán nel 1994, tendeva ad evitare il termine liberale, “perché nelle campagne non mi capiscono” (p. 40).
Oltre a questi elementi, Bottoni insiste molto sull’influenza del kádárismo, cioè l’assestamento portato da János Kádár fra il 1956 e il 1988. Il kádárismo, noto anche come "sistema Kádár" (Kádár-rendszer) fu un sistema di governo basato sulla sicurezza e sul compromesso, sulla cooptazione, e sulla concessione di limitati spazi di dissenso. Come voleva il famoso motto kádáriano, “Chi non è contro di noi è con noi”. Sicurezza, nel senso di sicurezza sociale ed economica, con salari magari non elevati ma sicuri, la tranquillità nel domani e nell’avere una pensione, tutti “lussi” che nell’Ungheria capitalista sono andati in gran parte perduti. In un certo senso il sistema Orbán, da lui stesso battezzato “Sistema di cooperazione nazionale” (non vi ricorda un po’ il corporativismo fascista?) si basa sulla convinzione, o meglio sull’illusione, di aver raggiunto un paragonabile grado di sicurezza. Come spiega bene Bottoni, però, le cose vanno ben diversamente.
Chiaramente, questo paragone con il socialismo reale ungherese va bene sino a un certo punto, nel senso che tutti i paragoni storici hanno senso se sono parziali. Un difetto riscontrabile più volte nel libro è che l’autore, da fervente anticomunista, tratta il “comunismo” come una specie di malattia fisica, una caratteristica corporea che una volta entrata nell’organismo vi rimane vita natural durante. Quindi, qualunque esponente del regime comunista riciclatosi nel capitalismo rimane sempre e comunque un “comunista”. Anche se certamente i rivolgimenti politici dell’Ungheria post-’89 rappresentano un ottimo esempio di gattopardismo, questo approccio è sicuramente sbagliato. Il comunismo è un’"ideologia" come le altre, e in quanto tale il termine va utilizzato in base alle idee professate e al comportamento mostrato in ogni singola epoca storica. Non sempre i comunisti sono “eterni” (anche se questo errore viene spesso commesso anche da noi: quante volte sulla stampa e nel senso comune si sentono nominare come “comunisti” Veltroni, D’Alema, Bersani?).
L’ORBANISMO
A parte somiglianze parziali, vediamo nel dettaglio che tipo di sistema Viktor Orbán è riuscito a creare. Bottoni usa vari termini nel libro, ma sono tutti utili per capire il succo del sistema.
Il sistema creato da Orbán è un sistema di turbo-capitalismo ultraneoliberista, autoritario, autocratico, paternalistico, neonazionalista e neofeudale.
Il turbo-capitalismo e l’ultraneoliberismo sono fondamentali per capire il sistema. L’Ungheria è infatti un piccolo paese (circa 10 milioni di abitanti) estremamente dipendente dal capitale straniero, soprattutto dal capitale finanziario, bancario e delle multinazionali. In un certo senso, l’Ungheria è un po’ il paradigma della colonizzazione che il capitalismo occidentale ha portato nell’Europa dell’Est dopo il crollo dell’URSS (1).
Dando qualche dato, si può vedere come l’Ungheria soffrisse e soffra una situazione di colonialismo capitalistico occidentale anche peggiore rispetto ad altri paesi dell’area. Bottoni arriva a definire “brutale” la dipendenza ungherese dalle multinazionali, dato che controllano oltre la metà dell’economia: il 54%, e il tasso è in crescita. La cifra per la Slovacchia è il 48, 44 per la Romania, 43 per Repubblica Ceca e 37 per Polonia. La media Europea è 25%, e l’Italia ha il 15, al penultimo posto.
Questa estrema dipendenza è pericolosa in quanto rende il paese molto esposto ai rischi di crisi globali. Nel 2009, quando il paese era in preda alla crisi, le multinazionali reinvestivano in Ungheria solo un terzo del profitto, mentre in Slovacchia o in Repubblica Ceca la cifra era 50-60% (p. 138).
Per citare le parole di Bottoni: “Quello che molti osservatori chiamano Orbánomics è quindi, al netto della retorica patriottarda e antioccidentale, una variante del turbocapitalismo delle semiperiferie europee retta dal nuovo garante autoritario di un modello (neo)liberale che nessuno, in Ungheria, ha mai seriamente contestato negli ultimi decenni”.
E qui ci dispiace, ma dobbiamo dissentire. È vero che questo modello non è stato mai criticato quasi da nessuno, ma ci sono state importanti eccezioni, come l’intellettuale marxista Gáspár Miklós Tamás, e alcune piccole, debolissime formazioni di sinistra che ultimamente mostrano una timida ma incoraggiante crescita. Dobbiamo anche dissentire dall’affermazione secondo la quale, pur con tutti i rischi denunciati, le multinazionali portino in Ungheria “cultura del lavoro” (p. 243). Avendo lavorato personalmente nelle multinazionali in Ungheria, posso dire che l’affermazione è totalmente infondata e ha dell’assurdo. Queste aziende vengono in Ungheria come in un ambìto terreno di caccia dove possono pagare tasse bassissime. Non solo, ma “lo Stato ungherese arriva a finanziare investimenti produttivi nella misura di un terzo del valore totale, liberando l’impresa straniera dal rischio di perdite” (p. 244-45).
Inoltre, le aziende straniere si trovano nella comoda condizione di poter pagare stipendi abbastanza buoni per l’Ungheria, ma molto più bassi che in Occidente. Ultimo, ma non per importanza, la manodopera ungherese è in gran parte docile e non sindacalizzata, in parte per mancanza di cultura sindacale nel privato, in parte perché un codice del lavoro iperoppressivo e il dispotismo aziendale rendono spesso impossibile l’organizzazione di qualunque cellula sindacale. Puoi sempre tentare, ma quasi sicuramente ti aspetta il licenziamento (la pratica è comprovata). Inoltre, i lavori delocalizzati in Ungheria sono quasi sempre quelli meno qualificati e che richiedono la tecnologia meno costosa (spesso dei computer scassati con i quali è quasi impossibile lavorare). Pertanto, dire che le multinazionali portano in Ungheria “cultura del lavoro” è semplicemente falso (così come è falso dire che vengono in Ungheria “per la qualità del servizio”, come mi disse una volta un manager rampante per prendermi in giro).
Di “cultura del lavoro” si potrebbe forse parlare a una donna dipendente di una multinazionale recentemente morta suicida. Era sola e aveva un figlio piccolo. Non siamo in grado di sapere quasi niente sui motivi che l’hanno spinta a commettere quel gesto, ma dà da pensare il fatto che i suoi colleghi sono terrorizzati e non hanno accettato di dire sul fatto che poche parole: “Aveva dei problemi psicologici pregressi, ma l’ambiente di lavoro ha aiutato a peggiorarli”. Questo è sintomatico, e ci autorizza a dire che questa povera donna è stata uccisa dal capitalismo. Probabilmente ci si è affrettati a seppellirla, ma è bene che ne si seppellisca anche il ricordo. Del resto, se non ci fosse niente da nascondere, perché i suoi colleghi dovrebbero essere terrorizzati, perché dovrebbero avere paura di parlare? Purtroppo, sul lungo andare, una persona debole e magari con problemi pregressi può non reggere l’atmosfera di terrore, di dispotismo, e di controllo ipertecnologico che regna in molte multinazionali, che sono per certi versi ben peggiori della fabbrica fordista. Nella fabbrica fordista il controllo sul lavoro era affidato al fattore umano, per sua natura imperfetto e fallibile. L’informatica invece è infallibile, matematica, non sbaglia mai.
Per riassumere, Orbán basa il suo sistema di cooperazione nazionale su qualche nazionalizzazione cosmetica (come si è visto, irrilevante nel quadro totale) e su delle politiche effettivamente doverose che la cosiddetta “sinistra liberale” non ha mai fatto né potrebbe mai fare, come il soccorso a centinaia di migliaia di ungheresi messi sul lastrico dai mutui in valuta estera nel 2011 (p. 163).
Il sistema è inoltre basato su misure propagandistiche in apparente sostegno delle famiglie ma di impatto in realtà assai marginale, come gli sgravi fiscali alle famiglie con tre o più figli (il che significa che ben il 90% delle famiglie ne restano tagliate fuori, per non parlare degli individui soli e delle persone senza casa – p. 246). Questo a fronte di un generalizzato, reale massacro alla spesa sociale. Ecco cosa ha causato il “darwinismo sociale di impianto neoliberista” di stampo orbániano:
«Il codice del lavoro introdotto nel gennaio 2012 avviò il taglio dei sussidi di disoccupazione, rimpiazzati dai lavori socialmente utili [secondo alcuni, in realtà, una forma mascherata di lavoro forzato, ndr], e la brutale revisione delle pensioni di invalidità, oltre a congelare per anni i salari e indicizzare le pensioni. La politica del governo rinunciava al carattere universale dell’assistenza statale per trasformare i benefici (ad esempio le esenzioni fiscali alle famiglie numerose) in un welfare settoriale e altamente discrezionale. Nel ciclo di governo 2010-’14 la pubblica amministrazione, l’educazione e la sanità subirono tagli di bilancio pari, in valore reale, al 30-40 per cento. Il fondo ordinario destinato alle università, pari nel 2009 allo 0,85 per cento del Pil, crollò nel 2013 allo 0,56 per cento, collocando l’Ungheria all’ultimo posto fra i paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.» (p. 165).
La cosiddetta “sinistra” ungherese, d’altra parte, “aveva abdicato alla rappresentanza dei ceti popolari, lasciando un vuoto che altre forze si affrettarono a colmare. I difensori del Fondo Monetario o delle multinazionali commettevano dunque un suicidio politico al di là della legittimità dei loro argomenti giuridici” sugli effettivi attacchi che Orbán portava allo stato di diritto. Nonostante le “dure politiche di austerità mai annunciate ma puntualmente attuate,” Orbán poté “porre le basi di un nuovo consenso nazionalconservatore e antioccidentale” (p. 166).
Bottoni sottolinea anche il paradosso della cosiddetta “Europa democratica”, che sebbene critichi Orbán a parole per le sue gravi violazioni alla democrazia, di fatto lo tiene in sella, perché la sua spietata austerità e l’ambiente favorevole per gli investimenti stranieri sono una manna, specialmente per la Germania.
Oltre quindi ai descritti legami con il capitale straniero, Orbán si è anche curato di creare una oligarchia nazionale a lui fedele, che quando è necessario fagocita imprese preesistenti con delle “nuove pratiche”.
Vediamo cosa iniziò a succedere dopo il 2010, l’anno della prima delle tre vittorie consecutive di Orbán:
«Grandi e medi imprenditori venivano avvicinati da faccendieri e uomini d’affari vicini al partito con un’offerta «irrinunciabile»: cedere la proprietà e la partecipazione a prezzi inferiori a quelli di mercato, o entrare nella spirale dei controlli fiscali. In una parola, vedersi punito il rifiuto. Nel 2014 uno dei più innovativi imprenditori locali del settore informatico morì d’infarto il giorno dopo avere ceduto, in seguito a innumerevoli pressioni, i codici di un sistema informatico da lui brevettato. Il sistema imparò presto a mostrare il suo volto più spietato.» (p. 156)
Quello appena descritto è il lato macroeconomico del sistema orbániano, sicuramente fondamentale per capirne le basi. Ma, come acutamente ci mostra l’autore, c’è anche un altro lato, che potrebbe essere definito neofeudale, che presenta Orbán come una sorta di buon feudatario, o in alternativa come un dittatore benevolo e paterno (vi ricorda qualcuno?), circondato da un certo culto della personalità.
Osserviamo il resoconto di una surreale visita fatta da Orbán nel 2017 in un villaggio sul confine rumeno:
«“Zia Bözsi”, come la chiamano in paese, mostra orgogliosa al primo ministro la sua modesta dimora. Senza lamentarsi, osserva con arguzia che «non sarebbe male votare tutti gli anni, perché quando arrivano le elezioni la pensione aumenta sempre di un poco». «E io gliela aumento?» chiede Orbán. «Certo, stavolta abbiamo avuto un aumento dell’1,6 per cento, ottimo». «E le ho anche mandato un buono spesa, vero?» aggiunge Orbán. «Come no, ho ricevuto diecimila fiorini» (circa 30 euro). «E alla fine dell’anno, se i conti saranno a posto, la aumenterò nuovamente» conclude soddisfatto il primo ministro, prima di passare in rassegna il bestiame (p. 218).»
Come dice Bottoni, questo episodio ritrae la trasformazione dello Stato in un feudo personale.
Per concludere questo breve riassunto sul sistema orbániano, sono necessarie alcune considerazioni. Come si accennava all’inizio, pur essendo un fervente anticomunista, l’autore del libro ci ha presentato una descrizione compatibile con i canoni marxisti. Forse, l’amore per il suo popolo (non esagerato né eccessivamente sciovinista) gli ha permesso di fare ciò che la cosiddetta “sinistra liberale” ungherese non è in grado di fare, cioè di fare un’analisi critica della storia recente del suo paese per capire il male dell’orbánismo e le sue radici. Non è forse superfluo aggiungere che lungo tutto il libro Bottoni fa ampio uso di categorie gramsciane per definire l’operato di Orbán: da un’ossessiva conquista di sempre più casematte per ottenere l’egemonia, fino al ruolo di vittime destinato alle classi subalterne. Eppure, Bottoni non cita Gramsci neanche una volta. Lo possiamo prendere come un complimento, dato che si dice che il maggior successo delle idee di un autore è mostrato quando vengono usate spontaneamente, senza citazioni (tra parentesi, Orbán utilizzò Gramsci nella sua tesi di laurea per studiare la struttura autorganizzata del sindacato polacco Solidarnosc).
LA POLITICA ESTERA DI UN SATRAPO ORIENTALE
Certamente, fa conto di spendere qualche parola sulla politica estera di Orbán perché, anche qui, la puntuale analisi di Bottoni riserva delle sorprese, e ci mostra che abbiamo di fronte un opportunista e un trasformista di rara abilità, capace di sfruttare ogni occasione, guadagnando dai “litiganti” più diversi.
Prendiamo il rapporto con gli Stati Uniti. Nel luglio 2014 Orbán pronunciò un violento discorso dove parlava esplicitamente della necessità di instaurare un regime illiberale, e questo aveva intimorito lo Zio Sam, che temeva che Orbán si fosse montato troppo la testa e che non fosse sufficientemente affidabile. Detto fatto: il Dipartimento di Stato USA entrò in azione mandando a Budapest André Goodfriend,
«un diplomatico con esperienza in aree di crisi come Russia e Siria. Goodfriend era stato inviato a Budapest dal Segretario di Stato Hillary Clinton come incaricato d’affari. Nel corso del 2014, sull’onda dell’aggressione russa in Ucraina e l’intensificazione della presenza russa in Europa centrale, l’amministrazione Obama iniziò a esercitare pressioni su Budapest con strumenti che andavano dalla lusinga alle combinazioni operative tipiche degli apparati di intelligence. Goodfriend si mosse in questo gioco con consumata abilità, partecipando alle manifestazioni dell’opposizione, ingaggiando siparietti con imbarazzati funzionari del governo e minacciando di «rivedere i rapporti di alleanza», poiché «la mancanza di freni e controlli sull’esecutivo» contribuiva «alla crescente corruzione che minaccia la democrazia».
Le minacce del “buon amico” inviato a Budapest dal Dipartimento di Stato si concretizzarono in ottobre con un provvedimento irrituale nel caso di un alleato Nato: il divieto di ingresso negli Stati Uniti per sei ufficiali ungheresi.» (p. 193).
Eppure, alla fine fu Orbán a spuntarla. Nel dicembre 2014 fu nominata ambasciatrice americana a Budapest Colleen Bell, una presentatrice televisiva tanto affascinante quanto incompetente in tema di Ungheria e di affari diplomatici (p. 195). È evidente che con questa nomina di basso profilo gli USA vollero rassicurare Orbán: stai tranquillo, forse ci possiamo anche mettere d’accordo (da buoni mafiosi). Infatti, a Washington si era deciso che era meglio lasciar perdere i piani di regime change: non ci avrebbero guadagnato, perché l’opposizione era altrettanto corrotta e screditata, e probabilmente incapace di garantire stabilità.
Passato il testimone da Obama a Trump, è interessante notare il ruolo di quest’ultimo nella violenta campagna di Orbán contro la CEU (Central European University), una prestigiosa università fondata da George Soros negli anni ’90 e critica verso il regime. Con una mossa quasi unica nella storia europea contemporanea (cose simili sono state fatte solo nella Bielorussia di Lukashenko e nella Svezia occupata dai nazisti), nel 2017 Orbán approvò una legge ad hoc, la Lex CEU, per impedire il rilascio delle lauree e costringere così la CEU a lasciare il paese. In parte l’intento è già riuscito, perché la CEU è stata costretta a trasferirsi parzialmente a Vienna, e il trasloco potrebbe diventare pressoché totale in futuro. Come è noto, fra Trump e Soros non è mai corso buon sangue, dato che il miliardario ungaro-americano è sempre stato avversario del presidente USA. Ciononostante, con la sua legge ad hoc Orbán toccava un’istituzione americana, facendo quindi uno smacco agli USA. Guardiamo come si è comportato Trump: per carità di patria, si è pubblicamente espresso contro il diktat di Orbán (a parole, appunto). Allo stesso tempo, nell’estate 2018 mandò a Budapest un nuovo ambasciatore, l’uomo d’affari David Cornstein, tra l’altro suo amico personale. La nomina era pensata esplicitamente per migliorare i rapporti fra USA e Ungheria e, in effetti, il comportamento di Cornstein mostrò che i rapporti fra Trump e Orbán non potevano essere migliori (del resto, i lobbisti di Orbán avevano lavorato a lungo per ottenere una nomina gradita).
«Cornstein incontrò Orbán e gli chiese un gesto di disponibilità sul caso CEU, offrendo tuttavia a Budapest una via d’uscita in caso di rifiuto: ammorbidire il veto sull’avvicinamento alla NATO dell’Ucraina (questione sulla quale Orbán pagava pegno a Putin) e acquistare forniture militari americane”.» (p. 229-30)
Pertanto, l’abile diplomazia di Orbán, apparentemente servo di tanti padroni ma che in casa sua riesce sempre a fare quello vuole, riuscì a far abbandonare la CEU al proprio destino. A nulla servirono neanche gesti di apertura, se vogliamo anche umilianti, da parte della CEU (e infatti criticati da alcuni studenti esterrefatti), come invitare Cornstein a tenere un seminario.
Per quanto riguarda la Russia invece, oggi sembra quasi assurdo affermarlo, ma Orbán non è sempre stato filorusso e filoputiniano. Anzi, ai suoi inizi in politica, lui come tutti i movimenti ungheresi nuovi o finti nuovi doveva ostentare diffidenza se non ostilità verso il paese erede della odiata URSS. Paradossalmente, prima i filorussi erano quelli della sinistra liberale di Ferenc Gyurcsány. La svolta filorussa di Orbán avvenne poco prima delle elezioni del 2010 e, come giustamente dice Bottoni, mescolò le “spinte ideologiche ai calcoli di bottega” (p. 185).
Certamente ci sono molti punti di contatto tra i due regimi: un certo "celodurismo", un’antipatia per l’Occidente in quanto tale, tradizionalismo e fondamentalismo cristiano, omofobia, ecc. Ma questa è più una sovrastruttura. Andando invece alla “ciccia” strutturale, gli oligarchi ungheresi che Orbán mandò a Mosca a studiare la situazione rimasero piacevolmente stupiti dalla verticale di potere e dall’efficiente autoritarismo capitalistico che Putin era riuscito ad instaurare. Gli oligarchi erano stati messi in riga, e quelli riottosi morti, in galera o all’estero. Gli altri rivestivano certo un ruolo importante, ma che doveva essere subordinato all’autorità del potere statale, pena la caduta in disgrazia (che può comportare conseguenze assai sgradevoli).
Come si vede, Orbán ha cercato di riprodurre nel suo paese un sistema di selvaggio capitalismo oligarchico probabilmente ispirato anche alla Russia di Putin.
Un ultimo punto che vale la pena menzionare sui rapporti internazionali del regime orbániano sono gli ottimi rapporti con Israele. La cosa ha dell’incredibile, se si pensa che l’antisemitismo in Ungheria è sempre stato molto radicato e piuttosto trasversale, in un modo che non ha paragoni in Italia (“certo, in Italia non ci sono ebrei”, ebbe una a volta a dirmi un neonazista ungherese). Bottoni definisce “poco circostanziate” (p. 238) le accuse di antisemitismo fatte a Fidesz, eppure questo sentimento è certamente presente nel partito di Orbán, come in altri. Non è poi del tutto vero, come dice Bottoni, che nella “rappresentazione del nemico, la vera o presunta fede ideologica e la visione del mondo (globalista, filoeuropea, post-nazionale) si sostituisce agli elementi biologici del razzismo antisemita. George Soros non viene colpito in quanto ebreo ma in quanto avversario ideologico” (p. 241). Mi dispiace dissentire, ma qui il discorso è molto più sottile.
È vero che, probabilmente, Orbán non ha mai attaccato apertamente Soros con insulti razzisti (niente “sporco ebreo” nei suoi discorsi, quindi). Ma guardate i manifesti con i quali Budapest era tappezzata fino a poco tempo fa. Questi manifesti sono paradigmatici del difficile ambiente che cerco, con fatica, di spiegare. Lo slogan governativo di questi manifesti dice: “Non lasciamo che Soros rida per ultimo”, accompagnata dall’immagine di un ghigno malefico. Un possibile sottotesto di lettura è “l’ebreo che ride”, un’espressione hitleriana che si riferiva ai malefici ebrei che sghignazzano mentre ti fottono (2). Come si vede, non c’è un esplicito insulto razzista, ma un possibile sottotesto che dà da pensare. Da aggiungere che alcuni solerti patrioti hanno pensato bene di aggiungere su questi manifesti, in qualche caso, ciò che nel messaggio stampato si era perso: "büdös zsidó" (sporco ebreo).
Ma con tutto questo, come è possibile che Orbán intrattenga rapporti così buoni con parte della comunità ebraica ungherese e con Israele? Ancora una volta, siamo di fronte alle grandi abilità di un puparo opportunista. Infatti, dalla “fine degli anni Novanta, Viktor Orbán infuse pragmatismo e visione strategica nel rapporto con l’ebraismo ungherese e lo Stato di Israele, mediante la costruzione di una sinergia con il partito conservatore Likud di Benjamin Netanyahu” (p. 239). Una precisazione necessaria è che l’espressione “comunità ebraica”, in Ungheria come altrove, è un’astrazione. Sotto questa etichetta infatti si nascondono persone, organizzazioni, comunità molto diverse: persone di destra e di sinistra, credenti e non, praticanti o meno, assimilati, ecc. A Orbán infatti interessava una parte particolare di questo variegato mondo: “l’ebraismo ortodosso per condurre la battaglia ideologica interna contro la sinistra liberale”.
Cito ancora Bottoni:
«Nel dicembre 1998, Orbán fu il primo capo di governo ungherese a promuovere la celebrazione pubblica del Hanukkah ebraico […] Negli anni successivi, il rapporto di Fidesz e di Orbán con l’ebraismo religioso ungherese si sarebbe consolidato tramite il sostegno del partito al rabbino Slomó Köves, a capo della sezione ungherese della comunità ortodossa Chabad-Lubavitch. Nel 2018, la comunità di Köves ha ottenuto in gestione dallo Stato una piccola università privata, precedentemente vicina ai socialisti, e l’ha ribattezzata «Milton Friedman», in onore dell’economista che guidò la controrivoluzione antikeynesiana della Scuola di Chicago. L’appoggio di Orbán a una causa non è mai disinteressato. Chabad-Lubavitch godeva di importanti ramificazioni negli Stati Uniti e in Israele. Orbán trasformò una questione religiosa in una causa ideologica e geopolitica […] Israele giocò un ruolo chiave in questa vicenda in quanto con l’arrivo al potere di Netanyahu, nel 2009, Gerusalemme iniziò a sostituire il rapporto privilegiato con il centro-sinistra ungherese a una collaborazione pragmatica con Orbán.» (p. 239).
Insomma, Orbán si presentò a “Israele come garante dei suoi interessi in Europa centro orientale, nella qualità di leader politico dell’unico paese della regione che ospita ancora una grande comunità ebraica”. Si trattò di una grande “convergenza di interessi. La presenza economica israeliana in Ungheria è rilevante sin dagli anni Novanta e i rapporti fra i due paesi non sono mai stati così intensi come negli ultimi anni”.
Ecco i dati di un rapporto solidissimo: dieci miliardi di euro di investimenti israeliani in Ungheria, oltre un decimo del totale dei capitali investiti nel paese. Migliaia di cittadini israeliani possiedono beni immobili a Budapest e considerano l’Ungheria un rifugio in caso un conflitto militare li costringa a lasciare il proprio paese. Non è poi un segreto che la cooperazione bilaterale si sia recentemente estesa al settore militare e della sicurezza nazionale (p. 239-40).
Un ulteriore elemento da aggiungere a questo quadro fra il surreale e il teatro dell’assurdo è l’ossessiva politica di manipolazione storica portata avanti dal governo Orbán sullo sterminio degli ebrei ungheresi. Oggi è noto che la deportazione degli ebrei ungheresi nei campi di concentramento fu possibile grazie alla collaborazione delle autorità civili e militari ungheresi: funzionari statali, esercito, polizia, ecc. (paradigma del resto non dissimile da quanto avvenuto in altri paesi europei, inclusa l’Italia). Inoltre, le deportazioni iniziarono con Horthy, e continuarono durante l’effimero regime delle Croci Frecciate, in vigore per circa l’ultimo anno di guerra (3). Invece, la falsificazione ufficiale dell’orbánismo presenta le deportazioni come esclusiva responsabilità dell’”occupazione” tedesca (occupazione tra virgolette, dato che l’Ungheria mantenne il proprio governo e le proprie rappresentanze all’estero) e dei suoi collaboratori, le Croci Frecciate appunto. Così, tutta la responsabilità dell’horthyismo e degli ungheresi è sciacquata via. L’Ungheria nella sua totalità è presentata come vittima innocente dell’invasore straniero, come esemplificato dal Memoriale per le vittime dell'occupazione tedesca, a Budapest. Questo monumento, inaugurato alla chetichella nel 2014 tra una pioggia di frutta e uova marce, è dedicato “alle vittime dell’occupazione tedesca”. L’Ungheria è rappresentata da un immacolato e innocente angelo, mentre la Germania occupante è l’orrida aquila che lo vuole aggredire. Da aggiungere che l’horthyismo è stato ormai completamente sdoganato: non lontano dal monumento si erge un busto di Horthy, su una scalinata privata ma rivolto all’esterno.
In sostanza, questo enorme paradosso è che Orbán è riuscito a comprarsi l’appoggio della parte più retriva di una comunità, la quale però è stata vittima nel passato recente di un immondo tentativo di sterminio al quale gli ungheresi hanno attivamente collaborato. Ma quella collaborazione è adesso cancellata, e il barile è stato prontamente scaricato sullo “straniero”.
Ma chi ha perso in questo mercato delle vacche? Ha perso l’ebraismo moderato, gli ebrei laici, progressisti e di sinistra. Per non parlare dei palestinesi, la cui tragedia gode di poca solidarietà in Ungheria, anche perché spesso le iniziative propalestinesi sono frequentate da neonazisti, cosa che ovviamente le scredita. Fortunatamente, alcuni piccoli gruppi di solidarietà e di sinistra portano avanti un’opera di sensibilizzazione, fra accuse e indifferenza generale. Uno dei tanti paradossi della situazione? In occasione dell’ultimo anniversario della Nakba, il Radical Student Collective (un collettivo di studenti di sinistra della succitata università CEU) organizzò la proiezione del documentario di Al Jazeera “The Lobby”, sulla lobby israeliana negli Stati Uniti (disponibile su Youtube) (4). Anche se poco partecipato, l’evento ebbe comunque una storia travagliata: i bravi studenti chiesero inizialmente un’aula che venne regolarmente assegnata, salvo vedersi tolto in seguito il permesso prima accordato. Sia come sia, la proiezione ebbe luogo, con regolari articoli di giornali il giorno dopo, secondo i quali “nell’università di Soros era stato proiettato un film antisemita” (sic!). A rispondere a simili attacchi sui social toccò a uno degli organizzatori, un giovane ebreo americano che studia gli anarchici ebrei newyorkesi, e che ha imparato da grande un po’ di ebraico e di yiddish (sia detto tra parentesi, molto somigliante a Trotsky, con tanto di capigliatura – bionda però – e lenti tonde). Ah, sei ebreo? “Allora sei un ebreo che ha interiorizzato i concetti dell’antisemitismo”!... Come si vede, la questione non è semplice.
INTERNAZIONALISMO PROLETARIO: UTOPIA O SPERANZA?
Infine, un importante punto di disaccordo con Bottoni può darci un segnale di speranza rispetto al futuro della lotta di classe in Ungheria e nel mondo.
Benché all’inizio l’autore giustamente critichi un internazionalismo proletario illusorio e solo a parole (p. 38), in altre parti del libro ci dà dei magnifici esempi di internazionalismo proletario della nostra epoca, pur senza considerarlo tale. Non dobbiamo stupirci. Non possiamo aspettarci che un autore non marxista riconosca ai lavoratori una propria "agency", come dicono gli storici americani (cioè una sorta di autocoscienza e una propria capacità di azione autonoma).
Vediamo come alcuni lavoratori ungheresi, organizzatisi e coalizzatisi coi loro compagni di altri paesi, riescono a far fronte a uno dei regimi di sfruttamento peggiori d’Europa:
«Nel gennaio 2019, diecimila addetti dell’impianto Audi di Györ, che insieme all’indotto produce il due per cento dell’economia ungherese, sono scesi in sciopero sostenuti dalle organizzazioni sindacali tedesche, preoccupate per l’eccessiva forbice salariale fra gli stabilimenti domestici e quelli delle periferie orientali. A differenza dei manifestanti che, nel dicembre 2018, misero brevemente sotto assedio il Parlamento e la televisione di Stato dopo l’approvazione della discussa legge sulle 400 ore annue di straordinari obbligatori, le maestranze dell’Audi avevano un obiettivo concreto: un importante aumento salariale infine raggiunto. La vicenda ha mostrato la necessità di rivitalizzare un movimento sindacale fiaccato da decenni di impotenza e collaborazionismo. Se il sistema continua a ignorare il conflitto sociale, Orbán rischia di ritrovarsi di fronte al suo «paese reale». Un paese in cui lo Stato si è dimenticato dell’esistenza dei servizi pubblici essenziali, dalla scuola alla sanità, per non parlare del diritto alla casa.» (p. 247)
Come vediamo, Bottoni riconosce che in Ungheria ci sono alcuni potenziali germi di lotta di classe (che lui chiama “conflitto sociale”). La cosa più straordinaria dell’episodio sopra raccontato è che gli operai ungheresi si sono coalizzati con i sindacati di un altro paese (tutti sappiamo che è una cosa difficilissima). Non solo, ma hanno anche vinto!
Proviamo a fare il confronto con l’Italia: quando siamo riusciti a organizzare l’ultimo sciopero conclusosi con una vittoria? Questo è un episodio in linea con l’internazionalismo proletario odierno, analizzato dallo studioso olandese Marcel Van Der Linden (e i suoi studi potrebbero essere utili anche a noi).
Un segnale positivo e parziale, quindi, assolutamente da non ignorare. Come dice Bottoni, se Orbán continua a massacrare i lavoratori come sta facendo adesso, potrebbe davvero andare a sbattere contro il suo paese reale, e l’urto potrebbe essere anche molto violento. Rispetto a un marxista, Bottoni ricorda un po’ il rapporto politico-intellettuale che Gobetti aveva con Gramsci e col gruppo dell’Ordine Nuovo: non marxista appunto, ma incapace di guardare la realtà ignorando completamente la classe lavoratrice.
Allo stesso tempo, non si possono nascondere le obiettive difficoltà: oltre ai tanti ostacoli oppressivi e all’indifferenza di molti lavoratori, il mondo sindacale ungherese non è per niente immacolato. So da un compagno attivo nei sindacati che nella base si incontrano facilmente razzismo, sessismo, omofobia (ricordiamo i grillini e i leghisti nella CGIL e nella FIOM?). A chi scrive è una volta capitato di rivolgersi al presidente di un sindacato che si definiva ispirato alla dottrina sociale della Chiesa, per poi scoprire che si trattava di una specie di neonazista (“froci, zingari, ebrei fanno schifo…”). Nonostante questo, ci sono anche altri piccoli segnali positivi: sappiamo da fonti riservate che i lavoratori della BKK (l’azienda di trasporti pubblici di Budapest, organizzata in modo incredibilmente efficiente, tanto da rendere Budapest la città europea con i trasporti migliori dopo Zurigo) cercano di organizzarsi in modo clandestino per sfuggire alle spie governative.
Ma guardiamo un altro episodio significativo. Fra le tante ipocrisie dell’orbánismo, Bottoni sottolinea quella sull’immigrazione. Osteggiata a parole, Orbán sa benissimo che all’economia ungherese servono braccia da altri paesi, per via di una mancanza di manodopera causata dal calo demografico e dal ben mezzo milione di ungheresi emigrati all’estero (contro 263.000 stranieri in Ungheria, p. 250). Ecco come “razze” diverse riescono a unirsi nella lotta:
«Nel marzo 2019 ha fatto scandalo il caso dello sciopero allo stabilimento dell’azienda sudcoreana Hankook di Dunaújváros, a 70 chilometri da Budapest, in cui lavorano tre gruppi rigidamente separati per status e mansioni: gli ungheresi, gli ucraini e, infine, i mongoli. Quando i lavoratori mongoli sono venuti a sapere che lo sciopero si era esteso dagli ungheresi agli ucraini, anche gli ultimi arrivati hanno tentato di incrociare le braccia nonostante i responsabili di reparto si aggirassero per lo stabilimento gridando «Mongol, work!» (‘Mongolo, lavora!’).» (p. 251)
Evidentemente, a volte la solidarietà tra lavoratori è più forte del razzismo e delle disgustose manovre padronali per dividerli. Gli ungheresi sono riusciti ad estendere lo sciopero agli ucraini, provenienti da un paese considerato comunque inferiore in quanto più povero e un tempo appartenente all’URSS. Ma i due gruppi, bianchi e in un certo senso europei, sono riusciti a coinvolgere anche i mongoli, degli asiatici extra-europei. Anche questo è un esempio magnifico che mostra che quando tutto sembra perduto, si può intravedere la luce dell’internazionalismo proletario in fondo al tunnel.
Note:
(1) Processo per la Russia spiegato da Giulietto Chiesa in un suo libro del 1997, Russia addio. Come si colonizza un impero, anche se Chiesa è ormai un autore assolutamente inaffidabile
(2) Vedi sul tema l'articolo del quotidiano israeliano Haaretz The 'Laughing Jew': The Nazi backstory of Hungary's anti-Soros poster campaign
(3) È proprio sotto le Croci Frecciate che si mosse Giorgio Perlasca, del quale Enrico Deaglio parla nel libro La banalità del bene. A Pelasca fu anche dedicato tempo fa uno sceneggiato, a dire il vero piuttosto scadente
(4) Vedi anche: John Mearsheimer e Stephen Walt, The Israel Lobby and US Foreign Policy, New York, Farrar, 2008