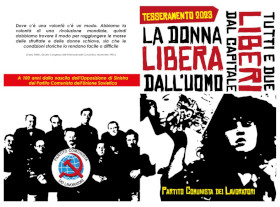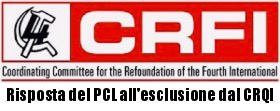Internazionale
Un confronto sulla questione cinese
9 Dicembre 2018
Il DIP (Devrimci Isçi Partisi, Partito Operaio Rivoluzionario di Turchia - sezione turca del CRQI) ha pubblicato recentemente un testo dal titolo "The character of war in 21st century: are China and Russia a target or a side of the war?" ("Il carattere della guerra nel XXI secolo: Russia e Cina sono un obiettivo o una parte della guerra?”) [1] a firma del compagno Levent Dölek.
Il testo affronta diverse questioni di carattere storico relativamente al posizionamento dei marxisti rivoluzionari di fronte alla guerra, ma si concentra prevalentemente sulla negazione della natura imperialista della Russia della Cina attuali, e di riflesso sul rifiuto di una posizione di disfattismo bilaterale nel caso di guerra tra USA, UE, Giappone da un lato, e Russia e Cina dall'altro. L'articolo si sofferma in particolare, con una scelta esplicita, sulla negazione del carattere imperialista della Cina considerando tale questione come paradigmatica di un metodo di analisi leninista.
Ci soffermeremo anche noi, convenzionalmente, su questo punto di analisi (la questione cinese) per argomentare la nostra critica alla tesi sostenuta dal DIP e motivare una diversa conclusione teorica e politica. Il tutto nello spirito di quel «dibattito importante e avanzato» che il testo del DIP formalmente propone «a coloro che adottino una posizione irreconciliabile nei confronti dell'imperialismo USA e dei suoi alleati». Naturalmente ci consideriamo tra questi.
LA TESI CENTRALE
L'articolo del compagno Levent Dölek premette alla negazione della natura imperialista della Cina attuale il richiamo alla teoria di Lenin dell'imperialismo moderno:
«Lenin spiega le caratteristiche della fase dell'imperialismo basata sul cambiamento strutturale del capitale e del capitalismo. [...] L'unificazione del capitale bancario e del capitale industriale ha creato il capitale finanziario, che è l'unità caratteristica del capitale imperialista. L'esportazione di capitale è diventata più importante dell'esportazione delle materie prime. [...] Nell'era dell'imperialismo, le grandi potenze definiscono l'atto di guerra e compiono la divisione territoriale del mondo. Tuttavia l'analisi dell'imperialismo richiede di fare distinzioni tra queste grandi potenze. Secondo Lenin, tra le sei grandi potenze che dividevano il mondo, Stati Uniti, Germania e Giappone erano giovani ed emergenti stati capitalisti (imperialisti), e Inghilterra e Francia erano i vecchi stati capitalisti (imperialisti). Con una struttura socio economica dominata da relazioni precapitaliste e circondata dalle moderne forze imperialiste capitaliste, la Russia era molto diversa dalle altre. Nel definire la posizione della Russia nella prima guerra mondiale come imperialista, Lenin ha sottolineato questa differenza cruciale. “In Russia l'imperialismo capitalista di ultimo tipo si è rivelato pienamente nella politica dello zarismo verso la Persia, la Manciuria, e la Mongolia, ma in generale in Russia predomina l'imperialismo militare e feudale”. Gli elementi del militarismo e del feudalesimo che dominavano l'imperialismo russo erano presenti anche nell'imperialismo ottomano. Tuttavia l'imperialismo ottomano era una semicolonia e non possedeva le caratteristiche distinte dell'imperialismo definito come la fase più alta del capitalismo. Pertanto né la Russia né l'impero ottomano possono essere visti come potenze imperialiste [...] Erano dipendenti dalle grandi potenze imperialiste e dunque occuparono una posizione secondaria [...] Di conseguenza l'imperialismo della Russia e degli ottomani assomigliava all'imperialismo dell'antica Roma piuttosto che all'imperialismo capitalista».
Dentro questa cornice teorica generale l'articolo colloca la definizione del ruolo attuale della Russia e della Cina:
«Un attento esame sia della Cina che della Russia mostra che il carattere delle loro economie non è definito dall'esportazione di capitali, ma dall'esportazione di materie prime. [...] L'economia cinese esporta sia beni che capitali ma ciò che è determinante nel caso cinese è l'esportazione di beni, non la caratteristica distintiva dell'imperialismo dell'esportazione di capitali. Ad esempio, l'esportazione di capitali da parte della Cina attraverso l'acquisto di porti e terminali è diversa dalla condotta del capitale finanziario che cerca manodopera a basso costo all'estero. I porti per la Cina non sono un mezzo per trasferire i profitti in eccesso acquisiti dal capitale attraverso lo sfruttamento di manodopera a basso costo. Piuttosto la Cina li usa per vendere merci al mondo, merci prodotte in Cina utilizzando la sua forza lavoro a basso costo. È come un'estensione della sua posizione nell'economia mondiale in qualità di primo paese esportatore che la Cina investe nei porti di tutto il mondo.»
L'articolo riconosce la presenza di capitale finanziario in Russia e Cina. Tuttavia afferma che:
«[...] quasi tutte le grandi società sono o società di proprietà statale o società per azioni in cui lo Stato è il principale azionista. [...] Possiamo osservare un modello di proprietà statale che non è compatibile con le tendenze classiche del capitale finanziario, specialmente quando si parla della Cina. [...] Mentre il capitale finanziario classico opera con il fine di massimizzare il profitto, le motivazioni politiche e burocratiche della Cina possono a volte far passare in secondo piano la redditività dell'investimento. [...] né la Russia coi suoi monopoli del petrolio e del gas, le sue banche statali, e i suoi oligarchi in continua crescita a causa del saccheggio dello Stato operaio, né la Cina col suo gigantesco ma prematuro capitale finanziario può costituire la base di una potenza imperialista.»
Infine l'articolo introduce un argomento relativo alle direttrici del flusso migratorio:
«[...] è impossibile per la Cina salire nella lega dei paesi imperialisti finché non cerca manodopera a basso costo al di là dei suoi confini, ma continua ad offrire salari tra i più bassi al mondo e rimane un paese in cui il capitale fluisce e da cui si muove la propria popolazione. A questo proposito dobbiamo ricordare che Lenin ha aggiunto anche il fenomeno migratorio agli indicatori dell'imperialismo.»
Come si vede, la tesi del DIP ha una sua organicità complessiva, che lega elementi teorici e storici e l'analisi della realtà presente. Ma gli elementi teorici sono distorti in funzione di un'analisi sbagliata e di una conclusione politica deviante. Vediamo di cosa si tratta.
LA TEORIA LENINISTA DELL'IMPERIALISMO NON SI PUÒ RIDURRE A UN SOLO ELEMENTO
Il compagno Dölek sottolinea formalmente a più riprese la complessità della teoria leninista dell'imperialismo, ma nel concreto ne fornisce una interpretazione riduttiva e impoverita.
Il primato dell'esportazione di capitali rispetto all'esportazione delle merci è sicuramente una caratteristica strutturale dell'imperialismo capitalista (vedremo poi l'applicazione di questo parametro alla Cina attuale), ma non è l'unico criterio indicato da Lenin. Il suo noto saggio del 1916 individua un insieme di fattori tra loro combinati sullo stesso terreno strettamente economico:
«Ai numerosi "vecchi" motivi della politica coloniale, il capitale finanziario ha aggiunto la lotta per le fonti di materie prime, per l'esportazione del capitale, per le sfere di influenza, cioè per sfere di accordi redditizi, concessioni, profitti monopolistici e così via, territori economici in generale.» (Lenin, L'imperialismo, fase suprema del capitalismo)
La stessa esportazione dei capitali è posta da Lenin in questo quadro complessivo. Da un lato essa riflette l'eccedenza di capitale nei paesi imperialisti («La necessità dell'esportazione di capitale è creata dal fatto che in alcuni paesi il capitalismo è diventato più che maturo e al capitale - data l'arretratezza dell'agricoltura e la povertà delle masse- non rimane più campo per un investimento redditizio»). Dall'altro, l'esportazione del capitale assume forme diverse e assolve molteplici funzioni tra loro combinate, ben al di là della pura caccia allo sfruttamento di forza lavoro a basso costo: «[...] apre nuovi canali per l'esportazione delle merci [...] accaparra terreni a buon mercato, salari bassi, materie prime a poco prezzo», si combina con contratti di rapina coi paesi soggiogati grazie all'uso dei prestiti usurai, imponendo spesso loro relazioni di monopolio, e occupa il terreno conquistato con piani di intervento e investimento che definiscono zone di influenza.
Non a caso Lenin si sofferma a lungo sul fenomeno dell'espansione delle ferrovie come direttrice dell'espansione imperialista e terreno di competizione tra gli imperialismi, laddove gli investimenti nelle ferrovie da parte dei paesi imperialisti trascinavano con sé la conquista dei paesi interessati e la loro assimilazione alla propria area di influenza.
Inoltre, a questi fattori prevalentemente economici dell'espansione imperialista Lenin aggiunge elementi sovrastrutturali da questi implicati, quali la politica di potenza e lo sviluppo del militarismo. Questi elementi, presi isolatamente, non sono sufficienti in sé - com'è ovvio - a definire la natura imperialista di uno Stato. Possono supportare infatti le politiche imperiali (non imperialiste) di stati feudali precapitalisti come, su altre basi, di Stati operai deformati. Ma su base capitalista sviluppata, e in congiunzione con l'imperialismo capitalista, la forza militare di uno Stato concorre a definire il suo grado di potenza imperialista, anche al di là della sua forza economica in senso stretto. Ad esempio la forza militare inglese, in particolare sui mari, rappresentò per lungo tempo un fattore di rallentamento e controbilanciamento del declino economico dell'imperialismo britannico. Lo stesso vale oggi per il militarismo soverchiante degli USA.
Naturalmente l'insieme di questi elementi (“economici, finanziari, militari”, come Lenin li classificava), i loro caratteri specifici, la loro connessione, il loro equilibrio variano da paese a paese e sono in costante mutamento, concorrendo per questa via a modificare i rapporti di forza tra gli imperialismi. In questo senso è interessante notare che all'interno della categoria generale dell'imperialismo, con le sue caratteristiche strutturali generali, Lenin distingue diverse tipologie particolari di imperialismo in base a differenti parametri di riferimento.
Distingue innanzitutto - come il compagno Dölek osserva - tra giovani imperialismi ascendenti (all'epoca la Germania, gli Stati Uniti, il Giappone) e vecchi imperialismi (Gran Bretagna e Francia). Ma non solo.
Lenin distingue anche tra “potenze” imperialiste (a loro volta differenziate per il proprio grado di potenza) e paesi imperialisti minori (Belgio, Olanda), laddove il ruolo preminente dei primi nella spartizione del mondo non preclude la natura imperialista dei secondi.
Distingue inoltre diverse forme di esercizio della dominazione imperialista: parla ad esempio di «imperialismo coloniale» per quanto riguarda l'imperialismo inglese, in quanto legato allo storico accaparramento di colonie oltremare, e di «imperialismo usuraio» per l'imperialismo francese, in quanto prevalentemente legato alla politica dei prestiti, con relativi condizionamenti, ricatti, intimidazioni nei confronti dei popoli soggiogati.
Infine parla di imperialismi che combinano al proprio interno i tratti del più avanzato e recente sviluppo con la persistente eredità di forme economiche arretrate precapitaliste. È il caso, all'epoca (in forme tra loro diverse), dell'imperialismo giapponese, dell'imperialismo italiano (“straccione”) ed anche dell'imperialismo russo.
LA RUSSIA ZARISTA: ARRETRATEZZA E IMPERIALISMO
L'analisi della natura della Russia zarista è sotto questo profilo importante, per comprendere il metodo di Lenin.
Il compagno Dölek sostiene che l'attribuzione a Lenin di una caratterizzazione imperialista della Russia zarista derivi da «un'errata lettura» dell'«enfasi» che Lenin poneva nell'azione disfattista contro «il carattere ingiusto e imperialista della guerra». Questa interpretazione ci pare riduttiva.
Nel suo scritto Il socialismo e la guerra, citato dal compagno Dölek, Lenin parla, è vero, del combinarsi in Russia dell'”imperialismo militare e feudale”, e dell'”imperialismo capitalista di nuovo tipo”, e considera il primo elemento ancora prevalente. Ma attenzione: prevalente dal punto di vista del suo peso ereditario (il regime politico zarista ancora in sella, e con esso l'aristocrazia fondiaria che ne costituiva il bastione), non dal punto di vista della tendenza trainante nella dinamica sociale della Russia. Il polo trainante di questa dinamica era a tutti gli effetti proprio l'”imperialismo capitalista di nuovo tipo”. Il combinarsi di arretratezza precapitalista e imperialismo moderno era espressione dello sviluppo ineguale e combinato della Russia, quello sviluppo ineguale e combinato cui fa riferimento lo stesso Trotsky sia negli scritti sul 1905 sia nella Storia della rivoluzione russa. Questo concetto è ben espresso da Lenin nel 1915, quando paragona l'imperialismo russo all'imperialismo italiano (“si somigliano”), proprio per il combinarsi in entrambi di arretratezza e sviluppo imperialistico moderno. O quando Lenin accosta, per la stessa ragione, imperialismo russo e imperialismo giapponese, sicuramente più sviluppato: la stessa posizione disfattista sostenuta dai bolscevichi nella Guerra russo-giapponese del 1905 fu al riguardo significativa.
Il medesimo concetto è ripreso da Lenin nel saggio sull'imperialismo del 1916. La Russia zarista è qui inserita tra le sei grandi potenze che si spartiscono il mondo - assieme a Inghilterra, Francia, Germania, Stati Uniti, Giappone - con una caratterizzazione specifica: « [...] la Russia, il [paese] più arretrato nei riguardi economici, dove il più recente capitalismo imperialista è, per così dire, avviluppato da una fitta rete di rapporti precapitalistici» (Lenin, L'imperialismo, fase suprema del capitalismo). La rete dei rapporti precapitalistici è l'eredità dell'arretratezza russa che ancora “avviluppa” il paese; “il più recente capitalismo imperialista” è la locomotiva del nuovo imperialismo russo.
Non a caso il saggio di Lenin si sofferma a più riprese proprio sullo sviluppo del capitale finanziario in Russia attraverso l'analisi delle grandi banche russe (banche a prevalente capitale tedesco, francese, inglese e banche indipendenti): «in Russia [...] con la formazione dei monopoli capitalistici si è sviluppata su scala immensa la fusione del capitale bancario con quello industriale».
Così Lenin pone la Russia in quinta posizione nella gerarchia tra i paesi imperialisti dell'epoca (dopo i quattro paesi capitalistici più ricchi, Inghilterra, Stati Uniti, Francia, Germania, ma prima di Italia, Giappone, Olanda, Belgio) per l'ammontare complessivo dei titoli finanziari detenuti (con riferimento ai dati del 1910), uno dei metri di misura dello sviluppo del capitale finanziario imperialista.
Infine Lenin colloca la Russia in seconda posizione tra le grandi potenze in fatto di possedimenti esteri (per milioni di km quadrati e di abitanti), subito dopo la Gran Bretagna, sia pure con notevole distacco, ma prima di Francia, Germania, Stati Uniti e Giappone. A maggior ragione prima di altri Stati imperialisti minori (Belgio, Olanda), le cui posizioni in campo coloniale erano dovute «soltanto grazie all'esistenza fra i grandi Stati di antagonismi d'interessi e di attriti, che impediscono un accordo per la divisione del bottino».
Importante in questo quadro generale la netta distinzione che Lenin fa - in ogni caso - tra la Russia e le semicolonie di Persia, Cina, Turchia. L'assimilazione indiretta di fatto tra Russia zarista e Impero ottomano che il compagno Dölek propone («né la Russia zarista né l'Impero ottomano possono essere considerate imperialiste, essendo entrambe dipendenti da grandi potenze») non trova riscontro nell'analisi di Lenin. Nella Russia zarista era sicuramente presente, in misura massiccia, capitale finanziario straniero, con un ruolo inevitabile di condizionamento negoziale e diplomatico (in particolare da parte della Francia, che usava questa leva sia verso la Russia che verso il Giappone), ma in nessun modo si può parlare di un'oppressione imperialista sulla Russia, come invece si poteva parlare di una oppressione imperialista sulla Turchia. I paesi semicoloniali come la Turchia sono per Lenin «un esempio di quelle forme di transizione nelle quali ci imbattiamo in tutti i campi, così della natura come della società. Il capitale finanziario è una potenza così ragguardevole, anzi si può dire così decisiva, in tutte le relazioni economiche ed internazionali, da essere in grado di assoggettarsi anche paesi in possesso della piena indipendenza politica». I paesi semicoloniali per l'appunto, non la Russia zarista.
IL RUOLO DELLO STATO NEL PASSAGGIO TRA FORMAZIONI SOCIALI
Se assumiamo i criteri posti da Lenin e li applichiamo all'analisi dell'imperialismo contemporaneo, è inevitabile arrivare a conclusioni molto diverse da quelle proposte dai compagni del DIP.
Se la Russia zarista era caratterizzata da Lenin come paese imperialista, sia pure col retaggio dell'arretratezza, come è possibile negare la natura imperialista della Russia e (soprattutto) della Cina contemporanee?
Naturalmente si tratta di imperialismi segnati da proprie specificità. Ogni imperialismo è del resto segnato - come abbiamo visto - da caratteri particolari legati alla propria formazione e parabola storica. A maggior ragione questo vale per imperialismi nati dal ceppo di Stati operai degenerati e deformati, quale ultimo sbocco della restaurazione capitalista in essi operata delle loro burocrazie dirigenti. La presenza importante dello Stato nell'economia - nella produzione, nelle banche, nei servizi - è sicuramente una traccia rilevante del passato sia in Russia che in Cina. In Cina si combina, come sappiamo, con la straordinaria continuità di un regime politico totalitario.
E tuttavia, paradossalmente, proprio l'eredità del passato staliniano e i forti tratti statalisti che ne conseguono hanno svolto e svolgono un ruolo centrale nello sviluppo imperialistico di questi paesi, in particolare della Cina.
Non è un caso.
Lo Stato ha assolto sempre storicamente una funzione decisiva nei processi di transizione tra diverse formazioni sociali. Fu così nei processi di accumulazione capitalistica originaria ai primordi della società borghese, e durante la stessa formazione degli stati nazionali. Fu così nello stesso processo di sviluppo capitalistico della Russia, dopo l'abolizione della servitù (1861), quando l'assolutismo zarista fu al tempo stesso l'ultimo baluardo della vecchia nobiltà e il primo fattore di accumulazione originaria capitalistico industriale in uno stretto intreccio col capitale finanziario europeo.
Così è stato anche nello sviluppo imperialistico di diversi paesi.
In Germania i poteri bonapartisti di Bismarck e il ruolo economico dello Stato (nazionalizzazione delle ferrovie) posero le basi di una transizione accelerata dall'unità nazionale allo sviluppo imperialista tedesco, consumatosi nell'arco di due decenni. Il passaggio di potere tra la vecchia aristocrazia prussiana degli Junker e la nuova borghesia capitalistico-finanziaria si consumò sotto l'ombrello dello statalismo.
In Giappone, nella fase del Rinnovamento Meiji, i poteri assoluti di uno Stato imperiale militar-feudale consentirono una transizione straordinariamente accelerata da una formazione sociale precapitalista all'imperialismo moderno, e successivamente impressero un ritmo eccezionale allo sviluppo storico di quest'ultimo. Le caste feudal-militari del Giappone si convertirono rapidamente nella nuova borghesia attraverso un processo di osmosi progressiva sotto il controllo dello Stato.
In Cina - in forme ovviamente diverse - abbiamo assistito, per alcuni aspetti, a un processo analogo. La centralizzazione assoluta dei poteri nelle mani dello Stato stalinista ha consentito a quest'ultimo di gestire dall'alto in tempi accelerati la restaurazione capitalista, e di rifondare la Cina su questa nuova base. La mutazione progressiva della vecchia casta burocratica nella nuova classe dei miliardari cinesi si è consumata nell'arco di trent'anni (dalle riforme economiche del 1978 di Deng Xiaoping sino all'ingresso nel WTO della nuova Cina capitalista del 2001). Lo stesso potere statale che ha diretto dall'alto la restaurazione capitalista oggi guida lo sviluppo imperialistico della Cina.
L'ESPORTAZIONE DEI CAPITALI DELLA CINA
Qui veniamo al cuore dell'argomentazione del compagno Dölek.
La tesi centrale secondo cui la Cina non è un paese imperialista perché l'esportazione di materie prime prevale sulla esportazione di capitali, perché l'esportazione di capitali non ha come fine lo sfruttamento di manodopera a basso costo, e perché l'esportazione di capitali segue finalità burocratiche e non di redditività, rappresenta una totale astrazione dalla realtà, e somma in sé diversi equivoci teorici.
Innanzitutto astrae dalla realtà.
La Cina sta invadendo il mondo attraverso l'esportazione di capitali. L'esportazione di capitali dalla Cina si è moltiplicata di ben quindici volte dai primi anni 2000. Questa esportazione di capitali apre anche varchi - come sempre - all'esportazione delle merci, ma l'aspetto centrale è l'esportazione di capitali, non di merci. Non a caso l'intera economia cinese ruota attorno allo straordinario sviluppo degli investimenti e al loro peso specifico sul Pil (oltre il 50%), superiore a quello di ogni altro paese al mondo. Investimenti interni, in particolare a ridosso della crisi capitalistica mondiale del 2008, per evitare di subirne gli effetti, che pur si sono avuti in termini di rallentamento dello sviluppo cinese; ma anche investimenti esteri, a misura dell'eccedenza dei capitali cinesi. L'enormità di questo processo e la sua incidenza sull'economia e sulla politica mondiale è talmente rilevante che appare incredibile rimuoverlo.
Ma in cosa consiste esattamente l'esportazione dei capitali della Cina, e in che forme essa si esprime?
La Cina esporta capitali con l'acquisizione di grandi spazi agricoli per produrre cibo da importare in Cina, ma soprattutto con l'acquisizione di giacimenti minerari in funzione dell'accaparramento di materie prime. A differenza degli USA, che sono ormai largamente autosufficienti dal punto di vista energetico, la Cina ha bisogno di andare a conquistarsi le materie prime necessarie al proprio sviluppo concentrato. Non l'”esportazione di materie prime”, ma l'accaparramento di materie prime in funzione (principalmente) della loro importazione e del proprio sviluppo capitalistico è caratteristica centrale della Cina odierna. Le materie prime in questione sono i tradizionali idrocarburi, ma sono anche e sempre più le nuove materie prime (litio, cobalto) necessarie allo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche, dove la Cina svolge un ruolo di prim'ordine nella competizione globale. Le immense distese di terra che la Cina ha accaparrato in Africa a prezzi stracciati sono funzionali innanzitutto allo sfruttamento di materie prime a basso costo. Lo sfruttamento a tal fine di manodopera locale è molto frequente, al punto da suscitare resistenze e proteste sociali (Zambia, Etiopia). A volte invece è rimpiazzato dallo sfruttamento di manodopera cinese direttamente esportata in loco dalla Cina, un'altra forma peraltro di esportazione di capitale (in questo caso “variabile”). Ma l'aspetto centrale in ogni caso è il saccheggio delle risorse naturali di paesi arretrati e dipendenti: ciò che Lenin indicava formalmente tra i caratteri strutturali dell'imperialismo.
In secondo luogo - ed è elemento centrale - la Cina esporta capitali attraverso la costruzione o l'acquisizione di infrastrutture. Strade, ferrovie, ponti, centrali elettriche, porti, centri logistici. Tali infrastrutture rappresentano anche vie di comunicazione di terra e di mare sulle quali far viaggiare le merci, e grazie alle quali raggiungere nuovi mercati o crearli dove non ci sono. Ma non si tratta solo di questo, a differenza di quanto afferma il compagno Dölek. Le infrastrutture rappresentano soprattutto uno strumento decisivo di conquista ed espansione di proprie aree di influenza, ai fini della dominazione imperialista. Infatti, come avviene in concreto questa esportazione di capitale? In due modi tra loro combinati. Da un lato, il capitale cinese acquisisce il controllo operativo, e i pacchetti azionari decisivi a tal fine, delle infrastrutture in questione, già costruite o in costruzione. Dall'altro, finanzia la costruzione delle infrastrutture con la concessione dei prestiti ai paesi interessati, i quali pertanto si indebitano con la Cina. Il debito pubblico verso la Cina di questi paesi ha raggiunto dimensioni enormi. E la Cina fa dell'indebitamento di questi paesi una leva decisiva per estendere il proprio controllo sugli stessi. Birmania ed Etiopia vengono assoggettati alla Cina per questa via, al pari di Angola, Zambia, Kenya. Lo Sri Lanka ha dovuto dare in concessione per novantanove anni il porto di Hambantota alla Cina perché non riusciva a sostenere i costi del debito contratto con Pechino. La Malesia, Myanmar, le Maldive sono costrette a scambi analoghi. E sono solo esempi tra i tanti.
Questa politica dei prestiti come nodo scorsoio non rientra forse esattamente nei parametri di quell'imperialismo usuraio di cui Lenin parlava con riferimento alla Francia?
Vedere la Via della Seta semplicemente come espansione commerciale e non come espansione imperialista significa darne una rappresentazione minimizzatrice.
Quando Lenin nel suo saggio sull'imperialismo analizzava lo sviluppo delle ferrovie come terreno di esportazione del capitale non si limitava a rapportarlo alle esigenze commerciali, ma lo vedeva come strumento di asservimento e dominazione, e persino come cartina di tornasole dei rapporti di forza tra i diversi imperialismi e delle loro aree di influenza. Oggi per la stessa ragione lo sviluppo di porti e infrastrutture di marca cinese in giro per il mondo è uno dei metri di misura dell'espansione imperialista della Cina. Si può non vederlo?
“PROPRIETÀ STATALE” IN CONTRADDIZIONE CON L'IMPERIALISMO?
Nel mentre rimuove il carattere macroscopico di tali processi, il compagno Dölek si sofferma sul divieto da parte della Cina di investimenti in casinò, e sulla restrizione imposta agli investimenti in alberghi e luoghi di intrattenimento. A suo dire, questo dimostrerebbe che la «redditività dell'investimento» prevale sulla massimizzazione del profitto, a riprova della natura non imperialista della Cina.
In realtà l'esempio portato dal compagno dimostra semmai l'esatto opposto. Proprio perché lo Stato cinese è proiettato in un'espansione imperialista, concentrata sull'acquisizione e saccheggio delle risorse di altri paesi, ha tutto l'interesse a scoraggiare investimenti puramente speculativi e marginali, che bruciano inutilmente capitali preziosi.
Lo stesso vale per la questione sollevata della proprietà statale.
Per minimizzare la presenza massiccia di grandi aziende cinesi tra le 500 più grandi aziende al mondo, il compagno Dölek precisa che «quasi tutte queste società sono o società di proprietà statale o società per azioni in cui lo Stato è il principale azionista». E aggiunge: «Il motivo per cui queste società sono tra le prime 500 al mondo non è il capitalismo sviluppato di Cina e Russia, ma la leadership russa nelle risorse naturali e l’enorme mercato cinese, dato che ha la più grande popolazione del mondo». In ogni caso, il «modello di proprietà statale» di molte grandi aziende cinesi «non è compatibile con le tendenze classiche del capitale finanziario».
Tutta questa argomentazione non solo è priva di ogni fondamento, ma capovolge per molti aspetti la realtà delle cose.
Restiamo concentrati sulla Cina, a partire da una premessa necessaria.
In Cina la presenza dello Stato nell'economia è minoritaria rispetto alla proprietà privata, almeno a partire dai primi anni 2000 (in Russia a partire dalla metà degli anni '90), a dimostrazione di una restaurazione capitalista da molto tempo intervenuta. Le aziende private in Cina valgono oltre il 60% del Pil, e occupano l'80% della forza lavoro. Il fatturato complessivo delle prime dieci aziende private ammonta a 3.700 miliardi di dollari. Cinquecentocinquanta grandi aziende private cinesi competono, nelle prime posizioni, sul mercato mondiale. La natura capitalistica della Cina non dovrebbe essere dunque materia di discussione, se applichiamo un metodo d'analisi marxista.
In questo quadro capitalista, lo Stato cinese ha agito come strumento di salvaguardia di vecchi monopoli ereditari, o come strumento di costruzione di nuovi monopoli, in entrambi i casi in funzione del nuovo sviluppo capitalistico. In altri termini, lo Stato ha agito e agisce, per dirla con Marx, come capitalista collettivo, in funzione dell'interesse generale di sistema. Il termine “capitalismo di stato” - che Trotsky ha applicato più volte ai regimi fascisti degli anni '30 - è in questo senso appropriato.
Qual è concretamente, per usare la formula del compagno Dölek, “il modello di proprietà statale” di molte grandi aziende cinesi? È il modello delle cosiddette SOE (State-Owned Enterprise). Si tratta di aziende nate dalla “societarizzazione” delle vecchie imprese di Stato, processo iniziato dopo il 1993. Una sorta di trasformazione delle vecchie imprese statali in società per azioni. Il fatto che lo Stato detenga un pacchetto azionario di maggioranza non muta la loro natura di aziende capitaliste che operano sul mercato. Si tratta di grandi monopoli capitalistici a (consistente) partecipazione statale. Il nucleo centrale delle SOE, quello controllato dal Tesoro cinese e ricondotto ad un'unica holding (State-owned Assets Supervision and Administration Commission), è costituito da aziende relativamente indipendenti (almeno da metà degli anni 2000) che hanno il diritto di incamerare per sé il grosso dei propri profitti pagando allo Stato cifre irrisorie, al punto che i loro profitti netti nel 2012 ammontavano al 4% dell'intero Pil cinese; e che la loro sovrabbondanza finanziaria le ha trasformate a loro volta in istituti di credito verso molte aziende minori.
Perché dunque questo «modello di proprietà» sarebbe in contrasto con «le tendenze classiche del capitale finanziario»? È vero il contrario. Lo Stato offre garanzia e copertura pubblica a grandi monopoli capitalisti, associando e raggruppando attorno ad essi una pletora di azionisti privati, partecipi non solo dello sfruttamento del lavoro, ma anche della proiezione imperialistica di tali monopoli sul mercato mondiale, a vantaggio dei propri profitti. Pertanto le SOE non solo non sono un corpo estraneo all'imperialismo cinese, ma ne sono un baricentro. Un baricentro tanto più forte proprio perché a protezione statale.
Il fatto che molte di queste società appartengano alle prime 500 società del mondo non misurerebbe lo sviluppo capitalistico della Cina ma “solo” l'imponenza della sua popolazione e dunque del suo mercato interno? Francamente è un argomento incomprensibile. A prescindere da ogni altra considerazione, l'imponenza del mercato interno è un fattore costitutivo dello sviluppo capitalistico di un paese e un criterio misuratore della sua forza economica. Non certo il solo, ma neppure tra i più irrilevanti. Gli Stati Uniti costruirono proprio sull'imponenza del proprio mercato interno, come sulla ricchezza delle proprie risorse naturali, la grande ascesa economica del proprio imperialismo su scala mondiale. Lenin, proprio nell'Imperialismo, citava non a caso tra i misuratori della forza economica delle grandi potenze anche la consistenza delle rispettive popolazioni (madrepatria e colonie). L'enorme retroterra demografico della Cina, unito alla forza centralizzatrice dello Stato, è oggi un supporto delle grandi aziende cinesi e della loro proiezione nel mondo. Il fatto che esse abbiano scalato le vette dei processi di concentrazione su scala mondiale misura la forza dell'imperialismo cinese.
Ugualmente sbagliato, infine, è l'argomento del compagno Dölek secondo cui non si dovrebbe parlare di imperialismo cinese in ragione dei processi migratori dalla Cina verso Occidente. È vero che Lenin indicava l'emigrazione come misura di arretratezza, ma non trasformò mai questo elemento in un criterio assoluto. Tanto è vero che caratterizzò l'Italia del primo '900 come paese imperialista, nonostante fosse il più interessato dal fenomeno dell'emigrazione di massa («L’imperialismo italiano è stato chiamato «l’imperialismo della povera gente» in considerazione della povertà dell’Italia e della disperata miseria delle masse degli emigrati italiani», da Imperialismo e socialismo in Italia, 1915). L'emigrazione non preclude la natura imperialista di un paese; misura semmai le sue drammatiche contraddizioni sociali e il carattere diseguale del suo sviluppo. Le contraddizioni sociali dello sviluppo capitalistico cinese hanno certamente sospinto un fenomeno migratorio, un fenomeno migratorio innanzitutto interno, dalle campagne alle città. Ma anche esterno, seppur (è importante precisarlo) socialmente composito: dalla piccola borghesia affaristica, nel campo dell'industria, del commercio, della ristorazione, alla manodopera schiavile reclutata e comandata da ambienti malavitosi. Tali fenomeni sarebbero stati impensabili, nelle loro attuali dimensioni, nel quadro di uno Stato operaio deformato. Invece si dispiegano proprio come sottoprodotto dello sviluppo capitalistico della Cina, del suo sviluppo ineguale e combinato, della sua integrazione nel mercato mondiale e nelle sue filiere produttive.
UNA POTENZA IMPERIALISTA IN ASCESA
La Cina non è solo un paese imperialista, ma una grande potenza imperialista, e per di più una potenza ascendente.
Naturalmente questa ascesa ha molti punti deboli e grandi contraddizioni: un enorme volume di debito (pubblico e privato), cresciuto progressivamente nell'ultimo decennio; la difficoltà strutturale a sviluppare il consumo interno a fronte dell'assenza di un sistema di welfare (o del suo carattere atrofico); l'accumulo di contraddizioni sociali potenzialmente esplosive, in presenza di una crescita di combattività del proletariato sul terreno delle rivendicazioni economiche; il ritardo di accumulazione della forza sul piano militare a fronte dell'assoluta preponderanza americana.
Peraltro, ogni grande ascesa imperialista nella storia è stata gravida di contraddizioni, né si può affatto escludere che le contraddizioni economico-sociali della Cina possano conoscere in futuro un punto di precipitazione. Del resto anche la grande ascesa americana del primo '900, ed in particolare degli anni '20, incappò nella crisi catastrofica del 1929-'33, senza che questa invertisse la parabola storica di quell'ascesa. Il problema è esattamente individuare la linea generale di tendenza in una dimensione storica. E se guardiamo il complesso combinato dei fattori, la linea generale di ascesa dell'imperialismo cinese appare inequivoca.
Nell'arco degli ultimi vent'anni la Cina ha conosciuto uno sviluppo capitalistico concentrato e accelerato senza precedenti nella storia del mondo. Nel solo decennio successivo al 2007 la Cina è passata da 2.000 miliardi di Pil a 12.000 miliardi, conquistando la seconda posizione su scala mondiale dopo gli USA. Nel 2000 la Cina valeva il 4% dello sviluppo della produzione mondiale, oggi vale oltre il 35%. La Cina ha sviluppato monopoli capitalisti tra i più grandi su scala planetaria, e una compenetrazione altissima di capitale industriale e bancario. Possiede riserve finanziarie per 3.200 miliardi di dollari, le maggiori del mondo. Ha conquistato il primato mondiale nel campo dell'industria. Ha conquistato posizioni di punta in tutti i settori strategici dell'economia mondiale, dai settori tradizionali dell'industria pesante (acciaio) alla frontiera delle nuove tecnologie e della ricerca (informatica, robotica, intelligenza artificiale, auto elettrica...). Ha progressivamente approfondito il proprio inserimento nelle istituzioni imperialistiche internazionali (ingresso nel WTO, rafforzamento della propria presenza nella Banca Mondiale, inserimento dello yuan nel paniere delle monete di riserva). Ha costruito proprie istituzioni finanziarie internazionali (Banca Asiatica degli Investimenti per le infrastrutture) capaci di controbilanciare le tradizionali istituzioni finanziarie, in funzione del sostegno alla propria espansione imperialista e della composizione di nuove alleanze e relazioni. Infine va sviluppando un'azione di recupero sul proprio storico ritardo in fatto di investimenti militari: il bilancio della Difesa cinese è passato dai 30 miliardi di dollari del 2000 a oltre 200 miliardi nel 2017, con una continua progressione della propria incidenza sul Pil, mentre la concentrazione di postazioni missilistiche sul Mar Cinese Meridionale si combina coi primi avamposti militari in altri continenti (Gibuti) lungo le rotte della Via della Seta.
Si può non vedere in tutto questo il segno generale di una dinamica storica?
La questione dell'individuazione delle rotte di fondo della dinamica imperialista si è presentata più volte nel dibattito del movimento rivoluzionario.
Trotsky, ad esempio, sin dal 1923 pose l'attenzione sull'ascesa americana all'interno dell'Internazionale Comunista, incontrando non poche resistenze. Le obiezioni tradizionali che incontrava richiamavano generalmente la fotografia immediata della realtà esistente: la superiorità militare britannica, la fragilità e le contraddizioni interne dell'ascesa USA. Nel “terzo periodo” staliniano l'obiezione si fece diversa e strumentale: Trotsky avrebbe sopravvalutato l'ascesa USA perché in realtà ignorava l'imminenza della rivoluzione in Europa. La grande crisi USA del 1929 fu usata non a caso come argomento polemico contro le previsioni di Trotsky. Tuttavia, il problema che Trotsky segnalava era esattamente quello di guardare alla tendenza di fondo della dinamica storica, al di là delle mille contraddizioni congiunturali. Per questo si soffermava sugli indicatori strutturali di potenza dell'imperialismo USA, cogliendoli nel loro insieme e nelle loro combinazioni, a partire dalla conquista dell'egemonia americana nei settori trainanti del capitalismo mondiale (automobile, acciaio, navi) assieme al recupero tendenziale dello svantaggio in fatto di armamenti. È lo stesso angolo di visuale con cui oggi guardare allo sviluppo imperialistico cinese.
Tutto ciò, sia chiaro, non significa affatto prevedere un sorpasso cinese sugli USA sul terreno dell'egemonia mondiale, perché il divario di potenza resta tuttora molto considerevole e non facilmente superabile in tempi brevi e medi. A differenza che nel XX secolo, quando l'imperialismo USA soppiantò l'imperialismo inglese sia sul terreno economico sia sul terreno della direzione politica del capitalismo internazionale, non si configura ad oggi una soluzione di ricambio alla testa dell'imperialismo mondiale, ciò che rappresenta per alcuni aspetti un fattore di complicazione della sua crisi politica.
Ma questo non significa che il quadro mondiale delle relazioni interimperialiste sia immobile.
Non è un caso che nell'ultimo decennio la questione cinese sia emersa come la principale questione strategica per l'imperialismo USA, e non solo. Non è un caso se l'amministrazione Obama ha fatto del "pivot to Asia" il punto di svolta della propria politica estera. Non è un caso se oggi il nuovo corso di Trump, in forme diverse (protezionismo, bilateralismo), fa della contrapposizione alla Cina la bussola strategica della politica USA. Né infine è un caso se la relazione con la Cina diventa fattore di contraddizione e divisione tra gli imperialismi europei - come si è visto nella discussione sulla equiparazione o meno della Cina a “economia di mercato” - e fattore di svolta della politica giapponese, con la revisione militarista della Costituzione.
A tutte le latitudini i circoli imperialisti hanno già riconosciuto a modo loro l'imperialismo cinese e la sua ascesa. Il fronte sino-americano è già diventato il baricentro della politica mondiale. Lo stesso posizionamento strategico verso la Russia è condizionato da questa centralità. Ovunque, in America, in Europa, in Giappone, la discussione interna ai circoli imperialisti non è e non può essere “come restaurare il capitalismo in Cina” - ciò che apparirebbe loro una battuta di spirito - ma come contenere, controbilanciare, sconfiggere l'espansione del capitalismo cinese nel mondo. Cioè, in termini marxisti, come contrastare l'imperialismo cinese.
Colpisce semmai il divario tra la discussione interna ai circoli imperialisti e la discussione dei marxisti rivoluzionari sulla questione cinese.
I RIFLESSI POLITICI DI UNA DISCUSSIONE TEORICA. QUALE POSIZIONE DI FRONTE ALLA GUERRA?
In conclusione della propria disamina, il DIP afferma: «Ciò che determina il carattere della guerra nel XXI secolo è l’accerchiamento della Russia e della Cina da parte dell’imperialismo statunitense, in alleanza con i suoi alleati subordinati dell’imperialismo europeo e giapponese, al fine di integrare i paesi precedenti nel sistema mondiale imperialista in modo incontrollato, portando a compimento il processo di restaurazione capitalista in questi paesi». Dunque «la sconfitta della Russia e della Cina per mano dell’imperialismo darebbe luogo a risultati regressivi in tutto il mondo. Pertanto, non è possibile alcuna imparzialità tra l’imperialismo e questi paesi».
Questa argomentazione ha una sua innegabile logica interna, ma si appoggia su premesse analitiche sbagliate, e per questo conduce a una conclusione politica sbagliata.
Si possono avere considerazioni diverse sull'eventualità di una prossima guerra imperialista. Il PCL non ritiene imminente o prossima tale prospettiva, e considera un errore ritenerla tale, ma è indubbio che essa rientra nel novero delle possibilità storiche, con tutta la loro tragica rilevanza.
Sulla base degli schieramenti internazionali oggi esistenti e della loro possibile dinamica di collisione, il fronte di una possibile guerra vede contrapposti il blocco occidentale da un lato (con il coinvolgimento del Giappone), Russia e Cina dall'altro. Naturalmente occorre prudenza analitica nel campo delle previsioni. Trotsky, che giustamente vide l'ascesa storica dell'imperialismo USA, pensò sino al 1932 che il fronte della nuova guerra avrebbe visto contrapposti gli USA e la Gran Bretagna. L'avvento del nazismo in Germania cambiò rapidamente il quadro delle relazioni mondiali, e con esse le previsioni di Trotsky, che tuttavia ancora nel 1938 segnalava l'estrema mobilità di schieramenti e alleanze in vista della guerra che si avvicinava. Detto questo, riconosciamo che il crinale di una nuova possibile guerra è oggi quello che vede contrapposti innanzitutto gli USA e la Cina.
Il punto centrale di divergenza con l'analisi proposta dal DIP riguarda il contenuto sociale di questa guerra. La sua possibile ragione storica non è il compimento di una restaurazione capitalista, già intervenuta da tempo sia in Russia che in Cina, ma esattamente l'opposto: il contrasto di una proiezione imperialista cinese quale ultimo effetto dell''avvenuta restaurazione. Detto diversamente, la rotta di collisione tra vecchie potenze imperialiste ancora dominanti ma in declino e nuove potenze imperialiste in ritardo storico ma in ascesa. È la collisione che in forme diverse ha innescato le guerre imperialiste del secolo scorso.
Il posizionamento politico verso questo scenario di conflitto riveste un'importanza di prim'ordine, non per la presunta prossimità di tale evento, ma dal punto di vista del metodo marxista.
Le nostre organizzazioni, PCL e DIP, vivono e operano innanzitutto nel proprio campo imperialista. Di conseguenza la prima frontiera del posizionamento contro la guerra è la frontiera che ci vede contrapposti all'imperialismo di casa nostra, intendendo con esso la nostra borghesia nazionale, o il nostro imperialismo nazionale (come nel caso dell'Italia), e insieme lo schieramento imperialista internazionale in cui i nostri paesi sono collocati, a partire dalla NATO, e dunque dall'imperialismo USA che la controlla. Su questa impostazione disfattista contro il proprio imperialismo, e sulla sua priorità nella propaganda e agitazione politica, non può esservi naturalmente alcun dubbio o riserva. Da qui la denuncia delle campagne militariste degli ambienti NATO e USA, della nuova corsa agli armamenti in Occidente, di tutti gli argomenti che dietro l'accusa a Russia e Cina mirano a legittimare posizioni scioviniste e a costruire un'opinione pubblica corrispondente.
Ma come marxisti rivoluzionari conseguenti, e dunque internazionalisti, abbiamo anche la necessità, parallelamente, di definire una proposta di posizionamento internazionale dell'avanguardia proletaria mondiale. Di fronte a una guerra tra imperialismi vecchi e nuovi per la spartizione del mondo - perché questa sarebbe un'eventuale guerra tra USA e Cina - crediamo che la posizione naturale dei rivoluzionari debba essere quella del disfattismo bilaterale. Non una posizione di “imparzialità”, termine equivoco e improprio perché sembra alludere a una posizione di osservazione passiva o neutrale, ma una posizione di contrapposizione attiva a entrambi i poli imperialisti, per il rovesciamento dei loro governi, per la rivoluzione socialista internazionale. La stessa posizione di fondo che i comunisti rivoluzionari tennero nella prima e nella seconda guerra imperialista.
Non si tratta di definire la propria posizione internazionale in base al paese che aggredisce e al paese che è aggredito, o a chi minaccia e a chi è minacciato. Non è mai stato questo storicamente il parametro di riferimento degli internazionalisti, né nella prima né all'inizio della seconda guerra. Il riferimento centrale è alla natura di fondo dei blocchi in conflitto, e dunque alla posta in gioco della guerra da un punto di vista di classe. Se due briganti imperialisti si scontrano per la divisione del bottino su scala mondiale, l'elemento decisivo non è chi aggredisce e chi no, ma unicamente il contenuto obiettivo della guerra. Da qui il disfattismo bilaterale.
Una posizione di difensismo rivoluzionario sarebbe naturalmente doverosa di fronte a uno Stato operaio, per quanto degenerato o deformato, come fu l'URSS, come fu la Cina, come oggi è ancora Cuba e la Corea del Nord; così come sarebbe doveroso di fronte a paesi coloniali o semicoloniali, in ogni caso dipendenti. Ma né in Russia né tanto meno nella Cina attuale vi sono oggi rapporti socialisti di proprietà da tutelare, né possiamo considerare tali paesi dipendenti. In Cina in particolare è al potere una nuova classe di grandi oligarchi capitalisti e di capitalisti miliardari, che sfrutta centinaia di milioni di proletari entro le proprie frontiere, e opprime un numero crescente di altri popoli al di fuori di esse. Non vi è alcun contenuto progressivo da difendere nell'attuale Cina, ma un imperialismo da combattere. Al pari dell'imperialismo USA, degli imperialismi europei, dell'imperialismo nipponico, e al di là del diverso carattere di ciascuno di essi.
[1] https://revistaedm.com/verNotaWorldRevolution/7/the-character-of-war-in-21st-century-are-china-and-russia-a-target-or-a-side-of-the-war