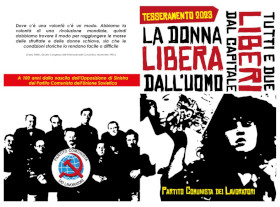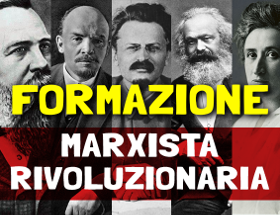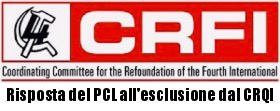Dalle sezioni del PCL
Il caso Bussi
Il caso d'inquinamento più devastante in Europa
23 Marzo 2017
Le "condanne" della giustizia borghese.
Naturalmente, secondo i canoni della giustizia proletaria che caratterizzano il nostro partito, il caso Bussi è ben lungi dall’essere risolto.
Il 17 febbraio 2017, la corte d’Assise d’Appello dell’Aquila, per la mega discarica dei veleni a Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, ha riconosciuto gli imputati, in maggioranza ex manager della Montedison, colpevoli del reato di avvelenamento colposo di acque pubbliche. Sono stati condannati a tre anni di reclusione Maurilio Agugia, Carlo Cogliati, Leonardo Capogrosso e Salvatore Boncoraglio. Invece Nicola Sabatini, Domenico Alleva, Nazzareno Santini, Luigi Guarracino, Carlo Vassallo e Giancarlo Morelli sono stati condannati a due anni.
Una lettura superficiale della vicenda, propinata dai mezzi d’informazione allineati alla stampa borghese, potrebbe ingenuamente far ritenere che la giustizia abbia fatto il suo corso. Naturalmente, secondo i canoni della giustizia proletaria che caratterizzano il nostro partito, il caso Bussi è ben lungi dall’essere risolto.
In particolare, poiché i fatti sono antecedenti al 2 maggio 2006, la Corte ha condonato le pene relative al disastro colposo. Ma la bontà della giustizia borghese non finisce qui. La sentenza ha riconosciuto il reato di avvelenamento aggravato di acque pubbliche. La pena però è stata prescritta. In altri termini: tonnellate di veleni sono state sversate nel fiume Tirino, affluente del fiume Pescara, per cui l’intero bacino idrografico della val Pescara è stato inquinato. Dunque i colpevoli non sconteranno alcuna pena.
Non è difficile immaginare come il verdetto abbia ricevuto il plauso da parte delle “anime belle” che, prive di una visione scientifica della società, sono immerse in una configurazione utopistica della dimensione sociale. Non a caso dopo la lettura della sentenza, l’avvocatessa dello Stato Cristina Gerardis ha dichiarato: «È una grande sentenza perché dimostra la giustezza delle nostre tesi: i fatti ci sono, è stato riconosciuto l’avvelenamento delle falde acquifere”. Sulla falsariga di quanto sostenuto dalla Gerardis, Luciano di Tizio, delegato abruzzese WWF, ha dichiarato: «L’obiettivo finale resta comunque la bonifica del territorio e l’applicazione del sacrosanto principio del chi ha inquinato paghi”.
Per comprendere la vicenda è necessario ricostruire il quadro storico all’interno del quale il polo industriale di Bussi è diventato uno dei complessi produttivi più importanti d’Europa.
In Italia l’industria chimica moderna nasce a fine Ottocento quando si sviluppa un nuovo paradigma tecnologico: l’elettrochimica. Tramite l’elettrochimica diventa possibile realizzare prodotti chimici utilizzando energia idroelettrica. I primi poli produttivi nascono in Piemonte, in Lombardia, in Veneto e in Abruzzo. Nonostante l’economia prevalentemente agricola, l’Abruzzo sarà un territorio dove il comparto elettrochimico troverà grande espansione.
La storia della grande chimica in Abruzzo ha inizio a Torino. Il 17 giugno 1899, nel capoluogo piemontese, si costituisce la Società Italiana di Elettrochimica (Sie). L’organigramma societario era costituito da una holding franco-elvetica-tedesca che per la tecnologia utilizzata risultava allora ai vertici dell’industria elettrochimica europea. La Sie utilizzava i brevetti delle società tedesche BASF (Badsiche Anilin und Soda Fabrik) e Cianyd Gesell Schaft. Il programma, sfruttando le risorse idriche del fiume Tirino, aveva l’obiettivo di produrre a Bussi alluminio, cloro-soda e derivati: prodotti altamente inquinanti.
In base al ciclo produttivo si evince che il polo industriale di Bussi avesse, fin dalla sua realizzazione, una vocazione bellicistica. Infatti il ciclo cloro-soda e derivati è principalmente rivolto alla produzione di esplosivi e gas nocivi. Con lo scoppio della prima guerra mondiale la produzione bellica del complesso elettrochimico di Bussi venne incrementata. Infatti alcuni impianti furono convertiti per la produzione di gas bellici. Non a caso durante il primo conflitto mondiale il polo produttivo di Bussi fu dichiarato ausiliario dal Ministero per le Armi e Munizioni, per la produzione di gas tossici.
Dopo il primo conflitto mondiale il ciclo cloro-soda fu ulteriormente potenziato. Di fatto si cominciarono a fabbricare iprite, gas lacrimogeni, arsine e T4 (un potente esplosivo).
Un anno fondamentale nella storia del polo elettrochimico abruzzese fu il 1931, quando alla guida del complesso industriale subentrò la Società Chimica Nazionale, di Guido Donegani. Donegani fu un personaggio di primo piano nel panorama industriale del Paese. Presidente della Montecatini e senatore con il Partito nazionale fascista, ricoprì anche il ruolo di consigliere della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Durante la sua gestione la predisposizione bellicistica del complesso di Bussi aumentò. Infatti, proprio in quel periodo, il Ministero della Guerra decise di installare reparti produttivi, gestiti dal Centro Chimico Militare (CCM), intensificando la produzione di gas bellici.
Nel 1935 la Società chimica nazionale fu rilevata dalla Dinamite Nobel, nel frattempo entrata a far parte del gruppo Montecatini. Con la Dinamite Nobel, Bussi diventò tra i più importanti centri di produzione di armi chimiche d’Europa. Infatti l’iprite utilizzata per gasare gli Abissini, durante la guerra d’Etiopia (1935-1936), fu fabbricata a Bussi.
Nella prima metà degli anni Quaranta le vicende del polo chimico di Bussi si legano inevitabilmente alla seconda guerra mondiale. Incuneati tra le gole di Popoli, in provincia di Pescara, gli impianti di Bussi subirono lievi danni dai bombardamenti degli Alleati. Un fatto curioso, che dimostra il rilevo acquisito dall’elettrochimica abruzzese, riguarda proprio il secondo conflitto mondiale. Nell’ottobre 1943 la Wermacht occupò il polo di Bussi e, per ordine di Albert Speer, ministro plenipotenziario per gli armamenti del terzo Reich, gli impianti furono difesi da possibili attacchi. In definitiva: la produzione bellica, sebbene in forma ridotta, continuò. L’occupazione degli stabilimenti di Bussi terminò nel giugno 1944 quando i tedeschi, in ritirata, distrussero gli impianti.
La Montecatini-Nobel riattivò gli impianti di Bussi nel 1947. Dunque il ciclo cloro e derivati continuò anche nel dopo guerra. Nella metà degli anni Sessanta avviene un fatto importante nella storia del polo produttivo. La Montecatini, per fronteggiare la crisi e la concorrenza di altre società, si fuse nel 1965 con la società elettrica Edison, dando vita alla Montedison. Quest’ultima, attraverso una serie di società partecipate, gestì gli impianti di Bussi fino al 2001, quando subentrò la Solvay, colosso belga dell’industria chimica.
Seguendo la storia del complesso elettrochimico di Bussi si ha la possibilità di capire la natura bellicistica del capitalismo. Si ha l’opportunità di comprendere che, nell’attuale sistema sociale di produzione, di fronte ad una congiuntura sfavorevole, i rapporti di produzione e le forze produttive, in determinati periodi storici, s’indirizzano verso il comparto bellico. Sono proprio le crisi di sovrapproduzione che hanno causato, in ultima istanza, il primo ed il secondo conflitto mondiale. Eventi che, come si è visto, hanno contribuito a rendere il complesso di Bussi tra i più notevoli a livello europeo.
L’aspetto più interessante, completamente velato dai mezzi di comunicazione servi del capitale, è che l’inquinamento prodotto a Bussi è stato causato dalla produzione bellica. Il ramo militare, in linea generale, è il fulcro dell’attività produttiva capitalistica. Infatti sono solo i conflitti, in ultima istanza, a risolvere le crisi economiche a cui necessariamente il capitalismo va incontro.
Dunque la vicenda di Bussi mostra, in tutta la sua chiarezza, la finalità devastatrice del capitalismo che si manifesta sia nella guerra, fonte d’indicibili sofferenze per l’umanità, in particolar modo per il proletariato, sia nella distruzione della natura, per cui il caso Bussi è emblematico, in quanto si tratta di uno dei maggiori disastri ecologici d’Europa.
La sentenza del 17 Febbraio, nonostante i limiti che la caratterizza, deve essere sfruttata dall’avanguardia proletaria per rendere cosciente la classe lavoratrice delle contraddizioni del capitalismo. Il verdetto, come si è visto, ha velato il significato storico, politico, economico e sociale del complesso produttivo di Bussi. La sentenza ha però il merito di aver accertato che tonnellate di veleni sono state sversate nel bacino idrografico della Val Pescara.
Partire da questo punto è necessario affinchè, attraverso un duro lavoro a stretto contatto con le masse, si possa trasformare l’indignazione della classe lavoratrice, attualmente vaga ed imprecisa, in una chiara disposizione politica che ponga, come punto centrale, il superamento del capitalismo. Ovvero il superamento di una fase storica che, sebbene abbia segnato un progresso nella storia dell’umanità, non è più in grado di garantire alcun tipo di miglioramento significativo al genere umano.