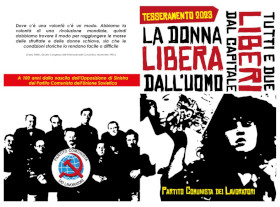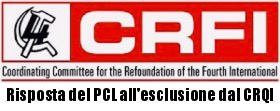Dalle sezioni del PCL
Working class a chi?
Chi ha votato veramente per Donald Trump?
16 Novembre 2016
Sentiamo e leggiamo che, negli Stati Uniti, la maggioranza dei voti all’imprenditore razzista Donald Trump gli sarebbero venuti dalla classe operaia.
Se gli operai eleggono un presidente razzista, gli operai sono razzisti.
Se gli operai sono razzisti, ci siamo persi qualcosa.
Non si spiega perché, ad esempio, operai provenienti da tutte le nazioni del mondo globalizzato (l’eufemismo postmoderno per “imperialista”) si trovino tutti davanti ai cancelli a protestare contro le vessazioni del padrone invece che prendersi a colpi di chiave inglese tra di loro perché uno è bianco, quello giallo e l’altro mulatto.
Non si spiegano i “Siamo tutti Abdel Salam!” che detonano ad ogni manifestazione, ogni presidio, ogni picchetto dai cori di centinaia di migliaia di persone, di qualsiasi provenienza geografica.
Non si spiega i sindacati perché siano così assortiti di iscritti, quando tra le proprie finalità non hanno certamente la lotta allo “straniero”.
Non si spiega, gli operai stessi di tutto il mondo, quale memoria, neanche “storica”, ma genealogica e familiare abbiano, dal momento che la classe operaia è soprattutto figlia dei grandi flussi migratori dell’ultimo secolo; degli italiani verso l’America, dei meridionali verso il settentrione, dei mediorientali verso l’occidente.
Ma soprattutto non si spiegherebbe come fa la classe operaia di qualsiasi Paese (e più è avanzato il capitalismo di quel Paese, tanto più è così!), composta almeno per la metà di uomini immigrati essi stessi, come possa esser razzista contro se stessa.
La faccenda fa acqua. Ed è acqua di fogna.
Partiamo innanzitutto dal fatto che parlare di “maggioranza elettorale”, negli Stati Uniti, è una questione spinosa.
Gli Stati Uniti (come il nome stesso dice) sono …Stati!
Quando parliamo degli USA dobbiamo tener presente che si tratta di una repubblica federale con tutte le implicazioni di specie che questa struttura comporta.
Le federazioni (50) hanno ciascuna i propri senatori e i propri deputati, detti “Grandi Elettori”. I cittadini americani non votano direttamente il loro presidente, ma un gruppo di Grandi Elettori, 538 dei quali (la somma di senatori e deputati di ciascuno degli Stati) saranno coloro i quali, rappresentando i voti ricevuti, dovranno eleggere questo o l’altro presidente, andando a formare la sua coalizione di governo, ovvero il Congresso degli Stati Uniti d’America, corrispettivo del nostro parlamento.
Il gap di questo meccanismo elettorale indiretto (che ha portato gli Usa a un presidente non voluto dalla maggioranza di chi si è recato alle urne già con George W. Bush nel 2000, e oggi con Trump) sta nel fatto che vi sono Stati più popolati e Stati meno popolati. Qui si hanno più e lì si hanno meno “votanti”.
Washington ad esempio, con i suoi 672.228 ha una intensità demografica nettamente più alta della Louisiana che conta poco più di 4.625 abitanti circa.
Ciascun Stato/federazione, tuttavia, ha per sé il medesimo numero di “Grandi Elettori” ai quali è dato di eleggere il presidente di tutti gli Stati del nordamerica.
È una sproporzione pericolosa, che uno Stato con più cittadini abbia lo stesso numero di rappresentanti d’uno Stato che, invece, conta molti meno cittadini e, specie se si considerano gli astenuti, due volte in meno numero di elettori.
Il pericolo si corre e la frittata, di quando in quando, scappa.
Se Stato per Stato si fa la conta del voto popolare alla candidata democratica e al repubblicano, Hillary Clinton viene fuori con il 47,7% dei voti e Donald Trump con il 47,3.
Ora: per le groupie di Hillary che si strappano i capelli dalla disperazione, questo sarà anche motivo di pena eterna. A noi, che fa schifo la criminale di guerra quanto ne fa il Qin Shi Huang del Messico, e che non possiamo né vogliamo non vedere, a dispetto delle giravolte di ciance vacue che intasano giornali e televisioni, quanto la differenza percentuale dall’una all’altro sia veramente risibile, preme ben altra analisi.
I (NON) VOTI DELLA CLASSE OPERAIA
I sondaggi registrano che il 50% circa degli elettori statunitensi non si è recato al voto.
Non succede molto diversamente altrove. L’affluenza diminuisce in pari tempo in tutti i paesi che generano una classe popolare insoddisfatta, rassegnata e disperata che non crede più alla politica. E certamente, a questa politica non c’è da credere proprio.
Rimane la metà dell’altro 50% che, però, ha votato. E, secondo le narrazioni tossiche di queste ore, avrebbe non solo votato Trump, ma si sarebbe trattato della “working-class” piena di problemi e che, di punto in bianco, si lascia abbacinare da un simile pagliaccio dell’orrore.
Sarebbe messa veramente male, la classe operaia statunitense, se fosse vero.
Ma considerando che il 50% della popolazione americana non ha votato non lo abbia fatto perché vede chiaramente che la contesa tra i due finalisti borghesi sia affare che non gli riguarda, e quindi prendendo per buono che quel 50% sia l’astensione di una classe che sa di non avere niente da guadagnare né dall’uno né dall’altro candidato, perciò – a ragione! – incrocia le braccia,
abbiamo, nel rimanente 50% esattamente diviso in due, come dimostrano le percentuali dei voti democratici e repubblicani, i voti da analizzare.
Consideriamo un 25% di società che, comunque, decide di recarsi alle urne (non foss’altro perché costipato dalle dichiarazioni ultrarazziste, ultrasessiste, ultraomofobe e tutto l’ultraschifo immaginabile e udibile, più che per un voto “positivo” a un presunto programma alternativo clintoniano che sa bene non esser tale), turandosi il naso e il voto al “meno peggio” perché quell’altro è, davvero, …fin troppo peggio, è stato vanificato dal meccanismo di elezione indiretta suesposto,
e che sia rimasta una percentuale residua di un 25% di cittadini che ha votato per Trump.
Perché, a conti fatti, è il 25% dell’intera popolazione statunitense che ha votato Trump.
E se quella è classe operaia, i borghesi dove stanno? Tutti operai? Chi non vota è perché “insoddisfatto dalle politiche liberiste dei governi di prima”, ecc ecc, quindi è working-class; chi vota è working-class pure…
Sono scomparse le classi, in America, e non ci hanno detto niente?
Sarebbe bello, ma gli Stati Uniti d’America sono quanto di più lontano ci possa essere da una società senza classi come la intendiamo noi. Le classi ci sono, vengono soltanto censurate. Oppure gli si cambia nome, tanto per confondere le cose.
LA PICCOLA BORGHESIA NON È LA "WORKING CLASS"
Come in Italia con Salvini, la stragrande maggioranza di chi si dichiara a suo favore, non è la “working-class”, seppure anche qui la narrazione si fa parimenti comune. Ma i piccolo-borghesi.
I piccolo-borghesi che, da tradizione che si riconferma ogni volta nel corso della storia, stanno a destra.
Ma non con la destra dei grandi imprenditori e dei grandi padroni che appartiene, invece, alla borghesia d’alta classe.
I piccolo-borghesi vogliono rimanere nel capitalismo e non lo mettono minimamente in discussione.
Ciò che gli importa, però, è che in questa corsa al profitto siano loro a vincere.
Quando perdono, cominciano a rumoreggiare convulsamente e a sparare a zero su tutto; a fare del sovversivismo osceno anche esteticamente e a dire di volere una “svolta”, favorendo sempre la peggior carogna dei reazionari abbrutiti e incattiviti quanto loro, da Mussolini in qua.
Al piccolo-borghese sono invise le grandi imprenditorie, le multinazionali, l’avanzata cieca dei colossi del capitale sulle macerie sì del proletariato, ma anche di se stessi. Perché più i grossi borghesi s’ingrossano, più il piccolo borghese si rimpicciola.
Ed è qui e solo qui il bandolo della matassa, e il perché i piccolo-borghesi devono essere razzisti e votano i razzisti.
Al grande capitale, chiariamoci, l’immigrazione fa gola.
Emblematiche della voluttà immensa che la grande borghesia trae dall’immigrato sono le dichiarazioni di Laura Boldrini che tesse le lodi dell’immigrazione e dello “stile di vita” degli immigrati da cui tutti dovremmo imparare, e di quanto sia virtuosa la flessibilità a cui si piegano piacevolmente gli immigrati, e che fa girare l’economia.
Alla grande borghesia l’emigrazione fa gola perché, chi emigra, emigra per disperazione.
E il disperato lavora anche a salari bassissimi e a condizioni di vera e propria schiavitù, giacché, come scriveva Marx, la borghesia ha sempre un piede nella nostalgia della schiavitù.
Più è grossa l’azienda per la quale lavorano immigrati a stipendi da fame, più è il profitto che rimane in tasca al proprietario.
Per potere trarre la maggiore convenienza da un esercito di schiavi messi a secernere plusvalore, bisogna che sia grande anche l’impresa. Se l’impresa è piccola, è ciò che il padroncino ne percespisce è relativamente “poco”, costui non può impiegare troppi lavoratori. O anche a pagarli a un euro l’uno, non rimarrebbe a lui nessun margine di profitto.
L’immigrazione può essere ed è la più grande risorsa per il capitalismo solo se si tratta del grande capitalismo. Solo a queste condizioni, si può estorcere una quantità smisurata di plusvalore, non altrimenti.
Così accade che più si fortificano, attraverso lo sfruttamento vieppiù intensivo di lavoratori disposti a tutto per sopravvivere, i padroni grossi, più i padroni piccoli languiscono.
La classe dei piccolo-borghesi ha tutte le ragioni per essere razzista!
L’immigrato, che arricchisce il pesce più grande e, in tal modo, minaccia quello più piccolo, è davvero il più grande nemico che possa avere sulla terra.
E gli fa un invidia enorme, quella schiera di schiavi a costo zero che arricchiscono fuor di misura il padrone grande e condannano all’estinzione i padroni piccoli! Non può, il piccolo-borghese, condannare il modo di produzione capitalistico, la proprietà privata di centri e mezzi di produzione o il libero mercato.
Condanna solo chi arriva prima di lui, e i mezzi che gli permettono d’arrivarvi, cioè gli immigrati, i più poveri, i disperati. Quelli che un altro può prendere per fame, lui no.
In America si dice working-class per riferirsi anche (e in questo caso, si direbbe “solo!”) alla classe dei piccolo-borghesi.
In un Paese in cui Marx ha fatto sempre grande fatica ad entrare, la differenza tra le classi è espressa in maniera molto meno sottile che altrove. Secondo il linguaggio e il senso comune USA, con cui, di là, scrivono i loro verdetti e la stampa italiana, di qua, li copiaincolla, “working-class” sono anche gli esercenti che, un tempo, lavoravano, avevano la loro bella attività, e non importa se impiegavano salariati a condizioni di lavoro miserrime per arricchirsene come potevano non meno di quanto faccia un cattivissimo padrone di una multinazionale.
Adesso, che il capitalismo marcia a passi da gigante e che il ceto medio si proletarizza, tanti piccolo-borghesi chiudono bottega, e sanno bene la colpa di chi è.
Dell’immigrato che si svende ai più grossi proprietari, consentendogli di arricchirsi e di inglobarlo, di comprarlo, di depauperarlo.
Il voto della società nordamericana a Donald Trump non è stato il voto della classe operaia, dei salariati di oggi e di ieri, del proletariato che ha fatto ciò che doveva fare: astenersi!
È stato il voto (come è qui il voto a Salvini, come fu ai tempi l’entusiasmo per Mussolini) della piccola-borghesia nazionale (e nazionalista) che vuole risorgere dalle sue ceneri e che sa che l’unico modo per farlo non è il socialismo, ma ostacolare come può l’arricchimento dei padroni più grandi, giusto il tempo di raggiungerli!
Bloccandogli le risorse, cioè la forza-lavoro a costo zero degli immigrati, degli “stranieri”.
Ecco cosa è stato il voto statunitense all’imprenditore paladino del riscatto dei bottegai incattiviti dalla recessione Donald Trump.
La classe operaia, a dispetto delle tante narrazioni tossiche che offuscano la ragione e coprono la verità, in Italia con Salvini come in America con Trump non può avere e non ha nulla a che fare.