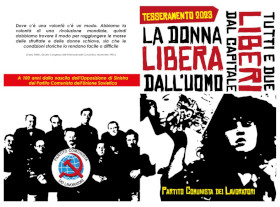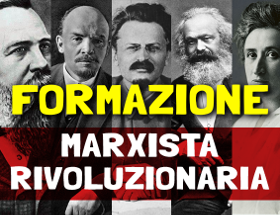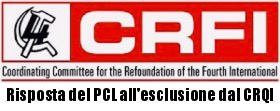Dalle sezioni del PCL
Storie di occupazione: Orsi Mangelli 1977
11 Novembre 2016
Nel 1926 venne aperta dal conte Paolo Orsi Mangelli una fabbrica per la produzione di seta artificiale dalla viscosa che raggiunse ben presto una forza lavoro di circa 1500 operai. Ad essa venne affiancato nel 1929 un impianto per la produzione di cellophan (SIDAC), con un’occupazione di 650 persone. La nuova società riuscì a superare indenne la crisi del ‘29, con qualche appoggio statale, e a sopravvivere alle difficoltà della guerra, che ne limitò molto la produzione per carenza di materia prima. Nel dopoguerra l’attività produttiva riprende rapidamente, grazie anche al fatto che gli impianti erano sfuggiti ai gravi danni provocati dai bombardamenti e dalle rappresaglie delle truppe tedesche in ritirata, grazie anche alla determinazione con la quale la direzione e le maestranze avevano vigilato sui macchinari. Negli anni ’70 la pesante crisi del mercato nazionale ed estero del settore del rayon e del cellophane fa registrare all’impresa un andamento fortemente negativo. Alla fine del 1972 si arrivò alla cessazione della produzione del rayon, con conseguente chiusura di questo reparto.La produzione industriale dell’area termina nel 1984 per quanto riguarda il cellophane e nel 1993 per quanto riguarda il nylon.
Dal PRU Ex Orsi Mangelli, in cui si legge anche:
“La precedente destinazione industriale dell’area ha gravato molto sulle dinamiche del processo di riqualificazione. […]I n particolare, la trasformazione dell’area destinata a parco urbano […] si trova oggi in forte ritardo a causa della gravità ed estensione dei livelli di contaminazione (da amianto ed eternit, ma quest è un’altra storia, NdA).
---
Com’era la situazione del’Orsi Mangelli prima dell’occupazione?
Negli anni settanta quando io sono stato assunto, io sono stato assunto nel 1970, c’era ancora la “fabbrica vecchia”, che era il rayon, poi c’era la Sidac che faceva cellophane e c’era il Forlion che faceva filati, per calze e altre cose. C’erano oltre 2000 operai, nel 1970.
Da un lato c’erano tutti i servizi di appoggio alla vera e propria famiglia operaia, con asilo nido, mensa, bar con sala di lettura quotidiani, minimarket, sponsorizzavano la squadra di ciclismo, pesca sportiva, c’erano un sacco di iniziative paternalistico-assistenziale, chiaramente utili.
Dall’altro purtroppo l’utilizzo di sostanze tossiche e nocive dovuto alla produzione e le scarse conoscenze di allora sui sistemi di prevenzione danneggiavano la salute degli operai: da un lato la grande mamma che ti assiste in tutto, dall’altro turni notturni, l’utilizzo di sostanze nocive, il rumore, gli odori sgradevoli.
Nel 1972 l’azienda annuncia la chiusura della fabbrica vecchia, quella dedicata alla produzione del rayon, con circa 830 licenziamenti. In seguito sono partite varie forme di lotta.
Nel 1976 si prospetta il fallimento dell’azienda. Attraverso un’operazione un po’ ambigua subentrò un finanziere semisconosciuto, di nome Porcinari, che appoggiato anche dai politici del tempo, ha preso in mano la situazione agendo come un avventuriero… Non ha mai pagato le maestranze. Siamo andati avanti con un po’ di finanziamenti agevolati dalle banche e altre forme… siamo arrivati al punto che i dipendenti dovevano avere nove mesi di paga più tutte le liquidazioni. In questa fase ci sono state le lotte più aspre nei confronti delle banche che non erogavano più finanziamenti per continuare a lavorare, e poi perché non si vedevano sbocchi. Quindi si è deciso di occupare.
Qual era la tua mansione?
Io ero in Manutenzione, nell’officina meccanica. Ci fu un ridimensionamento, anche dalle varie officine si limitò il personale. Si partì con l’organico ridotto all’osso, molti finirono in cassa integrazione. Io capitai in una sorta di bacino di 50 operai con mansioni particolari da cui attingevano in caso di bisogno. Avevo 29 anni.
Qual era la situazione del movimento operaio allora?
Il 76-77 era il momento delle Brigate Rosse, c’erano tutti i gruppi extraparlamentari, Lotta Continua, Potere Operaio. La situazione era tesa. Soprattutto nel periodo in cui fummo lasciati nove mesi senza paga ci furono le lotte più dure, con blocchi stradali sulla via Emilia, e della stazione, con operai denunciati. Era il momento dell’esasperazione, la gente non sapeva come andare avanti. L’occupazione della ferrovia in particolare fu semi-spontanea, vi parteciparono i più esasperati che non vedevano sbocchi, in parte sobillati dalla destra, che tendeva a mettere in evidenza le responsabilità della sinistra che aveva appoggiato l’avventuriero Porcinari. I sindacati tradizionali cercavano di mantenere le forme di lotta tradizionali, anche dure, ma che erano sempre entro certi limiti. L’occupazione è stata la risposta alla situazione.
Eravate compatti?
Sì eravamo compatti, abbiamo avuto anche l’appoggio di tanti quadri e di ruoli dirigenziali e qualificati, necessario per poter mantenere in sicurezza un impianto estremamente pericoloso che prevedeva depositi di ammoniaca, azoto liquido, acido solforico… Gli impianti non potevano semplicemente essere bloccati.
Quali sono state le difficoltà incontrate durante l’occupazione?
In primo luogo proprio garantire la sicurezza di tutti gli operai e della gente, dato che la fabbrica è stata inglobata dalla città. C’era una preoccupazione e una pressione psicologica costante, dato che il periodo era caldo e si temevano attentati o gesti disperati o incidenti pilotati per sfruttare il momento per scopi politici. Quindi era prioritario essere organizzati bene, sia come quadri specializzati che come maestranze. La gente dava la propria disponibilità e si organizzavano i turni e le ronde… Hanno partecipato centinaia di operai, c’erano ancora più di mille occupati nel 1977.
Qual è stato l’atteggiamento di politica e sindacati nei confronti della vostra lotta? E della città di Forlì e della gente in generale?
La partecipazione era tanta, in quel momento, i sindacati erano tutti uniti, con qualche distinguo, alle assemblee venivano anche i parlamentari locali. Avevamo la solidarietà di studenti, bancari e di molti settori della società, anche dei negozianti. La popolazione era consapevole che la chiusura di un’azienda del genere era uno sfacelo per il territorio di Forlì. Vi sono comunque anche stati tentativi di strumentalizzazione politica. Poi chiaramente c’erano altri settori che non simpatizzavano con noi, o per ragioni politiche, oppure c’era anche chi aveva l’idea che noi della Mangelli facessimo sciopero anche per la carta igienica, e ovviamente non era così.
Quanto è durata l’occupazione e perché è finita?
L’occupazione è durata circa 40 giorni. È finita perché hanno prospettato diverse soluzioni, come tutte le lotte ti danno una qualche soluzione più o meno dolorosa e tu accetti, con il solito sacrificio di un po’ di gente, qualche cassa integrazione, qualche pre-pensionamento…
Come giudichi questa forma di lotta?
È l’ultima arma. È l’arma della disperazione. Va organizzata bene, bisogna avere l’appoggio dei quadri e essere in grado di salvaguardare la sicurezza delle persone e l’efficienza degli impianti.
A mano a mano che la lotta diventa più dura calano il numero delle adesioni, cresce la paura di essere denunciati (come per l’occupazione della stazione), paura delle rappresaglie future da parte dei padroni. Fa parte dell’animo umano. Si deve fare un’azione di pressione progressiva, avendo preparato prima il terreno e avendo la massima adesione, valutando prima i problemi che si presenteranno, senza creare spaccature, privilegiando la compattezza del fronte di lotta.
Bisogna poi sapere che perdi sempre gente per strada. C’è chi è in grado di sostenere la mancanza di reddito per 10, 20, o 30 giorni, ma poi deve andare a lavorare, magari in nero.
E allora non sarebbe utile una cassa di resistenza?
Noi alla Mangelli siamo stati aiutati dalle banche che ci hanno anticipato due o tre mesi sulla base di crediti che l’azienda aveva. Aveva del materiale pronto da vendita come garanzia. In alternativa si ricorreva alla famiglia, agli amici, a chiunque per farsi dare un po’ di soldi e tirare avanti. Molti facevano tanti piccoli lavoretti.
Lo rifaresti?
Sì. Noi abbiamo avuto tante soddisfazioni dalle nostre lotte, tante conquiste. Quando sono andato a lavorare si smetteva il sabato a mezzogiorno, abbiamo ottenuto i due giorni consecutivi di festa, per chi faceva il turno spezzato. Poi è arrivata la quarta settimana di ferie…
Cosa vorresti dire ai lavoratori di varie realtà che oggi come quarant’anni fa occupano la fabbrica per difendere il posto di lavoro?
Cosa potrei dire? Noi abbiamo avuto qualche vittoria anche perché avevamo più ammortizzatori sociali con cui abbiamo potuto far scivolare in pensione tante persone… non è come adesso con gli esodati.
Il rovescio della medaglia è che forse per riuscire a tirare avanti quel tanto da mantenere il posto di lavoro e andare in pensione non si è fatta una lotta abbastanza dura sul fronte della sicurezza sul posto di lavoro. E quindi abbiamo perso gente per strada che alla pensione non ci è arrivata.
Ma se avessi davanti uno dei tanti ragazzi che oggi hanno davanti il licenziamento, cosa gli diresti?
(Sorride) Che siano preparati soprattutto a passare delle delusioni sul piano umano. Il problema è tenere unita la gente. Tenere uniti i disperati è facile, non hanno alternative. Ma bisogna cercare di tenere uniti anche coloro che potrebbero andare in un altro posto di lavoro o che avrebbero delle alternative.
Sono contento di aver creduto in qualcosa, non si può vivere senza credere in niente, o pensando che non si ottiene mai niente, che va tutto male, che la gente è tutta ladra. Nella vita bisogna credere in qualcosa.
Una volta che lotti devi anche pensare che possa andare bene. Però non bisogna arrendersi alle prime delusioni.
Noi abbiamo lottato in un periodo in cui c’era tutta un’altra mentalità, la gente era “genericamente” di sinistra, prendo un po’ tutti, era convinta che il progresso della società fosse irreversibile. Sembrava inevitabile che mano a mano che la gente si istruiva di più leggeva di più, studiava di più, aveva accesso alle informazioni tutto sarebbe migliorato. Sembrava scontato, invece la situazione è regredita. Io sono rimasto in quell’azienda fino alla pensione, lo considero un successo e il frutto della lotta, ma non dimentico che nel ‘70 eravamo più di 2000 e quando sono andato in pensione nel 2002, del nucleo originario della Mangelli eravamo 12. Eravamo dei sopravvissuti, ne abbiamo persi tanti per strada.
Abbiamo fatto degli errori, per carità, non siamo stati in grado di ottenere di più in un momento storico favorevole. C’era una solidarietà diversa e uno spirito diverso. Allora non c’era la delocalizzazione. Ora i padroni hanno tante armi in mano in più da utilizzare a loro vantaggio.