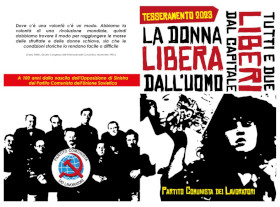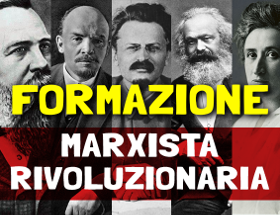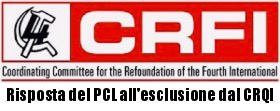Prima pagina
HUGO CHÁVEZ Un giudizio marxista della sua figura
12 Marzo 2013
La morte di Hugo Chavez ha provocato, come era prevedibile, un’ emozione popolare enorme in Venezuela. Ha commosso anche l’opinione pubblica internazionale. E’ la conseguenza naturale dell’attenzione che ha suscitato nella politica mondiale durante la maggior parte della sua gestione politica. Lo stesso già è successo nel passato con altri liders di nazioni di medio sviluppo, dall’indiano Gandhi, l’argentino Peron, l’egiziano Nasser o l’indonesiano Sukarno, così anche per Fidel Castro durante la seconda metà del secolo passato. Questo posto eccezionale si può spiegare per la naturalità universale dei problemi storici che sono stati lasciati irrisolti. E’ l’espressione del carattere mondiale dei conflitti nazionali. Il parto del chavismo si produsse a fine febbraio del 1989, quando una ribellione popolare- il Caracazo- contro il programma fondo monetarista del governo che aveva appena assunto l’incarico, sotto la presidenza di Carlos Andres Perez, fu massacrata da una repressione eseguita dall’esercito. Fu la fine del ciclo storico del nazionalismo civile piccolo-borghese, che per cinquant’anni incarnò il partito Azione Democratica(Accion Democratica) Tre anni più tardi, dalle proprie forze armate emerse una reazione contro coloro che avevano represso il Caracazo, sotto la sollevazione di ufficiali di rango inferiore, condotti da Hugo Chavez,che utilizzavano un’impostazione nazionalista. La sollevazione condusse il popolo di nuovo in strada –anche se in un modo incipiente- e convertì a questo golpe militare peculiare( contro il governo e l’alto comando delle forze armate) quasi in una sollevazione popolare. Nella coscienza del popolo albergò l’idea che avrebbe potuto contare sulle armi del Paese. Il Chavismo non nasce da una combinazione parlamentare né da un inciucio tra compagni di partito, bensì da una congiunzione del nazionalismo amalgamato con una parte delle masse. Il Caracazo e la sollevazione del ’92 sono il rintocchi di campana che anticiperanno il crollo del processo di privatizzazioni e indebitamento che hanno caratterizzato la tappa neo-liberale. Curiosamente, il menemismo avrebbe dovuto ancora debuttare quando in Venezuela si poneva come manifesto che questo era condannato a terminare in una crisi semi-rivoluzionaria.
NAZIONALISMO
Il nazionalismo militare chavista ha una parentela con la storia del suo Paese e di tutta l’America Latina. E’ il caso di Peron e dei nazionalismi militari, per esempio, in Perù (Velazco Alvarado) e in Bolivia (Juan Jose Torres), alla fine degli anni ’60, i quali nazionalizzarono le compagnie petrolifere straniere e gli zuccherifici- in alcuni casi senza indennizzo. Tutti questi movimenti, come farà dopo il chavismo, hanno fatto sfoggio di alcune particolarità di carattere eccezionale, specialmente a ciò che è relativo al suo leader. Il Caudillismo riflette la scarsa differenziazione sociale del movimento di massa e l’impegno del nazionalismo di presentare il popolo come un blocco unito esclusivamente da interessi nazionali. Distorcendo, con questo procedimento, le ragioni storiche del suo emergere: il protagonismo delle masse, che con azioni e sacrifici ripetuti, hanno messo in evidenza la strada senza uscita delle relazioni sociali vigenti, infine, la connessione tra la crisi sociale e politica in un paese con la declinazione storica del complesso del sistema nazionale dominante. La presunzione di rappresentare la nazione o lo slogan dell’unità nazionale puntano a giustificare la sottomissione della classe operaia con ciò che si sarebbe battezzato “la comunità organizzata”. E’ la giustificazione ideologica dell’imbavagliamento dei sindacati da parte di una burocrazia integrato allo Stato. Il movimento nazionale- civile o militare- è un’espressione della tagliola che la dipendenza del capitale finanziario internazionale mette allo sviluppo delle forze produttive nei paesi della periferia capitalista. E’ l’espressione di una lotta per difendere la parte dell’entrata nazionale nelle risorse che genera il complesso dell’economia mondiale. Il chavismo no si è limitato a utilizzare la rendita petrolifera del Venezuela per lo sviluppo dei programmi sociali di ampio raggio, prima di ciò, si è scontrato in forma aperta con il capitale internazionale e i suoi agenti interni per evitare la internazionalizzazione di PDVSA, l’impresa statale del petrolio, nelle mani delle borse straniere. Questa crisi fu la ragione che spinse al golpe militare che rovesciò a Chavez nell’aprile del 2002,e il sabotaggio petrolifero alla fine di quell’anno. In quelle date, il prezzo del barile di petrolio ancora si situava appena sopra i 10 dollari, di modo che non è certo che nella crisi avesse giocato un ruolo determinate la cattura della rendita mineraria straordinaria che sarebbe sorta dopo, dovuta all’aumento internazionale dei prezzi. La mobilitazione popolare che sconfisse il colpo di stato di Aprile e dopo il sabotaggio petrolifero furono il 17 di Ottobre del Chavismo, il quale già si era tratteggiato con la sollevazione del 1992, Un’ironia: Hugo Chavez salutò le masse che si erano mobilizzate per liberarlo dal golpe fascistoide con un invito a “tornare a casa”.
CHAVISMO E RELAZIONI DI PROPRIETA’
La sconfitta del golpe “civico-militare” convertì alle forze armate in chaviste, una consistenza che ha attraversato la prova del sabotaggio petrolifero. L’arbitraggio politico di Chavez incontrò nella “chavizzazione” delle forze armate un posto solido. Questa unione si rinforzò quando Chavez risolse a suo favore uno scontro con il generale Baduel, il paracadutista che lo salvò nel 2002 e che dopo divenne la massima autorità dell’esercito. Un’ altra cosa importante e’ che, nel momento più aspro del sabotaggio petrolifero, la banca internazionale non interruppe il finanziamento al Venezuela, né Chavez smise di pagare il debito estero. Perciò, la nazionalizzazione di alcune banche- una misura fondamentale per qualunque trasformazione sociale e per l’industrializzazione- si è prodotta solo di recente, quando ironicamente- la Banca Santander è stata comprata dallo Stato per far fronte alla crisi bancaria internazionale con il denaro di un ottimo indennizzo. Nei momenti più duri dei suoi scontri reciproci, il capitale finanziario internazionale ha sempre avuto chiaro che il chavismo non aveva interesse a rompere con le Borse, ne tanto meno era nemico della proprietà privata. Le nazionalizzazioni generosamente indennizzate perdono il loro contenuto anticapitalista, dove lo Stato scambia denaro fiscale per capitale e il capitale si scambia con denaro privato. La propaganda antichavista, specialmente quella del sionismo, imputa a Chavez interessi sinistri riguardo la sua alleanza con l’Iran. Si tratta di un’altra cosa: l’asse Venezuela-Iran è fondamentale per contrastare la pressione dell’Arabia Saudita e gli emirati del Golfo, istigati dalle industrie petrolifere anglo-franco-nordamericane affinché la Opec riduca i prezzi del petrolio. Chavez e gli ayatollah difendono la parte dei suoi paesi nell’entrata economica mondiale - anche se ciò pregiudica nazioni non petrolifere della periferia. In compenso, Chavez ha offerto a vari di quei paesi prezzi di preferenza, per questo ha rinforzato l’autorità del Venezuela nella disputa energetica. Il chavismo proclama un “socialismo del XXI secolo”, pero è socialismo della divisione parziale della ricchezza sociale, non della trasformazione del capitale in proprietà pubblica, ne dello Stato in direzione collettiva delle masse. La denominata “ridistribuzione dell’entrata” ha migliorato considerevolmente, a partire dai livelli di vita più miserabili della popolazione, pero questa entrata continua ad essere quella della rendita petrolifera. Chavez ha proceduto a numerose nazionalizzazioni, le principali in cambio di indennizzi generosi per i grandi capitali: Verizon, la nordamericana delle telecomunicazioni; Sidor, la siderurgica de Techint, pagata con estrema generosità; lo stesso dicasi per il cementificio del messicano Slim. Nelle campagne non è successo lo stesso, perché si comprovato che i titoli di proprietà degli espropriati erano fraudolenti. Queste nazionalizzazioni non risposero a un piano; sono state improvvisate dalla crisi stessa. La pianificazione richiede la partecipazione cosciente del proletariato, la sua indipendenza politica di classe. Per esempio, quando mancò il cemento per i programmi di residenza popolare o quando il governo non riuscì a conciliare lo scontro de Techint con gli operai di Sidor, si nazionalizzarono i cementifici e l’industria siderurgica- però per questo non cambiò nella sostanza la produzione gli uni o dell’altra, bensì la importazione. I grandi capitali fecero fagotto quando conclusero che non gli interessava lo scenario economico prevalente. Però il Venezuela non si trasformò in un paese industriale continua ad essere monoproduttore di combustibile. La redistribuzione delle entrate si fece con la cassa di PDVSA, la quale si trova fortemente indebitata e con un forte squilibrio economico dovuto al congelamento del valore del bolivar in un contesto di inflazione. I limiti di PDVSA si manifestano protagonismo del capitale straniero( con l’unica esclusione di EXXON) nello sfruttamento della fascia dell’Orinoco. La crisi di PDVSA è la ragione principale della recente decisione di svalutare il bolivar fuerte( immettere più moneta nazionale per dollaro esportato). Ugualmente alle altre esperienze nazionaliste del passato, quella del Venezuela ha fallito nell’obiettivo di assicurare uno sviluppo nazionale autonomo. Ciò non è possibile nello stadio di declino del capitalismo mondiale. Però nello stesso modo, il Venezuela emerge da questa esperienza con uno Stato più centralizzato, con la relativa retrocessione dei settori più parassitari del capitale nazionale e soprattutto con una presenza più attiva delle masse. Qualunque cambio al processo economico conterà su questi fattori come strumenti di lavoro.
PROSPETTIVE
Il Chavismo ha combattuto lo sviluppo di un sindacalismo indipendente. Il Codice del Lavoro introduce conquiste importanti per i lavoratori del terziario, però impone l’arbitraggio obbligatorio e la facoltà del Presidente di decidere la legalità di qualsiasi sciopero. Le commissioni paritetiche non si convocano quando scadono i contratti collettivi, i salari nella grande industria non sono aumentati. C’ è una statalizzazione dei sindacati. La morte di Chavez blocca la possibilità che le masse del Venezuela esauriscano l’esperienza politica con il suo tentativo nazionalista. Le critiche o delusioni che potrà provocare la nuova gestione salveranno questa esperienza storica considerata nel suo insieme. Dal punto di vista dello sviluppo della coscienza di classe, la morte di Chavez rappresenta un blocco. La morte di Chavez crea, obiettivamente, una crisi del regime politico, quello del potere personale. I successori dovranno trovare un’uscita alternativa. Gran parte del circolo che governa rappresenta quello che lo stesso popolo chavista definisce “la destra endogena”. Un’ alternativa è che, dopo le prossime elezioni, il sistema politico segua l’esperienza argentina Kirchnerista( qualcosa di ironico quando si accusa ai Kirchener di chavizzarsi). Ciò consisterebbe in un certa parlamentarizzazione del sistema, a scapito del verticalismo attuale e delle organizzazioni parallele a quelle ufficiali- com’è il caso dei consigli comunali. Il chavismo non è unito da un programma né è omogeneo in termini sociali; anche se rumoreggino le critiche al suo interno, funziona come un apparato di Stato e incluso parastatale. Il nuovo governo dovrà far fronte, senza l’autorità di Chavez, alla destabilizzazione economica che cresce e alle svalutazioni anche maggiori della moneta. Sarebbe un aggiustamento senza anestesia, in mezzo al cambio di un regime. L’ultima svalutazione è stata presentata dall’establishment attuale come una decisione che Chavez avrebbe preso alla Habana. Esiste una forte critica interna alla gestione distorta dell’informazione sulla malattia di Chavez, si è interpretato cioè come funzionale all’establishment che sta al comando. Dopo le nuove elezioni presidenziali, dovranno avere luogo le elezioni municipali, le quali sono state posticipate varie volte. Qui, l’opposizione di destra potrebbe incrementare la sua rappresentazione. La divisione della destra, come da poco ha osservato Diosdado Cabello-presidente dell’Assemblea Nazionale e presumibile leader della destra endogena- “voi siete più divisi di noi”. E’ vero. Incitata dall’uribismo colombiano, dai repubblicani degli USA e dai capitalisti finanziari venezuelani, una minoranza attiva spinge per la destabilizzazione. Sembra stare alla sua testa il sindaco di Caracas, Ledezma. Capriles sarebbe la testa della frazione conciliatrice. In questa crisi di complesso, le forze armate costituiscono la carta di riserva per bloccare una disgregazione politica. Si è parlato fino alla nausea della leadership continentale di Chavez. Quando si osserva con maggiore attenzione, si evince che è stata questa leadership , almeno negli ultimi anni, ad operare all’ombra della spinta delle imprese minerarie e delle appaltatrici brasiliane, le quali hanno imposto la loro agenda attraverso il “governo dei lavoratori” di Lula e Dilma Roussef. La Unasur è un satellite della diplomazia brasiliana. Dalle “riforme” a Cuba, alle negoziazioni con le Farc o gli accordi con l’Iran, l’operatore fondamentale è stato il Brasile, non Chavez-ossia la Borsa di Sao Paulo ( un santuario delle grandi banche di investimento). Non è caso che la Banca del Sud sia morta per mano degli interessi del BNDES- il Banco di sviluppo del Brasile( il quale finanzierà le opere idroelettriche delle imprese appaltatrici brasiliane in Argentina). Si è creato una situazione nuova in America Latina. Lo sfida principale che viene rappresentata è per la sinistra, la parte che è marginale in tutto questo processo. Nonostante tutto, dovrebbe essere la protagonista storica principale. Dovrebbe aprirsi un dibattito continentale per caratterizzare questa nuova situazione e ottenere da questa situazione tutte le conclusioni rivoluzionarie.