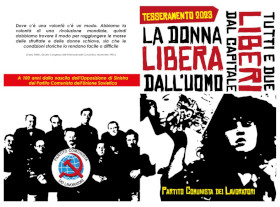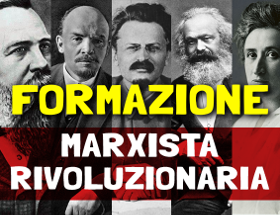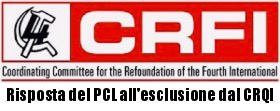Dalle sezioni del PCL
Il Che fare? Della Fiom
di Pino Casamassima
28 Gennaio 2011
Lo sciopero indetto dalla Fiom per il 28 gennaio stimola alcune considerazioni sullo stato delle cose del movimento operaio nello specifico e dei lavoratori in generale, oltre che su quello della politica, a cominciare dalla constatazione di un percorso ormai autonomo del maggiore sindacato metalmeccanico italiano rispetto a quello degli altri sindacati obiettivamente un po’ ingiallitisi per itterizia padronale…
Un avvenimento che sancisce l’ecumenica risoluzione d’un rapporto contro natura fra più – e alternative – anime sindacali che, a mò di miti platonici, tenevano legate insieme essenze diverse: come poteva coesistere la Fiom – che scalpitava verso l’alto – con Cisl e Uil – “naturalmente” protese verso il basso? (Oltre che Platone, sovviene Monicelli, per la brancaleonesca ammucchiata ulivista rimediata dal bianco crociato monsignor Romano, che fra i chierici da schierare contro il cavaliere nero poteva contare fin su don Clemente e don Tonino).
Per capire lo strappo della Fiom (percepito come nuovo da molti distratti) bisogna – come diceva Benjamin – cercare un suo analogo nella storia. E i suoi “analoghi” sono più d’uno, tanto da far apparire come anomala l’unione, non la disunione delle suddette anime sindacali. Se un certo “cretinismo parlamentare” aveva de-generato una legge maggioritaria da escort della politica, con la conseguenza di unire sotto lo stesso ombrello soggetti diversamente permeaibili alle crescenti piogge socioeconomiche, l’incestuosa unione sindacale s’era consumata sotto le lenzuola d’un compromesso storico fortemente voluto dai beati Aldo, Enrico e Luciano. Quelli che – seppur in modo specularmente opposto e con diverse fedi – avevano consegnato un’intera generazione al terrorismo e all’eroina. Perché se è vero che – con malafede – l’emerito sardo, poi anch’esso beatificato postmortem, in un’intervista confidò (confessare no, proprio no: al massimo si confida, appunto), seppur con 30 anni di distanza, d’aver voluto e cercato e ottenuto lo scontro con Autonomia per poterla sconfiggere militarmente, i due soloni dell’eurocomunismo avevano addirittura disconosciuto l’esistenza di quel movimento (del 77), nel solco di quella miope tradizione di famiglia togliattiana, che dalla “Svolta di Salerno” in avanti aveva guardato la società dell’avvenire coi soli occhi della governabilità: intesa come “possibilità di”. Ecco spiegato l’atteggiamento idiota di Longo col movimento del 68. (Che inaspettatamente s’era sentito dare ragione dall’epurato Pasolini, quando con una brutta poesia, il redivivo Savonarola aveva lanciato anatemi contro quei figli di papà che giocavano a fare la rivoluzione contro quei poliziotti figli dei contadini). Quel Longo che non era stato capace manco di riconoscere il carattere planetario d’un movimento che contestava non i piani di studio, non i baroni universitari, non le rette troppo alte, ma Yalta!, dove il forcipe della storia aveva partorito un mondo spaccato a metà. E mentre il Pci perseguiva il togliattiano progetto riformistico di migliorare la condizione della classe (operaia, s’intende) – cioè a dire infilarlo nel ventre molle del consumismo per fargli arrivare gli stessi “privilegi” della borghesia – quel movimento giovanile, per bocca di Mauro Rostagno, rifiutava in blocco quel progetto, perché «noi non vogliamo quel che voi avete, perché noi desideriamo sperimentare forme di vita e di consumi diversi», per concludere che «noi non vogliamo trovare un posto in questa società, ma creare una società in cui valga la pena trovare un posto».
Per tornare all’oggi, alle attuali lotte operaie ri-protagoniste (causa bisogno: concetto sul quale bisognerà tornare) di una realtà italiana da basso impero, è bene ricordare ai troppi ammaliati dalla “cooperazione responsabile” (sic!) che, suo malgrado, è stata proprio l’industria – il capitale – a sviluppare in modo formidabile la “cooperazione di classe”: una fabbrica, per quanto riconosciuto come sintomatico luogo di “cooperazione forzata”, dimostra a che grado di potenza può arrivare l’aggregazione operaia (leggi lavoratrice). Tutto questo sta in un passato rimosso da una sinistra che non sa più manco come chiamarsi e richiamarsi. Non c’è bisogno di nessuna forzatura per verificare come il comunismo fosse già stato ampiamente sperimentato (tenendo fra l’altro conto del disconoscimento marxista di qualsivoglia forma di innovatismo) dalla storia: ad esempio, con gli “usi civici” nel mezzogiorno, una consuetudine che riverberava il Mir russo e cioè il diritto all’uso produttivo della terra del latifondo per i contadini privi di ogni titolo di proprietà.
Il punto, oggi, è quello di riappropriarsi di un “progetto” che distingua, separi un futuro da un altro. In buona sostanza, è tempo di ritornare a una lotta che esca da un economicismo sindacale suicida (come ampiamente dimostrato negli avvenimenti sindacali prodotti dalla cosiddetta Triplice) per contaminare i luoghi della politica. Perché non è, dopo quella di Pomigliano e Melfi, la lotta di Mirafiori che deve essere posta al centro dell’azione, non uno specifico accordo sindacale, ma un progetto politico capace fra l’altro di rimediare ai guasti di una sinistra smarrita. È sempre il bisogno a generare le azioni: quello attuale – determinato dalla ciclica crisi di un capitalismo percepito più dall’esterno come vincente di quanto non si ritenga esso stesso (come spiegano i planetari fallimenti da Parmalat in giù) – risponde all’esigenza di difendere o prendere il lavoro. Un’occasione per il movimento dei lavoratori, dei precari, dei non garantiti (giovani e non) per passare alla cassa della storia per esigere la moneta contante coniata da un nuovo corso: quello prodotto da una nuova politica. Senza scomodare mummie più o meno ammuffite o attualissime, perché è esercizio che non ci interessa, dobbiamo ri-trovare nell’ideologia quella forza che nel 900 era stata in grado di riscattare il mondo operaio sul piano sociale/economico, mancando “solo” l’ultimo traguardo: in vero, il più importante, quello politico. Ma abbiamo già identificato alcune icone di quel fallimento, con buona pace degli orfani di Lama e Berlinguer. A livello sindacale la strada intrapresa dalla Fiom non solo è quella giusta, ma è in colpevole ritardo rispetto a quel percorso che andava intrapreso già all’indomani dell’insediamento di Marchionne sul trono della Fiat, ché il suo discorso “d’insediamento” conteneva già tutti quei semi germogliati poi in tanti fiori del male, fino alla più devastante: l’imperiale tradizione del divide et impera, a somiglianza di un premier che nel 2001 voleva stringere la mano al padre dei fratelli Cervi…