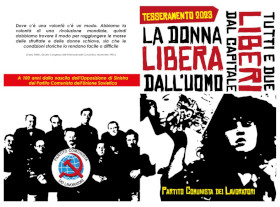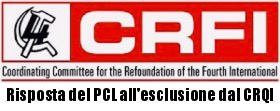Primo congresso
IL PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI NELLA SITUAZIONE POLITICA ITALIANA
ANALISI, RAGIONI, INDIRIZZO POLITICO E PROGRAMMATICO DEL PCL
L’esperienza degli ultimi 20 anni di vita politica italiana conferma l’esigenza di un nuovo partito del mondo del lavoro e delle classi subalterne: al servizio dell’indipendenza della classe operaia e di una prospettiva socialista.
Capitolo 1 - LA TRANSAZIONE ALLA SECONDA REPUBBLICA E LA VICENDA POLITICA DEGLI ULTIMI 20 ANNI
LA SVOLTA DELLA SECONDA REPUBBLICA. IL CROLLO DELLA DC CAPITALIZZATO DALLA BORGHESIA, GRAZIE ALLE SINISTRE ITALIANE
Il crollo internazionale dello stalinismo nell’89-91 ha avuto ampie ricadute sulla situazione politica italiana.
Di fronte alla nuova competizione capitalistica internazionale che si delineava, e alla necessità d’ingresso nel nuovo concerto imperialistico europeo (U.E.), il capitalismo italiano ha avuto la necessità di liberarsi delle zavorre ereditate dalla cosiddetta “Prima Repubblica” e dalla fase precedente della lotta di classe: l’ “eccesso” di spesa pubblica, il peso tradizionale dell’aziendalismo statale (partecipazioni) e soprattutto le conquiste sociali dei lavoratori strappate con l’ascesa dell’autunno caldo e dei primi anni 70 (conquiste erose nel corso degli anni 80, ma non ancora distrutte).
Realizzare questo programma di riforma strutturale e sfondamento sociale richiedeva una modifica profonda degli assetti di rappresentanza della politica borghese. Nuove condizioni consentivano e sollecitavano questa svolta.
Nel Nord del paese la morsa della crisi, della pressione fiscale, dei costi tangentizi nella spartizione degli appalti spingevano ampi settori di piccola-media borghesia ad uno scollamento dal grande capitale, trovando nella Lega (e poi in Forza Italia) il proprio canale d’espressione e approfondendo la crisi del blocco sociale democristiano: già colpito, in particolare nel SUD, dalla pesante riduzione degli spazi economici di redistribuzione clientelare.
Parallelamente lo scioglimento del PCI (a partire dalla Bolognina) e la nascita del PDS in un contesto internazionale nuovo, liberava la disponibilità di un nuovo strumento di governo per la borghesia: uno strumento tanto più prezioso se capace, grazie alle proprie radici popolari, di garantire un pacifico passaggio sociale dei nuovi pesanti sacrifici che l’ingresso nella U.E. comportava.
La magistratura borghese, col sostegno della grande stampa capitalistica, fu la levatrice dell’affondamento dei partiti di governo della “prima repubblica” (Tangentopoli) e dell’apertura di una nuova stagione.
Il varo del sistema maggioritario, sul piano nazionale e locale, e la progressiva riorganizzazione bipolare della rappresentanza politica corrispondevano ad una precisa esigenza di classe: rafforzare la governabilità dell’offensiva capitalistica contro i lavoratori italiani, grazie ad una maggiore stabilità dell’esecutivo e ad una maggiore autonomia del Parlamento dall’elettorato. Il PDS, a sua volta, vero motore del maggioritario, vedeva nel nuovo sistema istituzionale la polizza assicurativa del proprio accesso al governo a braccetto col grande capitale e l’uscita definitiva dalla “minorità” del vecchio PCI.
La stessa genesi della cosiddetta “seconda Repubblica”, racchiudeva così una lezione di fondo e un bilancio storico: i gruppi dirigenti della sinistra consentivano al capitalismo italiano di egemonizzare dinamica e sbocchi della crisi della prima Repubblica. Dopo aver imprigionato ciclicamente il movimento operaio nelle politiche di unità nazionale e di compromesso storico con la DC (nel primo dopoguerra agli ordini della burocrazia di Mosca, negli anni 70 nel nome del proprio autonomo appetito di governo) gli eredi del PCI consentivano che la crisi storica del regime democristiano venisse capitalizzata dalla grande borghesia in cambio di una propria legittimazione ministeriale, e successivamente di un proprio accreditamento come diretta rappresentanza borghese.
Per 20 anni la classe operaia italiana ha pagato i costi sociali e politici di questo scambio.
Parallelamente nessun’altra formazione della sinistra ha contrastato realmente tale deriva.
Il Partito della Rifondazione Comunista, in particolare – pur nato dallo scioglimento del PCI e dalla crisi dello stalinismo – si è rapidamente e progressivamente adattato al regime dell’alternanza borghese. Prima in forma irregolare e contraddittoria. Poi in forma organica, come sinistra di governo del Centrosinistra. In ogni caso, non solo non ha rappresentato un’alternativa di direzione per la classe operaia e i movimenti, che pure ha ciclicamente intercettato: ma ha costituito uno strumento di loro subordinazione al quadro borghese bipolare, nazionale e locale. E, dal governo o dalla sua maggioranza, uno strumento di attacco alla loro condizione.
ANNI 90. LA LUNGA LEGISLATURA DEL CENTROSINISTRA. LA “RIVOLUZIONE PASSIVA” DEL CAPITALE
Gli anni 90 hanno segnato un’offensiva e riorganizzazione strutturale del capitalismo italiano. L’attacco alla spesa sociale, con i ripetuti colpi alla previdenza pubblica nel 92, nel 95, nel 96; i processi di privatizzazione e liberalizzazione che hanno investito in forme e misure diverse, i gangli vitali dell’economia e della società (industria, telecomunicazioni, energia, scuola, sanità, trasporti, poste); i primi processi di privatizzazione e concentrazione del settore bancario; le leggi di precarizzazione del lavoro, col pacchetto Treu (97), hanno inciso a fondo, nel loro insieme, sulla società italiana, realizzando una sorta di “rivoluzione passiva”.
Con l’eccezione di una breve parentesi berlusconiana (94) questo intero processo è stato guidato dalla coalizione di centrosinistra, nella sua progressiva evoluzione e configurazione (dal “Polo progressista” all’ “Ulivo”), su mandato delle grandi famiglie del capitalismo italiano.
L’apparato DS e la burocrazia della CGIL hanno rappresentato l’architrave di questa politica, al servizio della grande borghesia: prima contenendo la prova d’urto della reazione operaia del 92 alle politiche del governo Amato, alla sua finanziaria di sfondamento, alla distruzione della scala mobile; poi siglando il grande accordo di concertazione col governo Ciampi (93); poi liquidando il grande sciopero generale contro il governo Berlusconi e il suo attacco alle pensioni (accordo Berlusconi/CGIL/CISL/UIL del 1° dicembre 94), sulla via della ricomposizione di un quadro di Centrosinistra (Dini); infine garantendo la pacifica subordinazione dei lavoratori all’intera legislatura di Centrosinistra (96-2001) e ai diversi governi che ne furono espressione (Prodi, D’Alema, Amato) sul terreno di una pesante politica antioperaia.
I gruppi dirigenti del PRC, a loro volta, a partire dal 93, si sono subordinati a questo corso: in un primo tempo siglando un accordo di governo col Polo progressista per le elezioni del 94, poi vinte da Berlusconi; in un secondo tempo realizzando l’appoggio esterno al governo Prodi proprio nella fase strategica di ingresso nell’euro e di massimo affondo antipopolare (96-98): col voto alla finanziaria di 70.000 miliardi, al pacchetto Treu, alle leggi antimmigrazione, alla detassazione di rendite e profitti. Infine rompendo col governo, a conclusione del grosso del lavoro sporco, ma con l’obiettivo strategico di ricomporlo.
Complessivamente, il capitalismo italiano ha realizzato nel decennio, sui sacrifici di grandi masse, un mutamento a proprio vantaggio dei rapporti di forza tra le classi e un aggiustamento strutturale parziale ma reale.
Sullo stesso terreno della politica estera l’espansione italiana nei Balcani sullo sfondo della riforma professionale dell’esercito, ha ricollocato l’imperialismo italiano nella spartizione internazionale delle zone d’influenza.
E tuttavia, paradossalmente, proprio il successo dal punto di vista capitalistico dell’azione di centrosinistra, logorò progressivamente il blocco sociale su cui la coalizione poggiava. La subordinazione della classe operaia al grande capitale produsse negli anni una grande disaffezione e passivizzazione, sociale e politica, in ampi strati popolari. La vittoria di Berlusconi nel 2001 non fece che capitalizzare questo processo.
Quelle sinistre che avevano sacrificato i lavoratori a Confindustria, avevano perciò stesso spianato la strada alla reazione. Non poteva esservi una responsabilità più grande, e un fallimento più clamoroso.
IL GOVERNO DI CENTRODESTRA (2001-2006). NATURA E CONTRADDIZIONI DEL BERLUSCONISMO
Il governo Berlusconi ereditò, a proprio vantaggio, il lungo lavoro antioperaio del centrosinistra. Tutte le leggi e misure fondamentali varate dal centrosinistra nella legislatura precedente, furono salvaguardate dalle destre (dalle leggi di precarizzazione alla missione militare nei Balcani). E al tempo stesso i nuovi rapporti di forza ereditati venivano assunti come base di partenza di un nuovo affondo sociale (legge Moratti, legge 30, legge Maroni sulle pensioni).
Tuttavia, come nel 94, seppur in un quadro di governo stabilizzato, emersero rapidamente tutti i fattori di debolezza del nuovo governo.
Il berlusconismo incarnava una piccola consorteria di interessi particolari, aziendalistici e di clan, poco atta a rappresentare, in forma organica, l’interesse generale del capitalismo italiano. L’asse di governo tra Forza Italia e Lega – perno della legislatura – accentuava i caratteri irregolari e populistici della coalizione emarginando dallo stesso governo gli esponenti più organici del capitale finanziario e delle grandi famiglie (dimissioni del ministro degli esteri Ruggero, uomo della FIAT). La legislazione ad personam attorno agli affari privati del presidente del consiglio rafforzava l’immagine di inaffidabilità del governo agli occhi della grande borghesia. Il grande capitale faceva affari lucrosi con Berlusconi (legge 30) ma non si sentiva rappresentato da Berlusconi.
La linea di politica estera del Centrodestra, estranea alla centralità europeista e fortemente dipendente dall’amministrazione Bush (partecipazione all’avventurosa missione irakena), contraddiceva l’orientamento strategico dei settori decisivi del capitalismo italiano, interessati ad una relazione negoziale con gli USA a partire dal proprio interesse autonomo e dall’opzione europea.
La linea di gestione dello scontro di classe da parte del nuovo governo riproponeva la logica fallimentare del 94. Da un lato una linea di scontro frontale sul terreno dell’articolo 18, che disperdeva l’asse concertativo tra grande padronato e CGIL (contro le stesse aperture iniziali di quest’ultima) e favoriva una massiccia ripresa di conflittualità sociale. Dall’altro lato l’incapacità di stabilizzare un quadro concertativo sostitutivo con CISL e UIL (Patto per l’Italia), a causa anche della crescente ingovernabilità delle contraddizioni interne al Polo. La crisi progressiva della direzione D’Amato in Confindustria quale sponda del berlusconismo, accompagnò il logoramento del governo.
L’arretramento delle posizioni del capitalismo italiano sul terreno della competizione internazionale tra il 2001 e il 2005, ma soprattutto la grande ondata di mobilitazioni popolari tra il 2001 e il 2003 approfondirono la crisi del blocco di consenso berlusconiano favorendone il progressivo declino.
Proprio in quel contesto la borghesia italiana maturò una preoccupazione centrale: evitare che la crisi del berlusconismo potesse travolgere gli equilibri sociali costruiti nella fase precedente innescando un conflitto di classe ingovernabile; e quindi predisporre un’uscita borghese dalla crisi del berlusconismo.
L’Unione di Centrosinistra corrispondeva allo scopo. La sua funzione fu quella di subordinare il movimento operaio e i movimenti di massa ad una prospettiva di alternanza borghese. Così, mentre i D.S., in concorrenza e convergenza con la Margherita, si candidavano a ricomporre una rappresentanza centrale della borghesia, PRC, PDCI, sinistra DS (e burocrazia CGIL) lavorarono a disinnescare le potenzialità esplosive dei movimenti di lotta per consentire il varo di un nuovo centrosinistra: Sergio Cofferati si preoccupò di usare il movimento di classe in funzione delle proprie (sfortunate) ambizioni politiche, impegnandosi a evitare una precipitazione dello scontro sociale a favore di una sua diluizione e gestione d’immagine; il PRC e Fausto Bertinotti si preoccuparono di usare il movimento noglobal, le grandi mobilitazioni pacifiste e persino il referendum sull’estensione dell’articolo 18 in funzione della rinegoziazione di un proprio ingresso diretto nel futuro governo.
L’operazione riuscì.
Berlusconi perse, sia pure di poco, le elezioni del 2006. Ma fu la borghesia a capitalizzare in proprio quella sconfitta, grazie a una sinistra italiana che, in cambio di ministri, le consegnò un’intera stagione di lotte.
IL CARATTERE GRANDE BORGHESE DEL GOVERNO PRODI. LA CRISI DEL SUO BLOCCO SOCIALE E POLITICO
Il governo Prodi si è candidato a rilanciare l’offensiva della grande borghesia, in un quadro di ritrovata concertazione.
Il programma dell’Unione, al di là della confezione elettorale era assolutamente inequivoco persino nella sua dizione formale: “alleanza leale con gli USA” in un quadro multilaterale; “centralità del risanamento del debito”, “aumento graduale dell’età pensionabile”, nessuna abolizione della legge 30…. E’ il programma del grande capitale, commissionato dai nuovi vertici di Confindustria, sostenuto dalle banche e dalla grande stampa, garantito dai fiduciari diretti del capitale finanziario nel nuovo esecutivo (Padoa Schioppa). E’ il programma che già Prodi aveva annunciato durante la propria campagna di investitura alle primarie (“sarà necessaria una terapia schok di sacrifici”). Per oltre un anno il nuovo governo ha perseguito questo programma annunciato, riflesso dalla sua base materiale: non ha “tradito” il mandato dei movimenti, ha semplicemente rispettato il mandato reale del padronato.
Per oltre un anno tutte le sinistre italiane e le burocrazie sindacali hanno votato e sostenuto questo programma. E non per “errore”: ma in cambio del sospirato ruolo governativo e concertativo, e quali garanti della pace sociale. Con ciò hanno consentito al centrosinistra nonostante la debolezza dei suoi numeri parlamentari, una politica che il centrodestra non avrebbe avuto la forza di realizzare, a fronte della prevedibile opposizione popolare.
Per oltre un anno, il governo ha sviluppato un rilancio della proiezione imperialistica italiana con particolare riferimento al Medio Oriente (missione libanese) e, in termini economici, all’India e alla Cina. Provvedendo in questo quadro all’aumento massiccio delle spese militari.
Ha fornito un sostegno pubblico senza precedenti alle grandi imprese e alle banche, con la gigantesca operazione del cuneo fiscale nella prima legge finanziaria (5 miliardi di euro iniziali e 7 a regime) e con l’ulteriore regalia della seconda finanziaria (riduzione del 20% di tasse alle imprese).
Ha realizzato l’aumento dell’età pensionabile e la revisione programmata dei coefficienti mantenendo (e in parte appesantendo) la sostanza della riforma berlusconiana: sino ad anticipare di un anno il travaso forzato del TFR nei fondi pensione, come chiedeva il grande capitale finanziario.
Ha preservato la sostanza della legge 30, in continuità col pacchetto Treu, entro un disegno di razionalizzazione e stabilizzazione del lavoro precario.
Complessivamente, un governo e una maggioranza fragilissimi in particolare al Senato, e in permanente rischio di caduta, hanno varato un programma superiore alle loro forze. Sullo sfondo di una parziale ripresa economica del 2006 (trainata dalle esportazioni e dal rilancio produttivo della FIAT) e di un potente sviluppo delle concentrazioni bancarie (S. Paolo-Banca Intesa/Unicredit-Capitalia) sostenute da ambienti di governo e intrecciate col suo gioco politico interno.
Tuttavia, dopo un anno, proprio lo sviluppo di quel programma, nel suo rapporto con le contraddizioni interne alla maggioranza moltiplica le difficoltà del governo e mette a rischio, più pesantemente che in passato, la sua capacità di tenuta. Sia in termini di blocco sociale sia in termini di equilibri politici e parlamentari.
In primo luogo tende a riproporsi, come nella precedente legislatura di centrosinistra, la linea di frattura interna al blocco sociale dell’Unione, lungo una dinamica di collisione tra pressioni sociali di segno opposto.
Da un lato la grande borghesia, incoraggiata dal primo anno di governo, spinge per uno sviluppo deciso del proprio programma su un terreno di misure più direttamente “strutturali” in assonanza con le misure concorrenziali varate parallelamente dal governo tedesco e dal governo francese: ulteriore abbattimento del livello di tassazione delle imprese; riforma delle regole della contrattazione in direzione del suo decentramento e di una più diretta subordinazione dei salari alla produttività; privatizzazione delle municipalizzate; riforma del pubblico impiego in direzione di più marcati rapporti privatistici e abbattimento della spesa. Un programma che, nel suo insieme, forza i fragili equilibri interni dell’Unione e restringe lo spazio reale di mediazione con le sinistre di governo.
Dall’altro lato la base popolare del centrosinistra, a partire dal lavoro dipendente, accentua progressivamente il proprio distacco dal governo Prodi. Sin dall’inizio il livello di fiducia attiva del popolo della sinistra verso il nuovo governo era sensibilmente più ridotto che al piede di partenza della legislatura precedente di Centrosinistra. La politica confindustriale di un anno di governo ha trasformato il benevolo scetticismo iniziale in una sfiducia dilagante. Questa sfiducia ad oggi fatica a tradursi in reazione generale di lotta, tendendo invece ad assumere i caratteri della rottura passiva. Una rottura che investe l’insieme della coalizione di governo, come ha documentato l’esito delle elezioni amministrative di maggio 2007: laddove lo sviluppo massiccio dell’astensione elettorale a sinistra, anche in regioni come la Toscana e l’Emilia, ha assunto il significato di un vero e proprio sciopero del voto verso tutte le principali forze di governo. A sua volta questo sentimento generale di distacco, alimenta, a livelli diversi, casi ripetuti di contestazione attiva del governo (fischi di Mirafiori contro la prima finanziaria, manifestazione di Vicenza contro la politica estera del governo, proteste contro l’accordo del 23 luglio) e, talvolta, della stessa sinistra che lo sostiene (contestazioni a Bertinotti): casi emblematici, in forme diverse, di una linea di frattura e, in un certo senso, di un potenziale di rivolta.
Inoltre la piccola borghesia professionale e commerciale, come alcuni settori di pubblico impiego, si trova stretta nella morsa dell’aumento dei prezzi con l’euro, di una politica fiscale tesa alla riduzione del deficit pubblico, di processi di concentrazione e liberalizzazione del mercato (decreto bersani). Un processo di instabilità economica che risveglia in questi settori tensioni e malumori sociali che si indirizzano contro il sistema politico (la casta) a sinistra verso una contestazione dei partiti e dei sindacati (grillismo, girotondi e manipulite); a destra verso politiche di garanzie di carattere sicuritario e xenofobo contro l’immigrazione e la criminalità. Un attivismo di questi settori che, nel quadro di frammentazione e conflittualità che attraversa il sistema sociale, coagula su entrambi i fronti settori della classe operaia e del lavoro dipendente, cionvolgendoli in movimenti dichiaratamente reazionari (mobilitazioni “progromiste” di Pavia, comitati di quartiere, campagna contro i rom, attenzione e penetrazione sociale di alcuni casi eclatanti di cronaca criminale) o di impronta radicalmente liberale (legge elettorale uninominale, non elezione dei parlamentari condannati, ecc).
In secondo luogo la polarizzazione interna al blocco sociale di centrosinistra si riflette nella polarizzazione interna alla maggioranza di governo.
Da un lato il costituendo Partito Democratico, col lancio di Walter Veltroni si candida apertamente a intercettare la domanda programmatica della grande borghesia (recupero della cosiddetta “questione settentrionale”). L’operazione dell’accordo di luglio su pensioni e precariato, saltando la logica della mediazione preventiva col PRC, ha rappresentato un investimento in questo progetto. Il tentativo parallelo di recuperare la crisi di consenso popolare con il cavalcamento della peggiore demagogia reazionaria (campagne antirom, antilavavetri ecc. …) va, in forme diverse, nella medesima direzione: una politica grande borghese, per aggirare la propria crisi di consenso, ha bisogno di ricorrere al più volgare populismo.
Dall’altro lato proprio il PRC vede precipitare la propria crisi. Dopo un anno di servizi alla borghesia italiana contro i lavoratori, non solo si vede disertato sempre più da fasce consistenti del proprio elettorato, dei movimenti, della propria stessa base militante (9 giugno), ma vede messo in discussione il proprio potere di concertazione da un partito democratico che minaccia, in prospettiva, di scaricarlo (maggioranze “di nuovo conio”). E’ un autentico vicolo cieco. Per un verso il PRC non vuole rompere col governo, perché significherebbe confessare un fallimento senza ritorno, compromettere il disegno di ricomposizione in atto nella sinistra di governo, e soprattutto perdere definitivamente con un bis del 98, i riconoscimenti e le benemerenze conquistati faticosamente presso gli ambienti liberali (con tanto di ruoli ministeriali e cariche istituzionali): da qui il sostegno alla nuova legge finanziaria confindustriale. Per altro verso il PRC ha difficoltà a reggere l’attuale situazione, pena un rischio reale di dissolvimento passivo e di crollo. Per questo ha bisogno di ottenere qualche concessione d’immagine da presentare alla propria base e al proprio elettorato di riferimento per cercare di dare un senso riconoscibile alla propria presenza ministeriale. E tuttavia proprio questa esigenza vitale cozza col nuovo corso del partito democratico e con le compatibilità interne alla coalizione: che registra un processo di frantumazione concorrenziale del Centro, a latere del partito democratico, nel segno dell’irrigidimento antiPRC (operazione Dini, Unione Democratica di Bordon, autonomizzazione di Di Pietro, fibrillazione di Mastella). Tutto dunque concorre ad approfondire ulteriormente la crisi del PRC.
In questo quadro generale di impasse, al netto dei possibilissimi incidenti parlamentari, la sorte del governo Prodi è sempre più la variabile dipendente di fattori esterni: la soluzione delle contraddizioni interne al Centrodestra che hanno operato come fattore di tenuta del governo), gli spazi d’accordo parlamentare sulla riforma della legge elettorale (o eventualmente su un nuovo ciclo di riforme istituzionali). Di certo appare improbabile la conclusione della legislatura da parte dell’attuale esecutivo. E il fossato che la sua politica ha aperto con le ragioni sociali di larga parte dell’elettorato dell’Unione già configura la forte possibilità in prospettiva di una rivincita reazionaria di Berlusconi ancor più netta che nel 2001.
Come nel 96-2001, il centrosinistra confindustriale si configura dunque come il miglior volano delle destre. Come nel 96-2001 la subordinazione delle sinistre al Centro borghese liberale le rende responsabili di un disastro non solo sociale ma politico per le classi subalterne.
CAPITALISMO ITALIANO E COMPOSIZIONE DI CLASSE
Nonostante i processi di riorganizzazione strutturale degli ultimi vent'anni e l'attacco profondo alle classi lavoratrici, il capitalismo italiano preserva diversi e specifici fattori di debolezza.
I gruppi industriali con un fatturato superiore ai 20 miliardi di euro sono un numero ristrettissimo (FIAT-ENI-ENEL). L'Italia conserva una propria egemonia internazionale in settori a bassa tecnologia (come nel tessile o nel mobile), ma il suo peso nel settore strategico dell'alta tecnologia è sostanzialmente marginale, ed anzi ha registrato negli ultimi dieci anni un ulteriore arretramento (informatica, chimica, elettronica di consumo). La crisi capitalistica internazionale ha colpito ripetutamente vecchie produzioni di punta dell'Italia (prima l'automobile, oggi in ripresa; poi l'alimentare...) spingendo settori decisivi della stessa grande impresa verso l'ambito protetto dei servizi (Benetton in Autostrade, Pirelli in Telecom...) segnati da un più alto saggio di profitto. Ciò che ha ulteriormente indebolito il peso internazionale dell'industria italiana.
La piccola impresa e l'economia dei distretti – a lungo forma caratteristica del capitalismo italiano - sono state attraversate da processi di crisi e differenziazione interna. La piccola impresa legata alla sub fornitura, largamente prevalente, è stata penalizzata negli anni dalle difficoltà della grande industria, dal suo parziale ripiegamento nei servizi, dai suoi processi di delocalizzazione all'estero (in particolare nei Balcani), che l' hanno privata di un mercato di sbocco relativamente stabile. La piccola impresa proiettata nell'esportazione (e spesso spinta all'export proprio dalla crisi della subfornitura interna) si è trovata esposta alla concorrenza internazionale senza poter più utilizzare la svalutazione del cambio per sostenere la propria competitività. Complessivamente le dinamiche di crisi che hanno investito parte rilevante della piccola impresa, hanno agito come fattore importante nella composizione del blocco sociale reazionario.
Il combinarsi della crisi della piccola impresa e della corsa all'acquisto dei servizi pubblici da parte delle grandi imprese grazie alle privatizzazioni – ciò che richiedeva enormi spese di capitale – ha generato una crescita esponenziale dell'indebitamento delle imprese verso le banche (oggi al massimo storico), favorendo di riflesso una più estesa partecipazione bancaria al capitale d' impresa, con effetti contraddittori. Da un lato un allargamento della base materiale del capitale finanziario, attraverso un più elevato intreccio di capitale industriale e bancario; dall'altro una più elevata e diretta esposizione delle banche – e quindi dei “risparmiatori” - alle incognite del “rischio impresa”.
Parallelamente questi stessi fattori si sono combinati, dialetticamente, con elementi di compensazione e controtendenza.
Le banche ed il sistema bancario nel suo insieme hanno accresciuto il proprio potere nel capitalismo italiano. A differenza che nell'industria, i processi di privatizzazione del credito che hanno percorso gli anni '90, hanno prodotto una modifica strutturale profonda nel settore. Prima il processo di concentrazione di Sanpaolo-IMI-Banco di Napoli attorno al Gruppo San Paolo IMI; poi il processo di concentrazione di COMIT, CARIPLO, Banco Ambrosiano attorno al Gruppo Intesa; ma soprattutto le grandi fusioni bancarie dell'ultimo biennio San Paolo-Intesa ed Unicredito-Capitalia, sullo sfondo della crisi di Mediobanca, hanno accresciuto non solo le capacità finanziarie delle banche italiane, ma anche il loro peso internazionale oltre che il loro peso politico interno.
Soprattutto negli ultimi anni si è evidenziata una forte spinta ad un’integrazione non subordinata con il capitale europeo, spinta che ha determinato la capacità di alcune grandi imprese di attestarsi solidamente sul mercato continentale. Dopo la catena di significativi insuccessi degli anni 80/90 (DeBenedetti e SGB, Continental e Pirelli, Fiat e Gm, ecc) si stanno concretizzando rilevanti fusioni transnazionali che hanno per protagonisti settori del capitalismo italiano: Telecom e Telefonica, Autostrade e Abertis, Enel ed Endesa, senza contare la crescita rilevante di Finmeccanica nel polo militare ed elettronico e di Unicredit nel settore bancario. E contemporaneamente quei settori di grande capitale italiano che negli scorsi anni hanno combattuto, con le unghie e con i denti, per mantenere il controllo in settori cruciali del sistema produttivo e finanziario nazionale sono stati più volte sconfitti o limitati: dal tentativo più volte respinto della Fininvest di acquisire una centralità oltre il settore televisivo (con il proprio successivo interesse per Telecom, Fiat e Generali,) sino al clamoroso crollo dell’aggregato Bpl-Hopa-immobiliaristi-Unipol nella battaglia del 2005/2006 per il controllo di Antonveneta. Anche se, in questo nuovo assetto che il grande capitale italiano sta conquistando, ancora molti rimangono i conflitti ed i nodi da sciogliere definitivamente (dal controllo delle Generali e a quello del gruppo RCS)
La ristrutturazione capitalistica ha prodotto l'emergere di una nuova leva di borghesia industriale, composta da imprese che oscillano tra uno e cinque miliardi di fatturato annuo (Geox, Todd's, Brembo, Ferrero...) molto proiettate verso l'esportazione e in stretto rapporto d'affari con le banche. Un settore meno assistito dallo Stato rispetto alla grande impresa, e per questo segnato da uno spazio di manovra politica più ampio. Un settore dinamico, oltretutto protagonista – in blocco con le vecchie grandi famiglie – del ricambio di vertice in Confindustria (Montezemolo), attraverso la costruzione di un'operazione egemonica su ambienti dell'industria del Nord.
L'ascesa asiatica, in particolare cinese ed indiana, ha cominciato ad agire come fattore di ripresa e di traino dell'esportazione di merci e capitali italiani, in particolare negli ultimi due anni. A sua volta la forte impennata produttiva della grande impresa italiana nell'industria pesante (siderurgia, meccanica...) nel 2006-2007 sospinta da un alto saggio di profitto sul mercato estero, rappresenta in parte un moltiplicatore economico. L'uscita della FIAT dalla grande crisi del 2001-2002, grazie principalmente alla netta crescita delle esportazioni, agisce nella medesima direzione.
Al polo opposto, contro tanti luoghi comuni, il proletariato italiano conosce complessivamente una significativa estensione.
La classe operaia industriale, pur ridimensionata nella grande impresa durante gli anni '90, registra un incremento consistente negli ultimi sette anni e un ricambio generazionale in diversi settori. Paradossalmente l'enorme sviluppo del lavoro precario costituisce una delle forme della proletarizzazione giovanile, anche nell'industria. Al tempo stesso cresce l'ingresso dei lavoratori stranieri, comunitari ed extra comunitari, nel proletariato industriale.
Aumenta parallelamente il volume complessivo del lavoro dipendente nell'ultimo decennio (da 14 milioni a 15 milioni di unità tra il '94 e il 2003), parallelamente ai processi di proletarizzazione di lungo periodo – in fatto di status sociale, livello di reddito, organizzazione del lavoro – di ampi settori di vecchio lavoro impiegatizio pubblico e privato (nella scuola, nelle banche, nei trasporti...).
L'aumento del lavoro autonomo para subordinato dal '94 al 2005 (in assoluto ma non in percentuale sul mondo del lavoro nel suo insieme) si configura anch'esso, di fatto, come una forma di estensione del lavoro dipendente precarizzato. Capovolgendo e smentendo le concezioni diffuse di tanta sociologia borghese e piccolo borghese, alla moda negli ultimi anni '90, sui miracoli della “autoimprenditorialità”.
Complessivamente, nella materialità della sua condizione, il proletariato italiano è l'avversario naturale e la vittima sociale del bipolarismo borghese e dei suoi interessi di riferimento. Sotto il centro destra, come sotto il centro sinistra, la crisi del capitalismo italiano, sullo sfondo della nuova competizione mondiale, si riversa innanzitutto sulla condizione della classe operaia e del lavoro dipendente.
Il blocco sociale reazionario di centro destra fonda sull'attacco al lavoro dipendente la propria tenuta interna: compressione salariale, abbattimento delle tutele sociali e della spesa pubblica come leva della redistribuzione fiscale verso la piccola media impresa antioperaia, della protezione dell'evasione, della speculazione finanziaria.
Il centro sinistra fonda sull'attacco al lavoro dipendente e sulla sua subordinazione diretta all'impresa, tramite la concertazione, la politica di regalia e sostegno al grande capitale industriale e bancario e delle privatizzazioni al suo servizio.
Vent'anni di vita politica italiana smentiscono e capovolgono, sotto ogni profilo, tutte le teorie che, in particolare negli anni '90, hanno frettolosamente sentenziato la scomparsa del proletariato o della centralità della contraddizione tra capitale e lavoro. Sia l'analisi del capitalismo italiano e della composizione di classe della società italiana nella sua evoluzione; sia la lettura degli schieramenti politici d'alternanza, dei loro blocchi di riferimento e dei loro indirizzi, confermano più che mai proprio la centralità della contraddizione di classe come perno costante della vita nazionale, al di là dei livelli mutevoli di combattività e di coscienza del proletariato.
E proprio in rapporto alla dimensione oggettiva della lotta di classe si misurano innanzitutto ruolo, natura, prospettive politiche delle sinistre italiane.
PARTITO DEMOCRATICO E COSA ROSSA. L’APPRODO DI DUE PROCESSI INTRECCIATI DI TRASFORMISMO. LA CONCLUSIONE DELLA PARABOLA STORICA DEL PRC
Il Partito Democratico e la costituente della cosiddetta “cosa rossa” sono il punto storico d’approdo dei lunghi processi evolutivi delle sinistre italiane degli anni 90. In un rapporto di totale contraddizione con le esigenze delle classi subalterne, con larga parte delle loro stesse domande, con la lezione delle loro sconfitte. Non solo: proprio le sconfitte delle classi subalterne negli ultimi 20 anni, di cui quelle sinistre sono state le prime responsabili, hanno costituito il lungo laboratorio di gestazione dei due nuovi progetti. Non progetti “sbagliati” od “errori” dei gruppi dirigenti della sinistra italiana. Ma progetti coscienti e razionali di una propria stabilizzazione di ruolo all’interno della società borghese. E per di più due progetti certo diversi ma tra loro correlati.
Il progetto del Partito Democratico conclude il percorso intrapreso alla Bolognina con lo scioglimento del PCI, in direzione di una rappresentanza diretta e centrale della borghesia italiana. La transizione alla seconda Repubblica ha trascinato questa progressiva mutazione del gruppo dirigente maggioritario della sinistra.
Il vuoto di rappresentanza centrale della borghesia prodottosi con lo scioglimento della DC; l’incapacità di Forza Italia di occupare quel vuoto in virtù dei caratteri particolari del berlusconismo, hanno incentivato gli epigoni dello stalinismo italiano a travalicare la stessa soglia della socialdemocrazia in direzione di un partito borghese liberale. La moltiplicazione dei ruoli di governo nazionale (e locale) maturati dalla metà degli anni 90, sino alla conquista della Presidenza del Consiglio (con l’esecutivo D’Alema) hanno rappresentato un fattore di accelerazione di questa dinamica: ampliando a dismisura le relazioni materiali dell’apparato DS col mondo delle grandi imprese, delle banche, dei potentati locali e trasformandolo progressivamente in un canale diretto di rappresentanza borghese. La parentesi berlusconiana non invertì questa dinamica: la rinuncia di Cofferati ad ogni ipotesi di “partito socialdemocratico del lavoro” a base CGIL disperse proprio in quegli anni un possibile fattore di “resistenza” allo sbocco annunciato. Ora la scissione della sinistra socialdemocratica DS con la costituzione di “Sinistra Democratica” e la programmata fusione tra DS e Margherita sanciscono la soluzione delle contraddizioni residue e l’approdo definitivo della mutazione.
Il Partito democratico non sarà un blocco monolitico, come emerge dalle lotte interne che segnano già oggi la sua gestazione. Sarà ed è terreno di scontro tra gruppi di potere e cordate politico-finanziarie come del resto accade in ogni partito borghese. Le sue fortune politiche dipenderanno da variabili imprevedibili, a partire dall’assetto politico-istituzionale cui approderà la “transizione italiana”. Ma in ogni caso la funzione storica cui si candida è quella di dotare la grande borghesia di quel partito di massa di cui è priva da 15 anni; uno strumento centrale per la sua egemonia sociale.
Proprio lo sviluppo del Partito democratico ha liberato lo spazio per la rifondazione di una socialdemocrazia italiana.
La cosiddetta “Cosa Rossa” è la metafora di questo disegno. Il disegno ha una sua razionalità: le attuali sinistre di governo unite per un anno a sostegno delle politiche della borghesia, provano a unire le proprie forze in un soggetto comune. Sia per porsi al riparo dagli effetti della propria crisi. Sia per autotutelarsi di fronte alle incognite della riforma elettorale e del possibile innalzamento delle soglie di sbarramento. Sia per provare a rilanciare il proprio ruolo negoziale nei confronti del partito democratico.
Numerose sono le contraddizioni interne che attraversano questo progetto. Sono contraddizioni tra i diversi soggetti contraenti (diversità di collocazione internazionale in rapporto al PSE; diversità di rapporto con la burocrazia sindacale della CGIL). Così come sono contraddizioni interne a ogni soggetto: sia nel PRC, dove la stessa maggioranza bertinottiana è investita da divergenze su modalità e sbocco del processo; sia in Sinistra Democratica che già sconta la separazione di Angius e che non è disponibile a un ruolo subalterno verso il PRC. Più in generale, sul terreno di massa, gli stessi elementi di crisi che spingono all’unificazione, ne indeboliscono la capacità di richiamo a livello popolare a partire dalla quotidiana compromissione di governo delle forze coinvolte. Inoltre possibili capovolgimenti dello scenario politico con una eventuale ricollocazione obbligata delle sinistre all’opposizione potrebbero influenzare notevolmente il processo costitutivo della nuova formazione.
Piuttosto la forza intrinseca del progetto, persino al di là dell’attuale quadro politico, sta nella sua funzione materiale. La dislocazione borghese-liberale dei DS richiama infatti la necessità reale di una “nuova” socialdemocrazia: che si candidi a controllare le dinamiche di lotta dei movimenti sociali ed in particolare a subordinare il movimento operaio alle compatibilità dell’ordine borghese e all’alleanza col Partito Democratico. Questa è la natura della “Cosa rossa”, indipendentemente da tempi, modi e consistenza della sua costruzione: una sinistra di coalizione con i liberali e la borghesia. Una sinistra che invece di lavorare a capitalizzare le difficoltà di consenso delle politiche borghesi in funzione di un progetto anticapitalistico, cerca in quelle stesse difficoltà una propria funzione utile sul terreno della collaborazione di classe.
Il PRC conclude con questo approdo la propria parabola storica. In piena coerenza con la propria vocazione governativa di lungo corso; con la propria ricollocazione ministeriale nell’attuale governo; con la lunga seminazione culturale del bertinottismo, in particolare a partire dal V Congresso (2001). Ma perciò stesso in profonda contraddizione con le aspettative e le domande di una parte consistente della sua base e con l’immaginario tradizionale dell’avanguardia sociale e politica dei movimenti: un partito nato formalmente nel nome della rifondazione comunista come “cuore dell’opposizione” al bipolarismo e alla concertazione è finito dopo 15 anni nel governo della borghesia italiana come ala sinistra del centrosinistra e copertura politica della burocrazia sindacale. Il sigillo della socialdemocrazia è il coronamento naturale di questo approdo. Ed anche la chiave rivelatrice retrospettiva di un lungo equivoco sulla natura reale dei gruppi dirigenti del PRC.
Al tempo stesso la svolta governativa del PRC e il suo sbocco annunciato hanno messo a nudo la bancarotta delle componenti critiche del partito.
La principale componente delle minoranze del VI Congresso (Essere Comunisti) si è arresa pienamente al nuovo corso, finendo col ricomporsi con la maggioranza bertinottiana in cambio di ruoli di gestione nazionali e locali e di rassicurazioni istituzionali. Da qui l’accettazione della prospettiva della “federazione delle sinistre” e la conseguente disgregazione interna dell’area.
La componente di Sinistra critica (su cui torneremo), pur opponendosi alla “Cosa Rossa”, si è adattata criticamente per un anno al corso governativo del partito votando per 21 volte la fiducia al governo e teorizzando l’appoggio esterno a Prodi. Ed oggi, pur rompendo con Prodi e preannunciando il proprio distacco dal PRC, oppone alla costruzione di un Partito comunista una imprecisata “costituente anticapitalista” su un terreno politico di movimento.
In forme diverse tutte le principali minoranze del PRC hanno rimosso da sempre la centralità della costruzione di una direzione alternativa del movimento operaio e dei movimenti di massa. Da qui, prima l’assenza di una battaglia vera contro il bertinottismo, e poi o la capitolazione definitiva alla sua deriva o la rinuncia a costruire un’alternativa reale e coerente.
LA NECESSITA’ DI UN PARTITO RIVOLUZIONARIO DEI LAVORATORI
L’esperienza degli ultimi 20 anni di vita politica italiana l’evoluzione e l’approdo delle sinistre ripropongono la necessità di un partito indipendente del mondo del lavoro e delle classi subalterne. Su basi coerentemente anticapitaliste e rivoluzionarie.
L’esperienza di 20 anni dimostra che il capitalismo non ha niente da offrire di “progressivo” alla maggioranza della società italiana. I suoi progetti di fondo, economici, sociali, istituzionali, scontano un’ulteriore regressione delle condizioni sociali e degli stessi diritti di milioni di lavoratori e lavoratrici, delle masse popolari, del grosso della popolazione femminile, dei giovani, degli immigrati. Centrodestra e Centrosinistra, nel loro alternarsi, non fanno che gestire, in forme diverse, le medesime controriforme. Entro il quadro capitalistico, nessuna nuova combinazione politico-parlamentare di governo può invertire questa tendenza. I partiti che si candidano a rappresentare le classi dominanti, o a collaborare con queste, gestiscono o negoziano questa politica.
Parallelamente 20 anni di sacrifici hanno accumulato in grandi masse popolari, a partire dal lavoro dipendente, un profondo malessere sociale.
L’arretramento diffuso della coscienza politica di massa connesso a una lunga stagione di sconfitte sociali; e il lavoro sistematico di distruzione di ogni tradizione e cultura classista da parte degli stati maggiori della sinistra italiana fanno sì che questo malessere si esprima spesso in forme distorte e persino reazionarie (rigetto della “politica” in quanto tale, forme di xenofobia…). E certo le classi dominanti cercano di trasformare la sofferenza delle classi subalterne in un fattore di loro passivizzazione e disgregazione.
Ma la crisi di consenso delle politiche dominanti è e resta un problema serio per la borghesia italiana. Al di là del voto passivo che formalmente incassano nel finto gioco bipolare, i partiti dominanti registrano, dopo vent’anni, il minimo consenso reale di larga parte del loro stesso elettorato. Il loro potere si appoggia prevalentemente non sul consenso attivo ma su un sentimento diffuso di sfiducia di larghe masse nella propria forza, di mancata percezione di un’alternativa credibile. Tanto più in questo quadro l’ingresso di tutte le sinistre nel bipolarismo ha rappresentato un ulteriore fattore di demotivazione (“siete tutti uguali”) e di protezione dell’ordine borghese.
Per questa stessa ragione la costruzione di un partito di classe antisistema, che costruisca controcorrente tra le masse la coscienza delle loro ragioni e della loro forza, fuori e contro il bipolarismo borghese è tutt’altro che un fatto ideologico e di testimonianza: è un investimento attivo e concreto nella crisi di egemonia della borghesia italiana. Un fattore di sua possibile trasformazione in radicalizzazione di classe. Solo un partito comunista e rivoluzionario, radicato in ogni piega della lotta di massa, può investire l’insieme del proprio lavoro nella prospettiva dell’esplosione sociale e nella costruzione in essa di una egemonia anticapitalista, dando uno sbocco progressivo all’insoddisfazione operaia e popolare, contro ogni illusione riformista, contro ogni suggestione populista. Peraltro, proprio l’attuale diffusione di suggestioni populiste con caratteri di rottura antistituzionale, in ampi strati popolari, conferma la necessità, e indirettamente lo spazio, di un partito di classe antisistema.
L’esperienza dei movimenti di massa degli anni 90-2003 in Italia, conferma la necessità di un partito rivoluzionario radicato nella loro avanguardia. La vicenda degli ultimi decenni di storia italiana ha smentito una volta di più i luoghi comuni ricorrenti sulla scomparsa della classe operaia e sull’irrilevanza della contraddizione di classe. Nonostante il profondo arretramento e ricomposizione subiti, in particolare nell’industria, la classe operaia ha cercato di reagire ripetutamente alle politiche dominanti affacciandosi direttamente sul terreno di lotta: in particolare nel 92, nel 94, nel biennio 2001-2002. Ogni volta con grandi potenzialità, talvolta trascinando con sé altri movimenti sociali o intrecciandosi ad essi come nel 2001-2002 (movimento antiglobalizzazione, movimento contro la guerra) con una reale incidenza sulle contraddizioni dello stesso blocco sociale delle destre. In nessuno di questi casi la classe operaia ha perso sul terreno dei rapporti di forza col proprio avversario sociale e/o politico. Piuttosto è stata sconfitta dalle proprie direzioni politiche e sindacali: che hanno sussunto i movimenti di lotta come fattore di alternanza contro le loro potenzialità di alternativa; che hanno usato la forza dei movimenti, controllandola e disciplinandola, contro le loro stesse ragioni; che hanno fatto leva ciclicamente sugli stessi arretramenti materiali prodotti dalle sconfitte da esse provocate per giustificare nuovi arretramenti e nuove sconfitte. I due ultimi decenni hanno dunque riproposto, nel loro breve spaccato, la lezione internazionale dell’intero 900: i movimenti – ed anche movimenti più grandi e radicali di quelli dell’ultima fase – non sono sufficienti a se stessi e alle proprie ragioni. Senza l’incontro con un progetto cosciente, sono destinati al ripiegamento e alla sconfitta. Di più: sono destinati ad essere subordinati agli interessi e alle operazioni dei propri avversari. Nell’esperienza di lungo corso della storia italiana è la grande lezione della Resistenza e del 68/76: entrambi sacrificati dal PCI sull’altare del compromesso col capitalismo italiano. Per queste stesse ragioni la costruzione di un partito indipendente del mondo del lavoro che si candidi all’egemonia alternativa nella classe e nei movimenti, contro ogni loro subordinazione all’alternanza, è un investimento decisivo nel loro futuro. Contro ogni logica culturale di contrapposizione dei “movimenti” al “partito”, astrattamente inteso, solo lo sviluppo di un partito rivoluzionario radicato in ogni lotta può lavorare a sottrarre i movimenti all’egemonia, diretta o indiretta, delle forze dominanti e delle loro “agenzie” nella classe.
Non si tratta di una riflessione accademica sul passato, ma di uno sguardo al futuro. Non mancheranno infatti movimenti di lotta, e neppure nuovi possibili processi di radicalizzazione generale, tanto più sullo sfondo dell’attuale crisi dell’egemonia dominante. L’essenziale è evitare che rivivano le sconfitte del passato. Per questo il problema della direzione politica si ripresenta come decisivo. Peraltro, pur a fronte dell’abbassamento della coscienza politica media della classe e delle nuove generazioni, il venir meno di un grande apparato politico di controllo del movimento operaio e della sua cultura organica (PCI), e parallelamente la modesta massa critica della nuova socialdemocrazia in gestazione (“Cosa Rossa”), ampliano lo spazio storico di costruzione del partito rivoluzionario in Italia.
Ricondurre le lotte immediate a una prospettiva di alternativa di potere della classe operaia e di tutti gli oppressi è inseparabile dalla costruzione di un partito rivoluzionario.
Posizioni politico-culturali “movimentiste” o centriste (Sinistra Critica) che rifiutano la “forma partito” o la costruzione del partito, non manifestano con ciò una differenziazione filosofica, ma programmatica e di prospettiva. O si limitano a un antagonismo senza rivoluzione. O, peggio, combinano contraddittoriamente antagonismo di movimento e appoggio critico ai governi nazionali o locali (Sinistra Critica). Tutte le soluzioni organizzative che in nome del “nuovo” si sono contrapposte alla costruzione del partito rivoluzionario leninista (negli anni 70, 80, 90) hanno finito con l’adattarsi alla società borghese, fosse pure nelle vesti di una sua contraddizione antagonista. La parabola storica del “Negrismo” è quanto mai indicativa. Come lo è (su un altro versante) la sorte di tutte le sperimentazioni organizzative che negli anni 90 sono state presentate come superamento della forma partito (Convenzione per l’alternativa, Convenzione anticapitalistica ecc.). Peraltro l’approdo del gruppo dirigente storico di Democrazia proletaria prima nel bertinottismo e poi di riflesso nel governo confindustriale di Prodi è una chiave di lettura postuma dell’inconsistenza di fondo del centrismo antileninista italiano e del suo “nuovo modo di fare politica” nel nome del “movimento”.
Viceversa, la costruzione del partito rivoluzionario non si contrappone affatto alle (reali) forme di organizzazione di massa dei lavoratori, dei giovani, dei movimenti di lotta. Al contrario, ne tutela l’autonomia, ne contrasta ogni possibile subalternità, lavora alla loro estensione e sviluppo, sulla base di un progetto generale alternativo all’ordine esistente: e quindi di un lavoro quotidiano che attorno a questo progetto, combini la battaglia di movimento, il lavoro sindacale, l’utilizzo delle tribune istituzionali, la campagna culturale, l’intervento e la costruzione internazionalista; un sistema combinato di lavoro e di azione che solo un partito rivoluzionario può condurre a unità e subordinare a un fine. Parallelamente proprio l’attuale scenario di frammentazione della classe e del blocco sociale alternativo, combinato con l’arretramento della coscienza, sottolinea una volta di più la necessità di un partito organizzato, radicato nell’avanguardia sociale e politica della classe e dei movimenti, portatore di una memoria storica, impegnato a ricostruire tra le masse, in ogni lotta, il senso dell’unità di classe e di un progetto socialista.
L’esperienza degli ultimi 20 anni ripropone al tempo stesso la necessità di un partito programmaticamente rivoluzionario, non “simbolico-identitario”. L’evocazione del “Partito Comunista” come riferimento astratto e ideologico a un’indistinta “tradizione novecentesca” è un inganno politico. Non solo rimuove il bilancio dello stalinismo ma perciò stesso ripropone (fosse anche criticamente) il bagaglio delle sue mistificazioni e della sua eredità (governismo, doppiezza tra pratica istituzionale e di movimento, rapporto amministrativo e burocratico con i movimenti e le loro organizzazioni, cancellazione della prospettiva del potere come potere dei lavoratori e autorganizzazione consiliare, adattamento alle finzioni diplomatiche dell’imperialismo internazionale…).
Questa tradizione non è morta con il crollo internazionale dello stalinismo, che pur ne ha minato alla radice le vecchie basi materiali, ma si ripropone nelle politiche dei “partiti comunisti” eredi di quella stagione: o nelle vesti di partiti di governo con la propria borghesia (dall’India al Sudafrica) o nelle vesti di partiti dominanti restauratori del capitalismo (dalla Cina al Vietnam). In Italia la riproposizione di quella tradizione nel PDCI o nella corrente grassiana del PRC si è espressa nel blocco di governo con la borghesia italiana, nel voto alle missioni di guerra e alle politiche di Confindustria, al fianco della socialdemocrazia bertinottiana. I fatti hanno dimostrato definitivamente che il togliattismo non può rappresentare alcuna alternativa alla socialdemocrazia.
La costruzione di un partito indipendente della classe operaia e dei movimenti di lotta passa dunque per la rottura radicale con lo stalinismo e ogni sua eredità. Passa per il recupero e riattualizzazione di quel patrimonio di principi e di programma su cui nacque il movimento comunista e che stalinismo e socialdemocrazia hanno insieme colpito e disperso. Solo il recupero di quelle fondamenta, il loro sviluppo e investimento nell’attuale scenario storico della lotta di classe, il loro incontro e fusione con l’esperienza viva e la maturazione dell’avanguardia sociale e politica della classe operaia e dei movimenti di lotta, possono segnare la rinascita autentica del partito rivoluzionario della classe operaia italiana.
Capitolo 2 - LO SVILUPPO DEL PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI COME COSTRUZIONE DEL PARTITO RIVOLUZIONARIO IN ITALIA
Il Partito Comunista dei lavoratori intende costruire il partito rivoluzionario della classe operaia e della sua avanguardia.
Il PCL nasce dalla battaglia di 15 anni nel PRC contro i suoi gruppi dirigenti, sul terreno dell’indipendenza di classe e per un programma anticapitalista.
Sin dalle origini, la prospettiva e il fine di questa battaglia è stata la costruzione del partito rivoluzionario attraverso il progressivo raggruppamento all’interno del PRC dei suoi settori di base più avanzati e radicali e un processo di selezione e maturazione di militanti e quadri rivoluzionari.
La nascita del PRC sullo sfondo del crollo dello stalinismo internazionale; l’effetto di ricomposizione politica di diversi settori del movimento operaio che la nascita di quel partito trascinò; la polarizzazione di nuovi settori operai e giovanili che la sua prolungata collocazione all’opposizione ha ciclicamente prodotto, hanno consentito ai comunisti rivoluzionari di presentare le proprie posizioni in un ambito d’avanguardia relativamente largo: di sviluppare le proprie relazioni e la propria riconoscibilità pubblica (non solo nel partito); di investire le proprie posizioni, forti di una maggiore riconoscibilità, sul terreno della lotta di classe e del dibattito dell’avanguardia. L’accumulo di questo patrimonio – e il parallelo processo di formazione dei quadri – ha costituito una prima fase decisiva della costruzione del PCL.
La battaglia contro il centrismo ha costituito una costante di questo processo di raggruppamento. A differenza dei comunisti rivoluzionari, una parte della “sinistra interna” del PRC ha inteso la propria funzione come pungolo critico dei gruppi dirigenti, senza alternativa di progetto, ed anzi col ciclico adattamento alle scelte della direzione. E’ il caso in particolare di Sinistra critica, ieri Bandiera Rossa: sostegno alla segreteria Garavini nel 91-92; rapida archiviazione della seconda mozione dopo il II Congresso del PRC (94) col sostegno alla segreteria Bertinotti nel 95; rapida archiviazione della seconda mozione al Congresso del 96 e ritorno al sostegno della linea Bertinotti nel 98/99; sostegno entusiasta alla linea Bertinotti al V Congresso del partito, presentata come “svolta rivoluzionaria” sino al 2003-2004… .
Questa condotta zizagante – ed in particolare l’abbellimento enfatico del bertinottismo nella stagione dei movimenti – ha contribuito a confondere e disorientare preziose energie militanti, a tutto vantaggio della direzione del partito e della sua propaganda mistificatrice. La ragione vera e ultima di questa politica non risiedeva affatto in una diversa concezione della tattica interna al PRC rispetto a quella dei rivoluzionari: ma in un diverso programma generale che ha sempre mitizzato la cosiddetta “dinamica oggettiva” dei movimenti sociali come leva strategica di una democratizzazione progressiva dal basso (“Democrazia partecipativa”, “Europa sociale e democratica”…); che di conseguenza ha rimosso la stessa centralità di costruzione del partito rivoluzionario a favore di una politica di pressione su Bertinotti e di un immaginario uso del bertinottismo da parte dei movimenti.
La parabola e l’approdo del PRC ha costituito la smentita più clamorosa e radicale di tutta questa impostazione. La demarcazione strategica e programmatica da questa impostazione da parte dei comunisti rivoluzionari ha rappresentato negli anni una condizione decisiva per la prospettiva del PCL.
La demarcazione dal centrismo si ripropone oggi come fattore indispensabile della costruzione del PCL e del partito rivoluzionario in Italia, in coerenza con i principi di fondo fondativi del MCPCL (i quattro punti programmatici). Sono questi i principi di fondo su cui il PCL basa la propria politica e la propria costruzione: l’indipendenza di classe dalla borghesia e l’opposizione ai suoi governi; la prospettiva strategica della dittatura del proletariato come potere consiliare dei lavoratori e delle lavoratrici; il metodo e l’articolazione delle rivendicazioni transitorie, come ponte tra la coscienza attuale delle masse e la prospettiva del potere; la costruzione del partito rivoluzionario in Italia come parte della rifondazione dell’Internazionale rivoluzionaria. L’insieme di questi principi recupera la tradizione rivoluzionaria del Partito Comunista d’Italia prima della sua degenerazione staliniana (togliattiana): in particolare recupera l’impianto strategico del programma di Lione del 26, elaborato da Antonio Gramsci. Il semplice richiamo a questi principi, naturalmente, non è sufficiente a determinare la politica quotidiana del PCL e l’articolazione concreta delle sue scelte: ciò che implica la costante attenzione all’analisi di fase e il rapporto vivo con la lotta di classe e la sua evoluzione. Ma fuori e contro quei principi nessuna politica rivoluzionaria è possibile: e si riproporrebbero nei fatti, magari in nome del “nuovo”, le mille varianti, già sperimentate, del centrismo.
L’insieme di questi principi segna oggi una linea di distinzione tra il PCL e le altre realtà dell’estrema sinistra italiana. Sia nei confronti della sua area “antagonista” (Cobas…) che combatte le politiche borghesi ma rimuove la prospettiva della rivoluzione. Sia nei confronti del costituendo soggetto di “Sinistra critica” che ripropone su basi indipendenti, tutti gli equivoci di fondo che hanno accompagnato il suo corso politico nel PRC, e il suo stesso rapporto col governo Prodi. Sia nei confronti della Rete dei Comunisti che pur collocata all’opposizione, si richiama criticamente alla tradizione stalinista, nazionale e internazionale, con inevitabili ricadute politiche (blocco con Veltroni a Roma nelle ultime elezioni amministrative).
La ricerca e la pratica dell’unità d’azione con queste forze su obiettivi comuni di lotta – fuori da ogni settarismo - è importante e utile; l’applichiamo e l’applicheremo senza riserve su scala nazionale e locale. Ogni blocco politico-programmatico con esse è invece obiettivamente improponibile, perché privo di una base comune di principio.
Il PCL combina l’intransigenza dei principi e l’autonomia del proprio progetto con la più ampia apertura nei confronti di tutti coloro che sono disponibili a convergere su di essi, indipendentemente dalla diversità delle provenienze e dei percorsi. E’ la politica del raggruppamento rivoluzionario. Questa politica che ha accompagnato la gestazione del PCL lungo il percorso interno al PRC, si ripropone oggi, in forme nuove, come la politica di costruzione indipendente del PCL. E’ una politica rivolta innanzitutto alla conquista di militanti, attivisti, elettori del popolo di sinistra oggi in rotta con l’Unione e con le sinistre di governo; a militanti e attivisti di componenti critiche di questi partiti che non offrono loro alcuna prospettiva; a militanti e attivisti dell’avanguardia sociale e politica della classe operaia e dei movimenti, che rifiutano di subordinarsi all’Unione di governo, ma anche di chiudersi nella propria esperienza parziale e ricercano un legame tra il proprio impegno di lotta e un progetto generale anticapitalistico. Al tempo stesso la politica del raggruppamento rivoluzionario non si rivolge solamente a singoli militanti: ma ricerca la conquista di gruppi e organizzazioni in possibile avvicinamento al marxismo rivoluzionario. Ad oggi non si configurano sul piano nazionale altri soggetti politici in via di convergenza complessiva con il PCL. Diversa e più articolata può rivelarsi la situazione sui territori e nelle realtà locali. In ogni caso è possibile che la crisi profonda del PRC e delle sinistre di governo da un lato; l’inconcludenza e l’inaffidabilità delle organizzazioni centriste dall’altro, possano liberare verso il PCL anche settori e gruppi provenienti da quelle forze. Si tratterà di monitorare ovunque queste possibili evoluzioni predisponendosi al dialogo più aperto. Ogni conquista di altre realtà, sulle basi del marxismo rivoluzionario, segnerebbe un avanzamento politico, non solo numerico, della costruzione del PCL.
Parallelamente, la politica del raggruppamento rivoluzionario ha un preciso risvolto nel lavoro di movimento.
Nel movimento sindacale, nel movimento antimperialista e “contro la guerra”, nei movimenti di emancipazione sessuale e per i diritti civili, in ogni ambito di massa, il PCL lavora a raggruppare attorno alle proprie rivendicazioni programmatiche di settore tutti i compagni disponibili, indipendentemente dalle loro diverse collocazioni organizzative: nella prospettiva di “tendenze anticapitalistiche” che sviluppino, nei rispettivi ambiti, una battaglia coerente di egemonia alternativa. Lo sviluppo concreto di questo lavoro di tendenza nei diversi ambiti si misura naturalmente con l’entità del nostro radicamento e con l’articolazione delle forze in campo in ogni settore: di conseguenza può attraversare vari passaggi intermedi. Ma l’essenziale è il metodo e la prospettiva del lavoro. E il lavoro di raggruppamento degli attivisti d’avanguardia sulle nostre posizioni di settore è un lato della costruzione del PCL come partito socialmente radicato: ed anche un ambito di conquista progressiva al PCL di nuove forze. L’esperienza del Polo obrero in Argentina, anche come bacino quotidiano della costruzione del partito rivoluzionario, è sotto questo profilo emblematico.
Il Congresso fondativo del PCL dà mandato agli organismi dirigenti del partito e alle sue commissioni di settore, di iniziare a sviluppare e articolare un piano di lavoro nei diversi ambiti di movimento nella prospettiva della costruzione, in essi, di tendenze anticapitaliste.
Proprio perché fondato su basi di principio e su una prospettiva storica il processo di costruzione del PCL non è vincolato a un quadro politico particolare.
Naturalmente il quadro di governo del Centrosinistra e la corresponsabilità in esso di tutte le sinistre definiscono uno scenario di costruzione più chiaro e diretto del PCL e del suo profilo alternativo. Non a caso il momento stesso della rottura con il PRC e l’avvio del movimento costitutivo del Partito comunista dei lavoratori coincisero con la ricollocazione di governo del PRC nel centrosinistra. E l’opposizione al governo Prodi ha costituito per un anno e mezzo la cifra essenziale del nostro lavoro di massa e della nostra riconoscibilità.
Tuttavia il PCL dev’essere pronto a misurarsi con scenari diversi e più complessi. La fragilità dell’attuale equilibrio politico può condurre, già nella prossima fase politica o in tempi relativamente brevi, a un cambio di scenario, segnato dall’estromissione di fatto delle sinistre dal governo (ritorno al governo delle destre a seguito di elezioni anticipate, o governo “tecnico” o istituzionale di decantazione in preparazione di nuovi equilibri…). Questa eventualità, col ritorno delle sinistre all’opposizione, presenta al suo interno numerose variabili. Ma difficilmente si ridurrebbe ad una semplice ricollocazione formale di caselle e posizionamenti. Il fallimento dell’Unione, a maggior ragione se combinato col ritorno di Berlusconi, tenderebbe a tradursi inevitabilmente in un processo di crisi dei gruppi dirigenti della sinistra, e della loro credibilità pubblica, già oggi in declino: in un “processo pubblico” alle loro responsabilità tra milioni di lavoratori e nel popolo della sinistra. Al tempo stesso quegli stessi gruppi dirigenti reagirebbero al fallimento della propria politica cercando di rilanciare, dall’opposizione, la prospettiva di una ricomposizione dell’alleanza di governo col Partito Democratico per una successiva stagione politica, tentando così di fuggire dal proprio isolamento e di riaccreditarsi presso gli ambienti liberali. E’ ciò che fece il PRC dopo la rottura col primo governo Prodi. E’ ciò che a maggior ragione farebbe oggi, dopo un processo di mutazione governativa più avanzata, il grosso delle sinistre italiane.
Nell’eventualità di un simile scenario, il PCL non dovrebbe arretrare di un millimetro dal progetto della propria costruzione indipendente.
Dovremmo anzi dire, più forte di prima, una verità elementare: “I gruppi dirigenti della sinistra italiana sono il principale fattore di disfatta per i lavoratori. E’ necessaria una nuova direzione, un nuovo partito”. Dovremo trarre con forza un bilancio pubblico dell’ennesimo fallimento della collaborazione di classe e dell’alleanza col Centro (Partito Democratico), rilanciando dall’opposizione la linea di massa del polo autonomo anticapitalistico. Soprattutto dovremmo cercare di far leva, una volta di più, sull’esperienza pratica di quel fallimento da parte di milioni di lavoratori, per lavorare a raggruppare e selezionare attorno a noi una nuova leva di militanti e di quadri, disponibili a resistere alla demoralizzazione e capaci di trarre un bilancio dalla lezione dei fatti.
Il processo di costruzione del PCL, e più in generale la costruzione del partito rivoluzionario non è e non sarà un processo lineare. Si intreccerà inevitabilmente, nel lungo corso, con fasi mutevoli e brusche svolte della lotta politica e di classe. Ma proprio per questo è essenziale la fermezza dei principi e la chiarezza delle basi programmatiche, la direzione di marcia di un progetto generale. Le organizzazioni centriste/antagoniste che vivono per lo più alla giornata, nel puro inseguimento della “prossima scadenza”, senza un progetto generale sono spesso travolte, al di là delle loro fortune immediate, da cambi di scenario non previsti e non razionalizzati. Così fu per l’estrema sinistra degli anni 70. Il PCL potrà reggere l’urto di possibili svolte proprio perché fondato su un progetto complessivo: e nella misura in cui saprà fare di quel progetto la leva di formazione dei propri militanti e dei propri gruppi dirigenti.
La capacità di misurarsi con le svolte, senza perdere la bussola, misura la tempra di un partito rivoluzionario.
PER LA PRESENTAZIONE ELETTORALE AUTONOMA E ALTERNATIVA DEL P.C.L.
Il PCL intende presentarsi come forza autonoma e alternativa alle elezioni politiche, amministrative e europee.
Il terreno della lotta di classe e dell’azione di massa è l’ambito centrale di lavoro e d’intervento dei comunisti. E’ il terreno di costruzione dell’alternativa anticapitalista, della prospettiva del potere dei lavoratori. Ma ciò non significa ignorare e rimuovere il terreno della lotta elettorale. In coerenza con la tradizione leninista, riteniamo che i comunisti debbano utilizzare ogni tribuna per sviluppare la propria propaganda e agitazione rivoluzionaria contro il sistema dominante. La tribuna elettorale risponde a questa esigenza. La partecipazione alla campagna elettorale rappresenta un canale prezioso di comunicazione di massa, di divulgazione popolare del programma anticapitalista, di lotta politica contro la borghesia, i suoi partiti, le sue agenzie “riformiste” nel movimento operaio, in funzione dello sviluppo del partito rivoluzionario. Così l’eventuale elezione di candidati rivoluzionari consente loro di utilizzare la tribuna istituzionale per il medesimo fine: denunciare la politica borghese, sviluppare la coscienza indipendente delle classi subalterne, favorire il radicamento di massa dei comunisti e del loro partito, in funzione del loro autonomo progetto.
Queste considerazioni valide in generale, hanno un’importanza particolare per un partito giovane come il PCL. Che ha la necessità vitale di propagandare e far conoscere le proprie ragioni, identità, progetto alle masse più larghe. Tanto più nel momento di massima compromissione di tutte le sinistre nel governo della borghesia italiana. La prima esperienza elettorale compiuta con la parziale partecipazione al turno amministrativo previsto, ha pienamente confermato l’utilità e l’importanza della partecipazione elettorale del PCL ai fini della sua riconoscibilità pubblica, dello sviluppo dei suoi legami di massa, della sua costruzione. Con la stessa logica è necessario prepararci ad affrontare le prossime prove elettorali, a partire dalle prossime elezioni amministrative: con la massima estensione possibile della nostra partecipazione. Così è necessario prepararci da subito all’eventualità di elezioni politiche anticipate.
In coerenza con le ragioni stesse della presentazione elettorale dei rivoluzionari il PCL si presenta alle elezioni come forza autonoma sulla base del proprio programma indipendente in alternativa alle coalizioni di centrodestra e centrosinistra. Sia sul piano nazionale, sia sul piano locale. I suoi eventuali eletti si collocheranno, ad ogni livello, all’opposizione delle giunte borghesi. A differenza di parte significativa dell’area centrista (Sinistra Critica) rifiutiamo ogni forma di governismo locale. Le giunte locali di centrosinistra, tanto più oggi, sono parte organica della politica complessiva della borghesia italiana (tagli, privatizzazioni, precarietà, repressione immigrati), in un rapporto organico con la rete territoriale dei poteri dominanti. Di conseguenza, l’opposizione di classe alle giunte locali di centrosinistra è parte dell’opposizione più generale alla borghesia italiana.
Non vi possono essere eccezioni.
La presentazione elettorale del PCL esclude blocchi elettorali con gruppi e formazioni di tipo centrista.
Il terreno elettorale non è, per definizione, un terreno di unità d’azione. E’ il terreno dove i rivoluzionari si affacciano con la propria proposta generale, autonoma e distinta, in funzione della costruzione del proprio partito. A maggior ragione questo vale oggi per il PCL. Che da un lato rappresenta, di gran lunga, la forza politica più significativa a sinistra del PRC, dall’altro (anche per questo) ha esigenza di farsi conoscere per quello che è, nella sua distinzione dai gruppi centristi, nella fisionomia complessiva del suo autonomo progetto. Ogni blocco con gruppi centristi sarebbe in contraddizione con questa esigenza. L’unica eccezione può porsi in presenza di gruppi e formazioni locali in reale evoluzione verso il PCL, ma non ancora pronti a collocarsi nelle sue fila: coi quali l’intesa elettorale, sul nostro programma, possa affrettare la loro conquista al partito. Ma, anche in questo caso, il criterio della scelta è sempre la costruzione indipendente del PCL.
Nelle elezioni amministrative, il PCL presenta programmi di rottura con le politiche dominanti e le loro compatibilità fuori da ogni logica di gestione dell’esistente. La bozza di programma indicato nazionalmente per la precedente elezione amministrativa costituisce il riferimento generale per l’articolazione dei programmi locali. Al tempo stesso, ferma restando l’importanza dei riferimenti programmatici al quadro locale, rifiutiamo di ridurre la nostra campagna elettorale ad un orizzonte localista. Ad ogni livello della loro presenza elettorale, i comunisti riconducono le istanze programmatiche locali al progetto complessivo dell’alternativa anticapitalista e alla costruzione del partito rivoluzionario.
Capitolo 3 - INDIRIZZO POLITICO E PROGRAMMATIVO
PER IL POLO AUTONOMO DI CLASSE ANTICAPITALISTICO
L’ASSE GENERALE DELLA LINEA DI MASSA DEL PCL
La battaglia per il polo autonomo di classe anticapitalistico è l’asse generale della linea di massa del PCL.
Si tratta di cogliere e sviluppare tutte le implicazioni di questa proposta, fuori da ogni sua interpretazione riduttiva o deviante.
Per polo autonomo anticapitalistico non intendiamo il “fronte antagonista” di estrema sinistra, ma una proposta di indipendenza di classe rivolta all’insieme della classe operaia, dei movimenti di lotta, delle loro rappresentanze, per una prospettiva di alternativa di sistema.
Naturalmente ricerchiamo e pratichiamo l’unità di lotta con tutti i soggetti politici e sindacali che si oppongono oggi al governo Prodi o che tendono a collocarsi all’opposizione; sia sul piano sindacale, sia sul piano politico. Il PCL ha svolto anzi un ruolo importante a partire dal settembre del 2006, nello sviluppo dell’unità d’azione tra forze diverse nel movimento contro la guerra e sul terreno dell’opposizione sociale, talora contrastando atteggiamenti settari o veti reciproci tra diversi soggetti. Ed oggi partecipa, come forza promotrice, al patto d’azione permanente tra le sinistre d’opposizione, contro il precariato e le politiche sociali dominanti. Ma non confondiamo la positiva unità d’azione con soggetti antagonisti contro le misure del governo con la proposta generale alle classi subalterne. La nostra politica non ha come fine la costruzione di un piccolo polo antagonista all’interno di questa società. Ha come fine la rivoluzione sociale: ciò che richiede la rottura della classe operaia con la borghesia, quindi il suo porsi come polo autonomo alternativo all’ordine costituito. La parola d’ordine del polo autonomo anticapitalistico ha dunque una valenza di massa e un respiro strategico generale.
La battaglia per l’indipendenza di classe, fondamento stesso del marxismo, è l’esigenza posta da tutta l’esperienza storica del movimento operaio italiano: ogni coalizione con la borghesia, i suoi partiti, i suoi governi, si è risolta in una disfatta sociale e politica per i lavoratori e i movimenti; e viceversa ogni risultato e conquista dei lavoratori, fosse pure contraddittoria e parziale, è stata il prodotto della loro azione di massa contro le classi dominanti.
La parola d’ordine del polo autonomo di classe non è dunque un’astrazione ideologica. Richiama l’esperienza concreta di più generazioni. Peraltro proprio l’esperienza concreta dell’attuale scenario politico ripropone la centralità di questa parola d’ordine. Da un lato l’equilibrio di centrosinistra si regge sulla subordinazione dei lavoratori e delle sinistre al grande capitale e alle sue politiche di controriforme e sacrifici. Dall’altro tutte le rivendicazioni della classe operaia e dei movimenti di lotta rivelano giorno dopo giorno, la propria incompatibilità col capitale e con l’Unione: sia le rivendicazioni economiche e sociali più elementari; sia le domande “pacifiste”; sia le rivendicazioni coerenti sul terreno dell’ambientalismo e dei diritti civili. Il PCL vuol fare emergere nella coscienza delle masse e innanzitutto della loro avanguardia ciò che è già scritto nella loro esperienza: solo rompendo con la borghesia, i suoi partiti, i suoi governi, la classe lavoratrice può aprire uno scenario nuovo e una nuova prospettiva per le sue domande ed esigenze. Solo rompendo con la borghesia e ponendosi come polo autonomo, su un proprio autonomo programma, la classe operaia può porsi alla testa di tutte le domande progressive e di emancipazione (sociali, ambientali, democratiche, di genere) espresse dall’insieme delle masse popolari e dei settori oppressi, evitando che quelle domande possano essere deviate su altri sbocchi, e ricomponendo attorno a sé un blocco sociale anticapitalistico. Per questo la parola d’ordine del polo autonomo anticapitalistico investe non solo l’intervento operaio del PCL ma tutto il suo intervento di massa e nei movimenti.
Sulla base di questa esigenza generale e dentro l’intervento di massa, la parola d’ordine del polo autonomo di classe può assumere una specifica articolazione tattica. Quella della sfida rivolta all’insieme delle sinistre e delle organizzazioni di massa che parlano a nome dei lavoratori perché rompano con la borghesia e uniscano nell’azione le proprie forze attorno a un programma di lotta indipendente.
E’ uno strumento tattico della politica leninista che può rivelarsi di grande attualità. In un momento di massima frattura tra i sentimenti delle classi subalterne e l’Unione di governo. In un momento in cui questa frattura si riverbera nella crisi interna alle stesse sinistre di governo e al loro blocco di riferimento, la parola d’ordine di sfida “Rompete con Prodi, col Partito Democratico, col Centro dell’Unione” può entrare in sintonia col senso comune di più ampi settori di classe, approfondire la crisi dei gruppi dirigenti delle sinistre, allargare lo spazio d’ascolto e d’influenza dei comunisti. E’ un’articolazione tattica che capovolge di segno la stessa evocazione tradizionale dell’ “unità”. Il termine “Unità” è usato dagli apparati di controllo del movimento operaio, per giustificare la propria unità col Centro borghese (“contro Berlusconi”), o per abbellire la costituente di una “Cosa Rossa” alleata al Centro. La parola d’ordine “Rompete con la borghesia, uniamo nell’azione le nostre forze contro la borghesia” serve a demistificare il falso richiamo unitario degli apparati. Risponde al naturale sentimento unitario dei lavoratori e del popolo della sinistra dandogli una traduzione indipendente e volgendolo contro la politica degli apparati.
Naturalmente non si tratta di uno schema rigido valido per tutte le occasioni. Si tratta di imparare a modularlo in rapporto al mutare degli scenari e alla diversità degli ambiti d’intervento. Ma è un ricorso tattico importante. Perché il compito dei rivoluzionari non può ridursi alla denuncia propagandistica di Bertinotti, Diliberto, Mussi (ed Epifani): deve cercare ogni mezzo per favorire la rottura con questi partiti dei settori migliori della loro base politica e sociale. E per questo deve saper intervenire nelle contraddizioni che li percorrono, da un punto di vista di classe e rivoluzionario.
La parola d’ordine del polo autonomo di classe anticapitalistico è strettamente correlata allo sviluppo e articolazione di una proposta programmatica transitoria, adeguata all’attuale scenario italiano: di una proposta rivendicativa e di un metodo d’intervento che partendo dalle esigenze immediate delle masse sviluppino la coscienza della necessità della rivoluzione.
Le organizzazioni centriste e/o antagoniste (come per altro verso le correnti estremiste) ignorano l’intera tematica rivoluzionaria delle rivendicazioni transitorie. Non è un caso: un progetto di puro antagonismo all’interno di questa società, o di pura propaganda letteraria del socialismo, non ha bisogno di gettare un ponte tra gli obiettivi immediati e la conquista del potere. E’ sufficiente la routine degli obiettivi minimi. Al contrario la costruzione di una prospettiva rivoluzionaria reale passa per la reale motivazione anticapitalistica di larghe masse e della loro avanguardia. Il sistema di rivendicazioni transitorie, integrato nel lavoro complessivo dei rivoluzionari, risponde a questa esigenza. Il Programma di Lione, riprendendo l’elaborazione dell’Internazionale comunista dei suoi primi congressi, poneva la necessità di “ricondurre ogni obiettivo di lotta alla prospettiva rivoluzionaria”. E lo affermava non in un contesto di radicalizzazione rivoluzionaria ma sotto i talloni di ferro del fascismo. In un contesto diverso ma con lo stesso metodo il PCL si pone l’obiettivo di sviluppare e articolare un programma di transizione per la rivoluzione italiana: su scala generale e in ogni ambito d’intervento, in stretto accordo con l’esperienza quotidiana della lotta di classe e di massa.
Non si tratta di elaborare un programma di rivendicazioni compatibili e “realizzabili” entro l’ordine borghese. Ma di collegare ogni lotta immediata e il livello attuale di coscienza a un programma di rottura col capitalismo e di potere dei lavoratori. L’anticapitalismo va ricondotto ad una dimensione “popolare” accessibile, legata all’esperienza quotidiana. Il PCL rifiuta la tipica separazione tra obiettivi minimi quotidiani e anticapitalismo “ideologico” da convegni. Vogliamo fare dell’anticapitalismo la cifra della nostra propaganda e, ove possibile, della nostra agitazione “di massa”. In rapporto al conflitto di fabbrica. Ma anche in rapporto alla speculazione sulla casa, ai mutui usurai delle banche, allo scandalo dei privilegi parlamentari, all’inquinamento dei cibi e dell’ambiente, alla questione clericale e meridionale. La necessità di un’alternativa di società e di potere emerge dall’esperienza quotidiana della società italiana, sotto ogni profilo. Far emergere questa necessità nella coscienza di massa è compito dei comunisti. Le rivendicazioni transitorie sono uno strumento di questa politica.
PER LA VERTENZA GENERALE DEL MONDO DEL LAVORO, DEI PRECARI, DEI DISOCCUPATI. PER UN LAVORO SINDACALE COMUNISTA
La proposta della vertenza generale del mondo del lavoro, dei precari, dei disoccupati è oggi la traduzione sul terreno sindacale della linea del polo autonomo di classe.
E’ una proposta di unificazione sociale del fronte di lotta e di ricomposizione del blocco sociale alternativo, a partire dalle esigenze più immediate e in rapporto al terreno attuale dello scontro.
L’Unione con la borghesia divide i lavoratori e disgrega l’unità delle classi subalterne. Vent’anni di concertazione sindacale dei sacrifici sociali – privatizzazione, precarizzazione, liberalizzazioni – hanno moltiplicato gli elementi di frammentazione e di indebolimento della forza strutturale della classe e i suoi stessi legami con le più ampie masse popolari. Oggi, il nuovo fronte d’attacco della borghesia italiana e del suo governo mira ad un’ulteriore approfondimento di questi processi di disgregazione. L’attacco al contratto nazionale di lavoro, i progetti di “riforma” della pubblica amministrazione, il nuovo attacco alla previdenza pubblica sotto la bandiera mistificante della contrapposizione generazionale rispondono a questa esigenza. La stessa campagna securitaria antimmigrazione, con autentici risvolti “pogromisti” (contro i Rom) rientra in questo quadro generale.
La proposta della vertenza generale, attorno ad una piattaforma sociale, unificante e di svolta, vuole rispondere all’offensiva dominante. L’esperienza di 20 anni dimostra non solo gli effetti sociali nefasti della concertazione, ma l’inefficacia di una risposta alla concertazione che si limiti alla pura sommatoria, in ordine sparso, e in discesa, dei diversi fronti di resistenza. Per di più in un quadro di micro-concorrenze sindacali tra le stesse forze anticoncertative. E’ necessaria una svolta unificante. Solo la rottura con la borghesia sul terreno della lotta generale può ricomporre l’unità dei lavoratori. Non significa ovviamente disimpegnarsi dai diversi fronti sociali di lotta e dalle loro specificità, ma lavorare a ricondurre ogni intervento sociale di settore ad una prospettiva comune. Tanto più a fronte dei processi di frammentazione che sono intervenuti, solo una piattaforma generale che unifichi le domande più pressanti dei diversi settori delle classi subalterne, può ricomporre un quadro comune di mobilitazione e quindi incidere sui rapporti complessivi tra le classi. Solo un’esplosione sociale concentrata e radicale può riaprire dal basso uno scenario nuovo, rafforzando come suo sottoprodotto la stessa difesa di conquiste e posizioni sociali minacciate (è l’esperienza della lotta di massa in Francia contro il CPE). Solo una esplosione sociale di lotta attorno ad una piattaforma unificante può ricomporre rapporti di solidarietà all’interno del mondo del lavoro e tra classe lavoratrice ed altri settori oppressi (immigrati) contro ogni rischio di contagio di culture regressive e populismi reazionari.
La nostra proposta di piattaforma per la vertenza generale si concentra oggi principalmente sui seguenti obiettivi:
Abolizione della legge 30 e delle altre norme di flessibilità, nessun ritorno al pacchetto Treu, ritorno alla chiamata numerica e agli uffici pubblici del lavoro; trasformazione di tutti i contratti atipici in contratti a tempo indeterminato e pieno.
Ripristino della scala mobile per tutti i lavoratori ed i pensionati dentro un quadro di rottura con la concertazione, il rifiuto dei tassi programmati, il pieno ritorno alla libertà di contrattazione.
Recupero salariale uguale per tutti di 300 euro con salario minimo intercategoriale di 1200 euro.
Indennità di disoccupazione, senza limiti temporali, per tutti i disponibili all’avviamento al lavoro a partire dai diciottenni di 800 euro o dell’80% del salario minimo intercategoriale o dell' ultimo salario, se superiore.
Ritorno al calcolo pensionistico al 2% annuo col sistema retributivo calcolato sugli anni migliori.
Riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore a parità di salario senza annualizzazioni e flessibilità.
Il PCL si impegna a portare questa proposta di piattaforma nei luoghi di lavoro, nelle organizzazioni sindacali, in tutte le esperienze di lotta.
Alla prospettiva della vertenza generale è connessa la tematica delle forme di lotta. La linea sindacale della concertazione ha sempre lavorato alla frammentazione delle lotte e al contenimento e dispersione di ogni loro potenzialità radicale. Lo stesso “sciopero generale” - quando convocato – è stato trasformato dalle burocrazie sindacali o in una pura esibizione dei propri rapporti di massa a difesa della concertazione (cioè del ruolo delle burocrazie) o, peggio, nell’atto simbolico teso a devolvere su un binario morto pressioni e dinamiche di lotta. Parallelamente la sinistra sindacale, a partire dalla sinistra CGIL, non ha mai contrastato realmente questa logica. E le stesse forze sindacali “di base”, pur positivamente anticoncertative, hanno più volte utilizzato la proclamazione di “proprie” azioni di lotta e di “propri” scioperi generali, come ricorso identitario o concorrenziale, fuori da un rapporto reale con la dinamica di lotta e l’esigenza di unificazione della classe.
Il PCL si impegna a costruire un’altra cultura della lotta sindacale e più in generale della lotta di massa, recuperando e riattualizzando la migliore tradizione del movimento operaio e sindacale. L’azione di lotta non è per “partecipare” ma per vincere. E così è per lo sciopero generale. Naturalmente possono essere utili e necessarie anche azioni di lotta propagandistiche e così “scioperi generali” dimostrativi (cui i nostri compagni partecipano regolarmente, al di là delle diverse appartenenze sindacali): ma solo in funzione della prospettiva di una lotta reale, cioè di un’azione di forza che punti a piegare la resistenza dell’avversario. Proprio in anni recenti importanti esperienze anche in Italia, pur episodiche e parziali, hanno riproposto, dopo lungo tempo, la praticabilità e l’efficacia di forme radicali di lotta di massa: prima fra tutte la lotta a oltranza degli operai FIAT di Melfi. Vogliamo recuperare il significato generale di queste esperienze. Peraltro lo sviluppo di una vertenza generale attorno ad una piattaforma sociale unificante è inseparabile dalla prospettiva di una prova di forza: richiama un livello di scontro sociale che supera i limiti del tradunionismo italiano, sfida l’insieme delle classi dominanti, introduce il terreno della rottura anticapitalistica.
Le aree centriste e le sinistre sindacali non abbordano, per definizione, questo terreno limitando il proprio orizzonte all’antagonismo quotidiano. Spesso confondendo “il movimento” con l’ambito minoritario dell’estrema sinistra e delle sue espressioni sindacali. Il PCL, viceversa, proprio perché si fonda su una prospettiva antisistema assume il proprio lavoro sindacale in funzione di quella prospettiva generale: lavora quindi in ogni organizzazione sindacale allo sviluppo del movimento reale delle masse e all’unificazione delle loro forze su un terreno d’azione radicale. L’unico peraltro che può strappare risultati, anche parziali. Per questa stessa ragione impegna tutti i propri militanti sindacali, ovunque collocati, a sviluppare e articolare nel proprio ambito d’intervento (sindacale e di lavoro) questa comune prospettiva di unificazione della classe. Raccogliendo attorno ad essa tutte le forze migliori del sindacalismo italiano e della sua avanguardia. Sia quelle concentrate nella CGIL; sia quelle presenti nel sindacalismo di base e nelle sue diverse espressioni organizzate.
L’intera tematica del lavoro sindacale va affrontata con un metodo analogo.
Le aree centriste, proprio perché basate fondamentalmente su un programma minimo, sovrappongono la propria identità politica all’identità sindacale (Cobas), o si appoggiano su un “proprio”sindacato di riferimento (Rete dei Comunisti).
I comunisti rivoluzionari affrontano invece la questione sindacale, dall’angolazione del proprio progetto generale: la conquista delle masse alla prospettiva anticapitalista. Non si identificano in una collocazione sindacale, ma in un programma politico complessivo. E con questo metodo comune intervengono nelle diverse organizzazioni sindacali, in una logica di ricomposizione dell’avanguardia e di proiezione di massa. Rifiutando ogni adattamento al proprio specifico quadro sindacale di riferimento. Ed anzi subordinando le proprie scelte sindacali al comune progetto politico.
Nella CGIL è essenziale una battaglia frontale contro la burocrazia sindacale, quale agenzia della borghesia tra i lavoratori: fuori da ogni illusione di poter “spostare a sinistra” il baricentro della Confederazione; fuori da ogni illusione di una sua riforma democratica e di classe, corrotta come è dalla linea concertativa e subalterna al quadro politico delle compatibilità capitalistiche; ma nell’ottica opposta dell’ampliamento dell’influenza politica dei comunisti presso le masse che la CGIL controlla, in particolare nell’industria, la cui conquista è di capitale importanza per una prospettiva socialista. Questa battaglia contro l’apparato CGIL è tanto più importante in uno scenario politico che vede la burocrazia sindacale e la sua linea di concertazione come diretto piedistallo del governo e delle sue politiche antipopolari; e che proprio per questo moltiplica le linee di frattura tra l’apparato sindacale e settori importanti della sua base. La stessa contraddizione tra CGIL confederale e FIOM, fuori da ogni illusione sulla direzione FIOM, apre un varco positivo per la battaglia antiburocratica dei comunisti. La concentrazione di nostri compagni nell’area 28 aprile (Cremaschi) con un peso non marginale è tanto più preziosa nel momento in cui essa ha acquisito – in parte nella realtà, in parte nell’immaginario pubblico - un ruolo di guida della battaglia contro la linea di concertazione.
Al tempo stesso non si tratta di assumere la Rete, nella sua attuale veste, come riferimento acritico: ma di lottare al suo interno per trasformarla in una tendenza democraticamente organizzata e strutturata, a partire dai luoghi di lavoro, e soprattutto in una tendenza sindacale anticapitalista e non semplicemente anticoncertativa, capace di assumersi pienamente le proprie responsabilità sul terreno dell’azione di massa.
Parallelamente, va sviluppata una battaglia politica all’interno degli stessi sindacati “di base” anticoncertativi. La presenza di numerosi nostri compagni all’interno di queste organizzazioni sindacali (in particolare nella CUB, nei Cobas, nel SDL, nello SLAI COBAS) è un fatto positivo. Sia per la loro obiettiva rappresentatività di un settore d’avanguardia, per quanto limitato, sia perché la politica della burocrazia CGIL può spingere verso questi sindacati, in determinati contesti, altri settori di lavoratori. Ma anche in questo caso non si tratta di adattarsi acriticamente alle loro politiche. Fermo restando il comune orientamento anticoncertativo, i militanti sindacali del PCL si battono contro i limiti del sindacalismo di base: per lo sviluppo al loro interno di un’autentica democrazia; per contrastare ogni visione di autosufficienza sindacale e ogni tendenza settaria verso lo sviluppo del movimento e le necessità della stessa battaglia anticoncertativa (v. la scelta sbagliata della CUB di boicottare la consultazione sull’accordo del 23 luglio e la sua opposizione alla nostra proposta di Assemblea nazionale dei delegati). Inoltre la battaglia per la vertenza generale deve investire non solo l’ambito CGIL ma lo stesso ambito dei sindacati di base.
Il PCL lavora al tempo stesso per il rilancio del movimento dei delegati RSU (tra l’altro rivendicando la piena democratizzazione delle stesse, con l’abolizione delle clausole di privilegio del “terzo”, i pieni diritti di assemblea e presentazione alle elezioni per tutte le sigle sindacali, ecc.). Un coordinamento permanente della sinistra larga degli eletti e nelle RSU sulla base di un programma immediato di natura classista può essere uno strumento importante di lotta antiburocratica e per lo sviluppo del movimento di massa. Ed anche un terreno prezioso di ricomposizione unitaria della stessa avanguardia sindacale, al di là dei diversi riferimenti organizzativi d’appartenenza.
Infine, pur considerando centrale la lotta nelle organizzazioni sindacali, i comunisti debbono evitare ogni tipo di formalismo. In particolare, nei momenti di ascesa della lotta, sia generali che particolari, è decisivo lavorare allo sviluppo di forme di autorganizzazione di massa, sia nella forma di comitati di lotta, sia nella forma ben più elevata, di strutture elette e controllate democraticamente (comitati di sciopero, consigli). E’ in definitiva in queste strutture, più che nelle organizzazioni sindacali, che si giocherà la battaglia dei comunisti per la conquista della maggioranza della classe. La nostra stessa parola d’ordine di Assemblea nazionale dei delegati del Nno agli accordi concertativi ha rappresentato, da un’angolazione particolare, una forma di approssimazione a quella prospettiva generale, per muovere anche da qui verso la prospettiva della ricostituzione di un sindacato generale di classe rappresentativo di tutto il mondo del lavoro.
Sulla base di queste indicazioni generali il Congresso del PCL dà mandato agli organismi dirigenti del Partito ed alla commissione lavoro di sviluppare l'articolazione della linea sindacale, anche in rapporto all'evoluzione della situazione politico sindacale complessivamente intesa.
PER UN PIANO OPERAIO ANTICAPITALISTICO
Il PCL sviluppa la proposta della “vertenza generale” in direzione di un programma anticapitalistico complessivo.
Le stesse rivendicazioni della piattaforma di lotta generale pongono la questione elementare della loro fonte di finanziamento. Ciò che investe non solo il nodo centrale della questione fiscale, ma la distribuzione strutturale della ricchezza e il quadro di compatibilità del capitalismo italiano.
Per vent’anni la borghesia italiana ha organizzato una sistematica rapina sociale di risorse pubbliche ai danni di salari, pensioni, sanità, scuola, trasporti, in direzione del pagamento del cosiddetto “debito pubblico”, dei trasferimenti pubblici alle imprese, di ripetute riduzioni fiscali per il capitale. Le sinistre di governo hanno accettato e accettano questo terreno negoziale limitandosi a contrattare piccole limature e correttivi simbolici (v. la richiesta della tassazione delle rendite al 20% senza elementi di progressività). Le organizzazioni centriste o antagoniste, che pur contestano la riduzione della spesa sociale non avanzano una proposta alternativa complessiva sul terreno della distribuzione della ricchezza, limitandosi a chiedere alle sinistre di governo di non ammainare le proprie bandiere riformiste, o addirittura in qualche caso, recuperando nel nome del “movimento” fasulli miti liberal-progressisti (v. Tobin Tax) o keynesiani.
Il PCL avanza invece un programma anticapitalistico sullo stesso terreno redistributivo. Non si tratta di proporre “finanziarie alternative” entro le colonne d’Ercole dell’attuale struttura della spesa e dei vincoli U.E.. Si tratta di porre in discussione quella struttura, di denunciarne “lo scandalo”, di indicare un’alternativa: che rovesci vent’anni di politica borghese con la stessa radicalità della borghesia.
Se i governi borghesi destinano ogni anno 70 miliardi di euro per il pagamento degli interessi del debito pubblico, sottraendoli a servizi sociali e necessità popolari, il PCL rivendica l’abolizione del debito pubblico verso banche, imprese nazionali e internazionali (con piena salvaguardia per i piccoli risparmiatori): per destinare le immense risorse così risparmiate al recupero della previdenza pubblica a ripartizione, all’investimento nella sanità e nella scuola pubblica.
Se i governi borghesi destinano ogni anno decine di miliardi di trasferimenti pubblici, diretti o indiretti, alle grandi imprese e alle banche, attingendoli dai redditi popolari, il PCL rivendica l’abolizione dei trasferimenti pubblici alle imprese private: per investire le risorse così liberate nella piena assunzione di tutti i lavoratori precari e nel salario garantito ai disoccupati.
Se i governi borghesi programmano ogni anno nuove riduzioni del prelievo fiscale sulle imprese e sulle banche (già scandalosamente privilegiate) finanziandole con nuovi tagli alle spese sociali, il PCL rivendica la tassazione progressiva dei grandi profitti, rendite, patrimoni: per liberare enormi risorse per la detassazione del salario, per il sistema di protezione sociale, per lo sviluppo dell’edilizia popolare, per l’investimento nelle energie alternative e nel riassetto idrogeologico del territorio.
Se i governi borghesi confessano ogni anno la propria impotenza di fronte all’enorme evasione fiscale (pur impugnandola ogni volta come demagogica promessa elettorale), il PCL rivendica l’unico programma di misure capaci di andare alla radice del problema: il controllo operaio e popolare sul fisco a partire dall’abolizione del segreto commerciale e bancario e l’applicazione del reato penale per lo sfruttamento del lavoro nero.
L’impostazione anticapitalistica del programma redistributivo, proprio per la sua valenza strutturale pone la questione decisiva della proprietà, in tutta la sua attualità.
Per vent’anni i governi borghesi hanno realizzato un grande processo di privatizzazione di tutti i settori vitali della società italiana.
Le sinistre di governo hanno avallato e cogestito questi processi. Le organizzazioni centriste/antagoniste, che pur contestano le privatizzazioni, si limitano per lo più a contrastarne gli effetti sociali, senza indicare un’alternativa complessiva: oppure riesumano, in forma nuova, vecchie teorie riformiste sul controllo pubblico dell’economia capitalistica.
Il PCL, da organizzazione comunista, pone invece apertamente la sfida rovesciando di segno la radicalità privatizzatrice della politica borghese. E non in termini astratti e ideologici ma in rapporto alla dinamica concreta della lotta di classe, alla sensibilità popolare, a ogni fatto pubblico che evochi lo “scandalo” della proprietà capitalista.
Le migliaia di vertenze a difesa del posto di lavoro contro processi di chiusura, ristrutturazione, delocalizzazione, esternalizzazione richiamano la necessità della nazionalizzazione senza indennizzo e sotto controllo dei lavoratori, delle industrie in crisi e che licenziano in modo palese o mascherato.
Le mobilitazioni di associazioni e settori popolari per la qualità dei cibi e contro le speculazioni sui prezzi alimentari pongono l’esigenza della nazionalizzazione, della grande industria agro-alimentare e della grande distribuzione, sotto il controllo dei lavoratori e consumatori.
Numerose vertenze territoriali contro l’inquinamento pongono l’esigenza della nazionalizzazione, senza indennizzo e sotto controllo popolare, delle industrie inquinanti quale condizione della loro stessa riconversione con garanzia per i posti di lavoro.
Così la rivendicazione della nazionalizzazione dell’industria farmaceutica, responsabile recidiva di un’azione sistematica di ladrocinio e corruzione sulla pelle del servizio sanitario pubblico e dei malati, può rispondere ad una vasta sensibilità sociale contro ogni speculazione sulla salute.
Su ognuno di questi terreni esemplari la rivendicazione dell’esproprio della proprietà borghese non solo indica l’unica vera soluzione; ma può saldare attorno alla classe operaia un blocco sociale più vasto e un sostegno d’opinione maggioritario.
Emblematica e centrale è, al riguardo, la lotta al potere bancario.
Le grandi banche sono oggi il baricentro del capitalismo italiano. I processi di privatizzazione e concentrazione finanziaria che hanno attraversato negli ultimi decenni il sistema bancario italiano ne hanno fatto il crocevia di tutte le reazioni di potere all’interno della classe dominanti: sia sul terreno economico sia sul terreno politico. Parallelamente, mai come oggi, le grandi banche si configurano come cappio al collo della maggioranza della società: coinvolte non solo in tutti i grandi scandali nazionali (Parmalat, Cirio, Bond Argentini) e nei processi di privatizzazione con pesanti ricadute sui lavoratori e i piccoli risparmiatori, ma nell’ordinaria vessazione usuraia, nella grande speculazione immobiliare, nell’esercizio dell’oppressione e del ricatto sociale verso milioni di lavoratori, inquilini, piccoli artigiani e commercianti. Mai come oggi l’odio sociale verso le banche è diffuso e radicato nel comune senso popolare.
La parola d’ordine della nazionalizzazione delle banche, senza indennizzo e sotto controllo popolare, corrisponde a una necessità sociale generale. Tutte le istanze di lotta vera all’evasione fiscale, alla criminalità capitalistica, alla speculazione sociale, alla devastazione ambientale, passano direttamente o indirettamente per la nazionalizzazione delle banche. Una rivendicazione che può raccogliere attorno a sé non solo il consenso del mondo del lavoro, ma anche quello di ampi settori di piccola borghesia e di “popolo”. Sottraendo oltretutto alla demagogia reazionaria delle destre (contro il “connubio sinistra-banche”) un terreno facile di presa.
E’ evidente che nessuna di queste rivendicazioni, e tanto più il loro insieme, è “realizzabile” in ambito capitalistico. Proprio qui sta il loro significato. Legandosi a ragioni reali, mostrano che ogni esigenza profonda delle grandi masse conduce al di là della società borghese e richiede il potere dei lavoratori. Peraltro solo una lotta per un programma anticapitalistico può strappare risultati ed obiettivi parziali.
LA LOTTA CONTRO L’IMPERIALISMO ITALIANO
La battaglia contro l’imperialismo italiano e contro ogni forma di subordinazione ai suoi interessi, è un’espressione naturale della proposta generale del polo autonomo di classe anticapitalistico.
Da comunisti rivoluzionari ci battiamo contro le dominazione imperialista internazionale, oggi a guida USA. Sosteniamo incondizionatamente i diritti di autodeterminazione di ogni popolo oppresso dall’imperialismo, e dunque il suo diritto di resistenza all’imperialismo: in America Latina, in Asia, in Africa, nella stessa Europa. Rifiutiamo ogni neutralismo pacifista tra imperialismo e nazioni oppresse e, di riflesso, tra il nazionalismo imperialistico e il nazionalismo dei popoli dominati e resistenti. Al tempo stesso riconduciamo ogni lotta di autodeterminazione nazionale alla prospettiva socialista internazionale: contro ogni illusione di imperialismo “democratico” o “sociale”, sotto la pressione dei movimenti o della cosiddetta società civile; così come contro ogni forma di conciliazione tra imperialismo e nazione oppressa. Di conseguenza, sosteniamo lo sviluppo di un’egemonia proletaria, anticapitalistica e internazionalista, all’interno di ogni movimento di resistenza nazionale: contro ogni forma di fondamentalismo reazionario e di nazionalismo borghese e in autonomia dallo stesso nazionalismo democratico radicale.
Entro questo orientamento generale, il PCL sviluppa una specifica battaglia politica contro l’imperialismo italiano, il “nostro” imperialismo. Le sinistre di governo, per definizione, hanno totalmente capitolato all’imperialismo nazionale, sostenendone la politica interna ed estera. Le organizzazioni centriste e/o antagoniste, che pur ne contestano le politiche, o risolvono la propria battaglia antimperialista nella campagna anti USA (di cui l’Italia sarebbe una pura “colonia”); o si limitano a contrastare gli effetti della politica imperialista (basi, spese militari) ma in nome di un’utopica prospettiva di “Europa sociale” e di un’ “altra politica estera” del capitalismo italiano.
Il PCL, al contrario, parte da un principio di realtà. L’Italia è un paese imperialista, quale settima potenza capitalista del mondo contemporaneo. La sua presenza organica nel consesso politico e militare delle potenze imperialiste, riflette questa realtà. E così la sua (crescente) partecipazione alle missioni imperialiste internazionali. I rapporti di forza con l’imperialismo USA certo condizionano la politica estera dell’imperialismo italiano come in generale della UE, entro un comune quadro di alleanza internazionale. Ma non annullano la specificità dei suoi interessi e del suo ruolo. Denunciare questi interessi e questo ruolo; combattere l’illusione di un possibile imperialismo italiano “di pace”, “amico” dei popoli oppressi, è per noi il primo dovere internazionalista: il principale contributo del movimento operaio italiano alla battaglia antimperialistica internazionale.
L’Italia ha esteso massicciamente negli ultimi 15 anni la propria presenza nei Balcani, configurandosi complessivamente come la seconda potenza economica dell’area (dopo la Germania). Con un ruolo egemone in Romania, in Bulgaria, in Albania, in Montenegro e con un ruolo crescente in Polonia (sia produttivo che finanziario). Come ha sviluppato un’azione autonoma di costruzione e imposizione, anche sul piano militare, di una propria sfera di influenza mediterranea (dal coinvolgimento nel colpo di stato tunisino di Ben Ali’ all’inserimento stabile di contingenti italiani nel quadrante balcanico).
Con la proiezione dell’Eni in Centroasia (Kazakistan) e in Africa (Nigeria), come già in Irak (Nassirya), l’Italia partecipa del saccheggio internazionale delle materie prime con un ruolo direttamente oppressivo verso le popolazioni interessate. L’espansione del capitale italiano in Cina dentro una feroce competizione internazionale fa dell’Italia una protagonista della nuova frontiera dello sfruttamento capitalistico.
E’ necessario sviluppare una risposta di classe a questa politica imperialista. Il supersfruttamento di manodopera a basso costo, a partire dai Balcani, entro il processo di delocalizzazione produttiva, si volge non solo contro i lavoratori di quei paesi ma contro gli stessi lavoratori italiani. Il movimento operaio italiano ha tutto l’interesse a ricercare un rapporto solidale e un’unità di lotta con i lavoratori di quei paesi contro il proprio imperialismo. Tanto più nel quadro dell’attuale allargamento della U.E. e in aperto contrasto con le tendenze xenofobe in atto.
L’Italia si candida a svolgere un ruolo centrale in Medioriente, nella nuova spartizione delle zone d’influenza e degli equilibri dell’area, dopo la sconfitta dell’imperialismo USA in Irak. La partecipazione, con ruolo guida, alla missione libanese si colloca in questo quadro. In particolare, l’Italia si candida ad assumere un ruolo diretto nella cosiddetta “soluzione” della questione palestinese: in aperto sostegno all’opzione sionista che prevede la resa e il disarmo della resistenza palestinese, combinati con l’accettazione di un piccolo Bantustan. E’ quello che chiamano “pace”. Peraltro, più che in altri paesi europei, la lobby sionista è una componente organica dell’establishement imperialista italiano, con una presenza diretta nelle sue rappresentanze politiche e nell’editoria dominante (Corriere).
La battaglia a sostegno del pieno diritto di autodeterminazione del popolo palestinese e più in generale del diritto di emancipazione della nazione araba, è inseparabile dalla battaglia contro l’imperialismo italiano, contro il ruolo delle sue truppe e dalla sua diplomazia. E viceversa: una lotta contro l’imperialismo italiano e la sua politica in M.O. è inseparabile dalla denuncia della natura del sionismo e dalla rivendicazione della liberazione della Palestina. La battaglia di denuncia e per l’abrogazione dei trattati politico militari tra Italia e Israele si colloca in questo quadro generale. Il PCL vuole valorizzare questa posizione coerentemente internazionalista e antisionista non solo nel movimento antimperialista e contro la guerra ma presso l’immigrazione araba e palestinese in Italia.
Lo sviluppo del militarismo è un risvolto naturale dell’imperialismo italiano. L’incremento delle spese militari (pur nel quadro delle restrizioni di bilancio) e la riforma professionale dell’esercito, non sono solo l’espressione degli interessi dell’industria militare ma il riflesso di accresciute ambizioni imperialistiche dell’Italia su scala internazionale. La battaglia contro le missioni militari e per il ritiro immediato e incondizionato delle truppe va combinata con la denuncia di quel ruolo e di quell’ambizione. Parallelamente una lotta coerente al militarismo tricolore va ben al di là dell’approccio tradizionale pacifista. La rivendicazione dell’abbattimento delle spese militari è prioritaria, congiungendosi alla richiesta del parallelo sviluppo della spesa sociale. Ma non è sufficiente. Vanno denunciati i crimini coloniali delle truppe italiane nei teatri di guerra. Va denunciato l’intreccio tra gerarchie militari e industria militare, che oggi vede ex generali tra gli amministratori delegati di Federmeccanica. Va rivendicata la nazionalizzazione, senza indennizzo e sotto controllo dei lavoratori, dell’industria militare in Italia: condizione necessaria perché la sua riconversione non si trasformi in licenziamento dei lavoratori, e dunque per coinvolgere gli stessi lavoratori del settore in questa battaglia, al fianco di tutte le forze antimperialiste.
Le stesse leggi finanziarie “lacrime e sangue”, i processi di privatizzazione e di concentrazione bancaria, la riforma delle pensioni e del TFR, le “riforme” del mercato del lavoro e delle regole contrattuali sono parte, diretta o indiretta, delle politiche di rafforzamento dell’imperialismo italiano e di allargamento delle sue basi materiali, entro il concerto U.E. e la nuova competizione mondiale. La battaglia sociale contro quelle misure non va dunque limitata al solo aspetto “sindacale”, ma va ricondotta alla lotta contro l’imperialismo italiano e contro il concerto imperialistico della U.E.. La lotta contro la U.E. e contro ogni ipotesi di sua riformabilità “progressista” è parte della lotta contro l’imperialismo italiano. Un sentimento anti U.E. è presente, anche in Italia, in vasti strati popolari, come lascito di vent’anni di sacrifici sociali “nel nome dell’Europa”. E’ necessario dare a questo sentimento una traduzione di classe. Non in termini di ripiegamento nazionalista, ma in termini di lotta per un’Europa socialista, liberata dalla camicia di forza del capitale e guidata dai lavoratori, rispettosa di ogni diritto di autodeterminazione delle sue nazionalità oppresse.
Il PCL si è impegnato e si impegna alla massima unità d’azione di tutte le sinistre d’opposizione contro la politica estera italiana del governo Prodi. Si impegna con tutte le sue forze nelle campagne del movimento “antiwar” a partire dalla lotta contro la base militare di Vicenza e per la chiusura delle basi militari. Al tempo stesso, dentro la più ampia unità d’azione, il PCL porta avanti la propria specifica prospettiva: non la lotta per “un’altra politica estera”, ma la lotta per il rovesciamento dell’imperialismo italiano e degli imperialismi europei.
COERENTEMENTE ANTICLERICALI PERCHE’ COERENTEMENTE ANTICAPITALISTI
La battaglia per il polo autonomo anticapitalistico è inseparabile dalla lotta al clericalismo.
In nessun altro paese europeo (con l’eccezione parziale della Spagna) la Chiesa ha avuto un ruolo tanto rilevante nella composizione storica del blocco dominante: sia in termini di compartecipazione materiale al capitalismo italiano e alla selezione delle sue rappresentanze politiche; sia in termini di organizzazione del consenso e del controllo sociale a partire dal Meridione.
Negli ultimi 20 anni di vita nazionale, questo ruolo ha in parte modificato i propri caratteri, ma non la sua rilevanza.
Dal punto di vista materiale, la Chiesa cattolica detiene il primato della proprietà immobiliare in Italia e partecipa con un ruolo di primo piano al processo di ristrutturazione del potere bancario (Banca Intesa – San Paolo). Non solo conserva un’ampia presenza nel settore dei servizi, dell’assistenza e dell’istruzione, entro gli spazi vacanti che lo Stato le lascia: ma proprio la progressiva riduzione della presenza statale nel settore pubblico, le ha consentito di consolidare ed ampliare la propria presenza attraverso il braccio del cosiddetto “noprofit” (oltretutto con un ruolo diretto nello sfruttamento del precariato del settore). Peraltro il regime concordatario e i privilegi fiscali ad esso connessi restano più che mai un fattore di garanzia dell’accumulazione capitalistica della Chiesa.
Dal punto di vista politico si registra una modifica importante. Nella fase della I Repubblica e sullo sfondo della divisione internazionale del dopoguerra, la Chiesa trovava nella Democrazia Cristiana la rappresentanza politica e lo scudo protettivo dei propri interessi: ed anche la sede naturale della mediazione con l’interesse generale del capitalismo italiano. Con il crollo della DC e sullo sfondo della II Repubblica, la Chiesa ha moltiplicato i propri canali di rappresentanza diretta su entrambi i versanti del bipolarismo borghese: nel Centrodestra (UDC, area cattolica di F.I., area cattolica di A.N.); nel centrosinistra (UDEUR, area cattolica e filoclericale del Partito Democratico..). Peraltro è significativo che il Centro liberale del Partito Democratico (Veltroni, Rutelli), proprio perché proteso alla costruzione del partito centrale della borghesia italiana, ricerchi un’intesa con la gerarchia ecclesiastica, tassello costitutivo del blocco storico dominante.
Dal punto di vista ideologico e culturale, la Chiesa esercita un’incidenza rilevante, con un ruolo guida del fronte reazionario su terreni cruciali. Da un lato rilancia una linea di ortodossia confessionale antiliberale (mitologia del matrimonio, difesa della castità, negazione dei diritti degli omosessuali e delle lesbiche, difesa della legge 40, ripresa della campagna contro la 194); dall’altro lato promuove la recita di un solidarismo compassionevole “antimercantilistico” (su povertà, emarginazione, immigrazione), che fa da supporto ideologico al proprio ruolo assistenziale e prova a capitalizzare culturalmente lo spazio liberato dall’evoluzione liberale del grosso della sinistra.
La lotta contro la Chiesa cattolica è dunque una necessità imprescindibile.
Le sinistre di governo, impegnate nella collaborazione con la borghesia e col Partito Democratico, non possono perciò stesso realizzare una battaglia anticlericale conseguente: come mostra l’attuale linea di resa su Dico, legge 40, legislazione fiscale filoclericale. Ed anzi proprio l’ingresso del PRC nel governo con la borghesia è passato per la ricerca della benedizione dei vescovi. L’area centrista e/o antagonista marca spesso, su questo terreno, un profilo defilato o riduttivo. O si disimpegna largamente dalla battaglia anticlericale per effetto di un’impostazione economicista/sindacalista (Rete dei Comunisti). O si limita ad una pura battaglia democratica e culturale per “i diritti”, senza investire la materialità capitalistica della natura della Chiesa.
Il PCL intende invece inquadrare la lotta contro la Chiesa entro la più generale prospettiva anticapitalistica. La sola che può liberare una battaglia anticlericale coerente. La sola, oltretutto, che può trasformare la battaglia anticlericale in una mobilitazione sociale di massa, potenzialmente maggioritaria nella società italiana.
L’impegno politico e culturale contro la reazione ecclesiastica a difesa dei diritti (delle donne, dei conviventi, degli omosessuali) è naturalmente prioritario, contro ogni riduzionismo economicistico: solo ponendosi alla testa di tutte le domande di liberazione il movimento operaio può realizzare un’alternativa di società. Ma la battaglia democratica, pur necessaria, non è sufficiente. Se vuole trasformarsi in una battaglia di massa, capace di allargare il fronte di mobilitazione contro la Chiesa, deve legarsi a rivendicazioni sociali di rottura, contro la costituzione materiale del capitalismo ecclesiastico.
In primo luogo va rivendicata l’abolizione di ogni privilegio fiscale del clero. L’abolizione dell’8 per mille; l’abolizione dell’esenzione fiscale dall’ICI e dall’IVA: la richiesta di destinazione di tali risorse a scuola, sanità e pensioni può guadagnare un vasto consenso popolare.
In secondo luogo va rivendicata l’abolizione dell’attuale pioggia di finanziamenti pubblici a scuola privata e sanità privata (largamente sotto controllo clericale) e il loro passaggio allo Stato sotto controllo popolare. La battaglia per la laicità dei servizi, a partire dall’istruzione, è inseparabile dalla richiesta del loro carattere pubblico.
In terzo luogo va rivendicato l’esproprio della grande proprietà ecclesiastica immobiliare e la sua destinazione a uso sociale: ciò che amplierebbe considerevolmente la disponibilità di abitazioni, strutture sociali, parchi pubblici per la popolazione povera.
Più in generale il PCL si impegna a sviluppare sia nei movimenti per i diritti civili sia nel movimento operaio e nelle organizzazioni di massa, una battaglia coerente contro le gerarchie ecclesiastiche. Rispettiamo le convinzioni religiose di ciascuno ed il diritto di professione di ogni fede. Così denunciamo l’attuale campagna reazionaria islamofoba, risvolto ideologico delle politiche imperialiste contro la nazione araba e delle politiche securitarie anti-immigrazione. Ma non consideriamo la questione della Chiesa e della religione un affare privato, ma un terreno di intervento pubblico dei comunisti all’interno di un progetto generale anticapitalistico. L’antagonismo centrista può anche ignorare questo terreno. Ma una prospettiva rivoluzionaria di liberazione sociale non può che assumere la liberazione delle masse da ogni oppio religioso e il rovesciamento del potere clericale come proprio compito.
L’EMERGENZA AMBIENTALE
La tematica ambientale è un terreno centrale di lotta dei comunisti nella prospettiva anticapitalistica .
Il capitalismo ha sempre assunto la natura come pura merce, entro la logica ceca del profitto. La devastazione dell’ambiente ha sempre rappresentato, in varie forme, un effetto collaterale dello sviluppo capitalistico. Tanto più oggi, il combinarsi della potenza economica e tecnica con i fenomeni della crisi capitalistica e con la nuova competizione mondiale, scarica effetti distruttivi micidiali sulla condizione ambientale del pianeta (incremento enorme dei tassi di anidride carbonica nell’atmosfera, modificazioni climatiche, deforestazione e desertificazioni…).
Fenomeni che, in forme e misure diverse, investono tutte le latitudini del globo. Di riflesso, la questione ambientale e la preoccupazione per l’ecosistema investono generalmente l’opinione pubblica e la sensibilità di vaste masse più che in epoca precedente, anche all’interno dei paesi imperialisti. Questo fatto ha alimentato e alimenta l’utilizzo ipocrita della tematica ambientale, per fini elettorali e di immagine da parte dei tradizionali partiti borghesi o di specifici partiti ambientalisti piccolo borghesi. Chi cercando di conciliare liberalismo capitalistico e ambientalismo (v. Partito Democratico americano o blairismo). Chi predicando contro la tecnica e la scienza da un versante reazionario (spesso clericale). Chi limitandosi a suggerire con grande enfasi palliativi neoriformistici minimali platonici ( i vari partiti verdi).In ogni caso nei fatti la questione ambientale è divenuta più che mai un terreno di scontro politico, culturale, di classe.
Così anche in Italia. Nel nostro paese la questione ambientale investe in varie forme non solo il dibattito politico, ma passioni e iniziative di massa. Lotte contro discariche abusive e inceneritori, attorno al ruolo e presenza di fabbriche inquinanti, contro l’inquinamento dei cibi, le speculazioni sul territorio, la privatizzazione dell’acqua, hanno coinvolto a più riprese settori popolari assumendo spesso rilevanza nazionale, come a Scanzano, Acerra, ed in particolare la lotta della Val di Susa.
Manca tuttavia un progetto unificante e alternativo. Il centrosinistra, sia nazionalmente che localmente mira a ridurre l’ambientalismo a puro simbolo culturale “progressista”, nel mentre gestisce il saccheggio capitalistico del territorio e le sue articolazioni locali. Le sinistre di governo, al di là delle parole, sono pienamente coinvolte nelle politiche borghesi antiambientali. E quando partecipano alle iniziative locali di lotta “contro” quelle politiche lo fanno per dissolverne le potenzialità radicali, ricondurle alle compatibilità dell’Unione, usarle per propri fini negoziali. Sinistre centriste che pure contrastano le politiche del governo, spesso si muovono in una pura logica antagonista e localista, senza progetto generale di classe.
Il Partito Comunista dei Lavoratori assume la questione ambientale dentro il proprio programma generale di classe anticapitalistico, come suo tassello inseparabile. Contro ogni lettura economicistica o materialistico volgare del marxismo, la migliore tradizione del marxismo rivoluzionario ha sempre rivendicato la rivoluzione sociale come leva decisiva di soluzione della questione ambientale, e la questione ambientale come una delle ragioni e bandiere della rivoluzione sociale. Così Marx ed Engels (v. “La dialettica della natura” e ampie pagine del “Capitale”). Così Lenin nella rivoluzione d’ottobre che dedicò alla rinascita e alla cura dell’ambiente energie e attenzioni preziose persino negli anni della guerra civile, in totale contrasto con le successive politiche della burocrazia staliniana. Vogliamo riprendere e aggiornare quella tradizione contro ogni uso antimarxista e antiproletario dell’ecologismo.
Sotto il profilo teorico-programmatico generale indichiamo la condizione ambientale come paradigma, tanto più oggi dell’alternativa tra socialismo e barbarie. Il fallimento dei cosiddetti accordi di Kyoto su una riduzione concordata, pur irrisoria, delle emissioni di CO2 su scala planetaria; il rilancio della corsa ai pozzi di petrolio e alle energie fossili, connesso oltretutto alla ripresa delle guerre imperialiste e al contenzioso strategico tra le grandi potenze (USA-UE-Russia-Cina); il rilancio della stessa campagna borghese per il nucleare, anche e in primo luogo in Italia, rivelano l’incompatibilità più totale del capitalismo con la salvaguardia dell’ambiente e della salute tutte le pose borghese “progressiste” sull’ambientalismo servono solo a nascondere questa verità. Solo la liberazione dell’umanità dall’anarchia del capitalismo; solo la riconquista del controllo sociale sull’economia planetaria sulla tecnica, sulla scienza, e sui loro indirizzi; solo un controllo sociale sulla produzione e sui suoi fini, in funzione della specie umana e quindi del suo ambiente di vita, può disinnescare la bomba ecologica alimentata ogni giorno dal capitalismo: ripristinando l’equilibrio tra produzione e natura . E ricostruendo oltretutto anche per questa via una diversa relazione tra la specie umana e le altre specie viventi, oggi spesso ridotte a oggetto di saccheggio e perfino di tortura (vivisezione) a fini di profitto. Per questo il marxismo rivoluzionario si batte sia contro le posizioni borghesi liberali di tipo neopositivista che nascondono lo sfruttamento capitalistico della scienza e la distruzione capitalistica dei suoi stessi indirizzi di ricerca, sia le tendenze neoluddiste o estetico-mitologiche di rifiuto della tecnologie. Il socialismo non ha alcuna paura della tecnica e della scienza. Al contrario vuole liberarle dalle catene del profitto e dell’anarchia capitalistica per porle al servizio dell’uomo come strumento di liberazione. A sua volta proprio per questo solo il socialismo potrà individuare e rifondare l’equilibrio armonico tra sviluppo economico e sostenibilità ambientale. Per questo la classe lavoratrice può e deve includere la tematica ambientale dentro a una prospettiva socialista assumendola come una delle leve della propria egemonia alternativa sulla maggioranza della società. Sul piano dell’iniziativa politica , il PCL impegna i militanti del partito e le sue strutture a prendere parte a tutte le lotte e iniziative di massa di carattere progressivo sul terreno ambientale. Per difenderne e svilupparne l’autonomia dal gioco dell’alternanza, per liberarle dal controllo diretto o indiretto di vecchi o nuovi apparati, per volgerle contro le classi dominati e i loro governi, nazionali e locali. Al tempo stesso, proprio per sviluppare l’autonomia dei movimenti è necessario costruire una connessione programmatica dalle diverse lotte ambientaliste attorno ad un progetto generale unificante di carattere anticapitalistico: che le svincoli da ogni rischio o deriva di carattere localista che le ricongiunga alle ragioni sociali di lotta della classe operaia di un alternativa di società e di potere, costruendo un egemonia di classe e anticapitalistica sulle lotte.
In questo quadro il Partito Comunista dei Lavoratori rivendica in primo luogo:
- la nazionalizzazione senza indennizzo e sotto controllo operaio delle imprese inquinanti ai fini della loro riconversioni
- l’investimento concentrato di risorse, sotto controllo sociale e a spese dei profitti, in un sistema pubblico organizzato di raccolta differenziato sull’intero territorio nazionale dei rifiuti
- la riconduzione sotto controllo sociale e pubblico del sistema di smaltimento dei rifiuti, con la conversione degli impianti di incenerimento in impianti di trattamento a freddo o di dissociazione molecolare dei rifiuti. L’opposizione dei progetti di costruzione di impianti industriali e tratte viarie dall’impatto ambientale nocivo. Sviluppo di un piano operaio di opere di pubblica utilità ecologicamente compatibili.
- rifiuto della reintroduzione dell’energia nuclare e massiccio investimento di risorse pubbliche, a spese dei profitti e sotto controllo sociale nello sviluppo delle energie alternative e rinnovabili.
A partire da queste prime indicazioni il congresso impegna i gruppi dirigenti del PCL e le sue commissioni di lavoro a sviluppare la riflessione analitica e l’elaborazione politica e programmatica sulla questione ambientale come necessità inderogabile.
LA NUOVA QUESTIONE MERIDIONALE
La conquista delle masse meridionali ad una prospettiva anticapitalistica è un fattore determinante per l’affermazione di tale prospettiva.
La questione meridionale ha mutato profondamente i suoi caratteri storici originari non la sua intensità. Dopo un secolo e mezzo di unità italiana, la condizione complessiva del meridione registra una concentrazione radicale di mali nazionali: il massimo della disoccupazione di lungo periodo, l’assenza diffusa di infrastrutture elementari e di servizi, una presenza radicata e immutata della grande criminalità organizzata, il riproporsi di un’emigrazione di massa verso il nord specie giovanile. La svolta degli anni 90 e l’avvio della II Repubblica ha indotto a un’ulteriore aggravamento della situazione del sud. La riduzione dei trasferimenti assistenziali, il disegno liberista del federalismo, il taglio delle spese sociali, la precarizzazione del lavoro hanno colpito in misura particolare la condizione sociale del mezzogiorno, già segnata in diversi tratti da un processo di deindustrializzazione. I processi di concentrazione del capitale finanziario hanno saccheggiato la finanza meridionale assorbendo e cancellando le banche del sud. Le politiche dei patti territoriali e dei contratti d’area prevalentemente concentrati nel SUD vi ha introdotto la sperimentazione di zone “para coloniali” a vantaggio per lo più delle grandi imprese del Nord (v. FIAT).
In questo quadro generale si realizza una crescente polarizzazione della ricchezza e del contrasto di classe all’interno della stessa società meridionale. Da un lato emerge una borghesia meridionale, legata alle costruzioni, al terziario e all’economia turistica, protagonista spregiudicata delle operazioni speculative sulle aree industriali dismesse e che moltiplica i propri capitali attraverso i meccanismi della rendita urbana, agraria e finanziaria: è una borghesia nuova e dinamica, intrecciata alla borghesia del nord da un fitto reticolo d’affari, e che al tempo stesso si mostra capace di una significativa egemonia su settori rilevanti della società meridionale, in particolare sulle libere professioni e su ampie aree del ceto medio commerciale. Al polo opposto il parziale ridimensionamento della classe operaia industriale (ma non del lavoro dipendente) si accompagna ad un processo di più ampia pauperizzazione, segnato dal peso crescente dei disoccupati, dal lavoro stagionale, dal declassamento di un pubblico impiego privato delle vecchie certezze di status e di reddito.
La criminalità organizzata, nelle sue diverse espressioni,, trova in questo scenario sociale il proprio spazio di inserimento e riproduzione. La criminalità organizzata è una frazione organica della borghesia meridionale con cui intrattiene un rapporto complesso: per un verso esercita su di essa un prelievo fiscale illegale e diffuso, largamente sostitutivo del fisco statale, entrando così in contraddizione con l’interesse generale della borghesia nazionale e del suo Stato; per altro verso le assicura protezione sociale, credito bancario e flusso finanziario (anche attraverso l’utilizzo di settori dello Stato e della pubblica amministrazione). Parallelamente la stessa criminalità agisce, in vaste zone del sud, come ufficio di collocamento di giovani disoccupati e quindi, paradossalmente, come ammortizzatore sociale, tanto più in una fase in cui lo Stato borghese, da sempre gendarme, giunge a negare persino l’assistenza.
Centrodestra e Centrosinistra si contendono la rappresentanza del blocco dominante del meridione contro le ragioni sociali della maggioranza del popolo meridionale. Il berlusconismo si presenta col volto di dispensatore di ricchezza e scudo protettivo dell’illegalità diffusa contro l’ “invadenza statalista”: con esplicito ammiccamento alla criminalità organizzata. Il Partito Democratico e il Centrosinistra puntano all’integrazione del blocco dominante del meridione entro lo Stato e le leggi generali della società borghese: usando la leva dei trasferimenti pubblici privilegiati per le imprese del SUD e la promessa formale della protezione statale per un capitalismo legale.
In realtà, sia le amministrazioni locali di Centrodestra che di Centrosinistra si appoggiano sui poteri forti legali o illegali del meridione e sulla fitta rete di clan e di consorterie a questi legati. La riduzione dei fondi pubblici agli enti locali, la gestione degli appalti e dello smaltimento rifiuti, il più libero ingresso di capitali privati nelle opere pubbliche (proiet financing), consolidano nel loro insieme la relazione organica tra giunte locali e borghesia meridionale.
Parallelamente, la difficoltà a raccogliere un reale consenso d’opinione attorno a queste politiche le spinge a combinare l’uso della leva clientelare con la posa populista: orlandismo, bassolinismo, vendolismo hanno rappresentato espressioni diverse di questa politica sul versante del centrosinistra.
L’esperienza di questi vent’anni conferma in un quadro storico nuovo, la tesi di fondo di Antonio Gramsci e del marxismo rivoluzionario: non c’è possibile soluzione della questione meridionale in ambito capitalistico. Contro tutte le teorie socialdemocratiche o staliniane che hanno a lungo presentato la questione meridionale come un’espressione di arretratezza residuale (in funzione del proprio blocco con la borghesia), l’esperienza dimostra che essa è il prodotto all’opposto, del mercato capitalistico e del suo sviluppo diseguale e combinato. Quella borghesia italiana che fu incapace di risolvere la questione meridionale al momento dell’unificazione nazionale, è tanto più impossibilitata a risolverla oggi: ed anzi l’incorpora, con tutte le sue patologie, entro la conservazione del proprio dominio sociale e del proprio blocco dominante.
Per questo ogni blocco con la borghesia italiana si risolve contro le masse meridionali. Solo un polo autonomo di classe anticapitalistico può affrontare e risolvere la questione meridionale entro un’alternativa complessiva di società e di potere.
La piattaforma di lotta per la vertenza generale unificante di lavoratori e disoccupati acquista dunque una valenza centrale per le masse del Mezzogiorno. Le rivendicazioni del salario garantito ai disoccupati e ai giovani in cerca di prima occupazione, della trasformazione dei lavoratori precari in lavoratori a tempo indeterminato, dell’abolizione del “Pacchetto Treu” e delle leggi di flessibilizzazione del lavoro vanno assunte, tanto più oggi, come terreno di unificazione del blocco sociale alternativo nel sud e come ambito di ricomposizione in esso dell’egemonia di classe. In questo senso vanno ricondotte a un programma anticapitalistico più complessivo, basato su un vasto piano di rinascita e di sviluppo generale del Mezzogiorno, e sulla necessità di un’azione di lotta radicale a suo sostegno da parte dell’insieme del movimento operaio, in rottura con la logica delle politiche concertative adottate fino ad oggi dal sindacato.
Occorre rivendicare come politica sociale per la rinascita del Mezzogiorno l’eliminazione dei privilegi di classe della borghesia: l’abolizione del segreto bancario, commerciale, finanziario quale unica condizione per la lotta all’elusione ed evasione fiscale; l’imposizione di una patrimoniale ordinaria e straordinaria sulle grandi ricchezze; la tassazione fortemente progressiva dei profitti e delle grandi rendite; l’abolizione dei trasferimenti pubblici alle imprese, vero assistenzialismo di Stato che sottrae ogni anno all’erario pubblico decine di miliardi.
Al blocco storico dominante tra la grande borghesia del Nord e la borghesia meridionale, ivi inclusa la sua frazione criminale, occorre contrapporre il blocco storico tra la classe operaia e le masse popolari del Sud, a partire dai lavoratori e dai disoccupati, sulla base di un programma anticapitalistico. Ed anzi questo blocco di classe è il solo che può trasformare la questione meridionale da bandiera della demagogia reazionaria (nelle opposte versioni, fascista e leghista) in una leva decisiva dell’alternativa anticapitalistica.
PER UN MOVIMENTO DI MASSA DELLE DONNE
Il PCL può e deve impegnarsi per lo sviluppo di un movimento di massa delle donne sul terreno della ricomposizione dell’opposizione di classe e anticapitalistica.
Negli anni 70 l’ascesa della classe operaia italiana aprì un varco importante allo sviluppo del movimento delle donne. E a sua volta la lotta delle donne fece un’irruzione forte nel dibattito politico, nella cultura, nella società italiana, favorendo la maturazione di una esperienza di massa più avanzata sullo stesso terreno democratico e ottenendo anche risultati importanti, seppur limitati, dal punto di vista del costume e del diritto (v. legislazione sulle lavoratrici madri, L. 194/78).
Con gli anni 80 l’arretramento del movimento operaio trascinò con sé un’involuzione più generale della sensibilità democratica e della coscienza di massa e, con esse, un arretramento del movimento delle donne.
Ma soprattutto su quello sfondo si svilupparono nel movimento femminile orientamenti culturali di distacco progressivo dai temi sociali e di classe, di rifiuto della contraddizione capitale/lavoro, di ripiegamento intellettualistico-elitario. Le teorie idealistiche ancora oggi presenti in una parte del pensiero femminista – che riconducono l’oppressione femminile a una radice biologica e a un codice simbolico maschile – nacquero in quel clima sociale e culturale.
Negli anni recenti l’inizio di una ripresa del movimento operaio, la crisi di egemonia delle politiche liberiste, l’affacciarsi di una giovane generazione, hanno creato uno spazio nuovo per il possibile rilancio di un movimento di massa delle donne, capace di coinvolgere in primo luogo i settori più oppressi e sfruttati della popolazione femminile. E tanto più oggi il PCL deve impegnarsi in questa direzione: a partire da una lettura di classe dell’oppressione femminile, che non nega la sua specificità, ma la colloca in uno scenario generale.
La crisi congiunta di capitalismo e riformismo, su scala internazionale, si scarica con raddoppiata violenza sulla condizione delle donne. Nei paesi imperialisti disoccupazione di massa, precariato, flessibilità, privatizzazione dei servizi, riguardano spesso, prima di tutto, la popolazione femminile. Nei paesi dell’Europa orientale, sottoposti all’introduzione brutale delle leggi di mercato, si registra un drastico abbassamento del livello di vita delle donne. Nei paesi del cosiddetto Terzo e Quarto mondo le politiche colonialiste di guerra e miseria rendono disumana in primo luogo proprio la condizione della donna.
In Italia le politiche sociali degli ultimi 20 anni hanno determinato un attacco profondo alle condizioni di vita di milioni di donne (Legge 40/98 del governo Prodi, Legge Bassanini del 97 a favore della sussidiarietà, politiche familiste di Berlusconi). Oggi il governo Prodi da un lato dà sponda all’integralismo cattolico (sulla stessa 194), dall’altro innesta il rilancio della “centralità della famiglia” su un ulteriore smantellamento dello Stato sociale, incentivando la donna, attraverso detrazioni fiscali e assegni irrisori al nucleo familiare, a farsi carico di compiti di cura prima propri del Welfare State. La privatizzazione del sistema sanitario e degli asili nido (quando esistenti) va nella medesima direzione. Le donne sono dunque costrette a subire doppiamente sulla propria pelle il carico di lavoro di cura nei confronti dei soggetti a rischio e marginalizzati di questa società (anziani, malati terminali, sieropositivi, portatori di handicap). E questo nel mentre subiscono come prime vittime l’attacco ai posti di lavoro (licenziamenti) e la compressione dei salari.
Da più versanti l’oppressione di milioni di donne ha sempre più un contenuto sociale riconoscibile e inequivoco. Su questo terreno va costruito un intervento di classe teso a ricomporre la più vasta opposizione di massa. La lotta alle privatizzazioni e contro l’attacco allo Stato sociale; la lotta per il diritto al lavoro e per un salario garantito quando il lavoro non c’è; la lotta per il diritto alla salute garantito dal servizio pubblico e gratuito; la lotta per gli asili nido e contro la chiusura dei consultori, possono coinvolgere, in prima fila, i settori più oppressi della popolazione femminile. Ma è essenziale che il movimento operaio assuma queste tematiche all’interno delle proprie lotte come terreno di egemonia e ricomposizione. E che il PCL ponga queste tematiche congiuntamente all’interno del movimento operaio (contro ogni logica concertativa) e come ambito di sviluppo di un movimento di massa delle donne.
Il PCL si pone il compito di monitorare tutte le espressioni di lotta delle donne, di radicarsi al loro interno, di lavorare a estenderle e unificarle. Costruendo sempre una connessione viva tra obiettivi immediati e prospettiva anticapitalistica, entro la logica transitoria. E quindi riconducendo ogni lotta delle donne al processo più generale di emancipazione della classe lavoratrice per un’alternativa di società e di potere.
La ripresa di un forte movimento di liberazione della donna che intrecci rivendicazioni democratiche e di genere e lotta all’oppressione sociale è una componente decisiva del rilancio di una prospettiva socialista. Al tempo stesso, solo una prospettiva socialista che spezzi il dominio del capitale può creare le condizioni necessarie, non sufficienti, per un’effettiva liberazione delle donne dalla loro specifica oppressione. Così come solo una prospettiva socialista può realizzare la pienezza dei diritti di tutte le minoranze sessuali (gay, lesbiche, bi e transessuali)
Duplice allora è il compito che ci poniamo: sviluppare nell’avanguardia di classe e tra le masse la coscienza dell’essenzialità della liberazione della donna, contrastando ogni forma di pregiudizio; sviluppare nel movimento delle donne ed in tutti i movimenti di emancipazione sessuale la centralità della lotta di classe e del movimento operaio come riferimento strategico per la propria liberazione.
PER L’UNITA’ DI LOTTA TRA LAVORATORI ITALIANI E MIGRANTI
L’impegno del PCL per i diritti sociali e politici dei migranti e contro la xenofobia e il razzismo è parte integrante della lotta per la ricomposizione dell’unità di classe e per la costruzione del blocco sociale alternativo.
Le migrazioni sono uno degli effetti più macroscopici delle contraddizioni dello sviluppo capitalistico, ed oggi anche delle guerre e delle catastrofi ambientali.
Anche l’Italia conosce da tempo una presenza crescente di lavoratori provenienti da Paesi dell’Europa dell’Est e del Terzo mondo che la classe dominante punta ad utilizzare come forza lavoro disponibile a basso costo e con poche pretese.
Chiusura delle frontiere, flussi programmati, controllo poliziesco sono i punti salienti delle politiche dell’immigrazione attuate negli ultimi 20 anni e condivise, al di là delle differenze di tono e di accento, dal centrosinistra e dal centrodestra. La famigerata legge Bossi-Fini ha costituito la punta estrema di questa politica.
Lungi dal disciplinare il fenomeno, questa linea repressiva aggrava le già difficili condizioni di vita dei migranti, crea i cosiddetti clandestini, contribuisce a costruire una percezione distorta dell’immigrazione come fenomeno criminale e criminogeno e ad alimentare la xenofobia e i pregiudizi razzisti. Peraltro, la condizione di clandestinità, il ricatto dell’espulsione, la minaccia della xenofobia sono funzionali a rendere gli immigrati disponibili per qualsiasi lavoro e a qualsiasi condizione, a farne cioè un elemento di indebolimento e di divisione della classe operaia.
Di fronte alla novità dell’immigrazione, la risposta delle forze del movimento operaio è stata del tutto subalterna alle tendenze politiche dominanti, limitandosi al più, a generici sussulti di impegno umanitario. Anche il PRC, nel quadro dell’appoggio al primo governo Prodi, porta la responsabilità della legge Turco-Napolitano che introdusse per gli immigrati irregolari i campi di concentramento e la deportazione.Ed oggi il progetto di legge Amato-Ferrero sull’immigrazione, in forma diversa, non fa che riproporre la logica dei flussi (triennali), degli sponsor (già sperimentati), dell’improbabile domanda nei paesi d’origine, della differenziazione di trattamento e status tra immigrati poveri e “qualificati”: una logica che riproduce inevitabilmente segregazione e clandestinità. Mentre il ministro degli interni rafforza i dispositivi di espulsione verso gli stessi immigrati comunitari. E mentre i vertici del Partito Democratico e numerose amministrazioni locali abbracciano una politica forcaiola e para-leghista.
La risposta a queste politiche non può ridursi alla pur necessaria pratica della solidarietà e della difesa dei diritti democratici. Se vuol essere efficace e credibile sullo stesso terreno democratico, deve porsi in una logica di classe anticapitalistica.
Se da un lato occorre battersi risolutamente contro la xenofobia e il razzismo e per costruire la risposta militante, unitaria e di massa, alle aggressioni xenofobe, dall’altro occorre battersi per l’unità tra lavoratori italiani e stranieri attorno a comuni rivendicazioni, sviluppando la loro sindacalizzazione e la loro piena integrazione nel movimento operaio e nelle sue organizzazioni. La battaglia contro il lavoro nero, per l’abolizione delle leggi di precarizzazione del lavoro, per il diritto reale alla casa, non va concepita come battaglia dei soli lavoratori “italiani”, ma come terreno di possibile ricomposizione di lotta tra lavoratori italiani e stranieri, comunitari ed extracomunitari. In ogni organizzazione sindacale e di massa va posta apertamente questa necessità. Va sviluppato nella coscienza della classe operaia a partire dalla sua avanguardia, il concetto che ogni lesione dei diritti sociali dei migranti è un colpo all’interesse generale della classe. Che solo l’integrazione degli immigrati e delle loro rivendicazioni nelle proprie lotte può impedire che il supersfruttamento e la marginalità degli immigrati vengano usati dal padronato contro i lavoratori italiani: sul terreno economico-sociale come strumento di ricatto e divisione; sul terreno politico-culturale come leva di campagne reazionarie che insidiano i diritti di tutti. Al tempo stesso solo un movimento operaio e sindacale che si batta su basi indipendenti, per le proprie rivendicazioni generali, su salario, lavoro, casa, può ostacolare la demagogia reazionaria che usa il malessere del proletariato italiano per contrapporlo alle “pretese” degli immigrati.
In questo quadro strategico, che assume la forza lavoro immigrata come componente del blocco sociale alternativo, il PCL si impegna a rivendicare in primo luogo la chiusura dei cosiddetti centri di permanenza temporanea, la regolarizzazione di tutti i migranti presenti sul territorio nazionale, l’abolizione delle procedure poliziesche per il permesso di soggiorno e di lavoro, l’attuazione di concrete misure materiali e socio-culturali di accoglienza e integrazione. Al tempo stesso ci battiamo per l’obiettivo generale dell’abolizione di tutte le restrizioni all’ingresso e i pieni diritti di cittadinanza, sociali e politici, per tutti coloro che cercano migliori condizioni di vita nel nostro Paese. L’espansione del fenomeno dell’immigrazione, come portato dell’oppressione imperialista internazionale e del carattere ineguale e combinato dello sviluppo capitalistico è inarrestabile. Sta ai comunisti integrarlo in una prospettiva di liberazione. Il diritto a una vita migliore è universale. Solo una prospettiva socialista internazionale può realizzare pienamente questo diritto.
PER UN GOVERNO DEI LAVORATORI
La lotta per un governo dei lavoratori, basato sulla loro forza e la loro autorganizzazione, è il coronamento naturale della battaglia di classe anticapitalistica.
Solo un governo di rottura con la borghesia può dare realizzazione compiuta alle rivendicazioni anticapitaliste. E parallelamente ogni lotta per rivendicazioni anticapitaliste ha una prospettiva realistica solo se assume lo sbocco di un governo dei lavoratori.
La prospettiva del governo dei lavoratori non riguarda solo il futuro ma lo stesso presente dei movimenti e delle lotte e in essi dell’azione quotidiana dei comunisti. Solo quella prospettiva infatti fonda la battaglia per l’autonomia dei movimenti dal quadro borghese e dall’alternanza di governo. E viceversa la rimozione di quello sbocco favorisce la subordinazione, diretta o indiretta, dei movimenti stessi al quadro dominante: o nella forma della loro integrazione subalterna o nella forma della loro disgregazione e marginalizzazione. Qui sta la differenza di fondo tra “antagonismo” e rivoluzione. Solo un progetto di rivoluzione dà fondamento certo e prospettiva reale all’antagonismo.
Il governo dei lavoratori è un governo di rottura con l’ordine esistente. Esso trasferisce alle classi subalterne il potere di comando. E con ciò capovolge il codice stesso della democrazia borghese. Nella repubblica borghese più democratica – affermava Lenin – il potere reale si concentra nelle mani della classe sociale dominante e del suo apparato statale. La repubblica borghese più democratica è “un paradiso per i ricchi e un inganno per i poveri” (Lenin). L’intera esperienza storica italiana ha confermato interamente il giudizio del marxismo. La I Repubblica, nata dalla sconfitta delle potenzialità rivoluzionarie della resistenza partigiana, si fondò sulla ricchezza delle grandi famiglie, sulla dilagante corruzione democristiana, sui manganelli di Scelba, all’ombra del tramestio di Gladio, del Sifar, del Sisde, sino allo stragismo degli anni ’60/'80. La Costituzione del 48 (“una rivoluzione promessa in cambio di una rivoluzione mancata”, Calamandrei) fu solo la cornice retorica funzionale a mascherare questa realtà. Tangentopoli fu invece la sua confessione postuma: non una “devianza” ma la radiografia della I Repubblica.
L’esperienza della cosiddetta II Repubblica ha confermato, in forme nuove, lo stesso ordine di classe. Aggiungendovi una modifica antidemocratica della rappresentanza, un rafforzamento dei poteri esecutivi, una professionalizzazione dei corpi repressivi. Il potere economico si concentra nelle mani di vecchie dinastie capitalistiche (FIAT), di una nuova borghesia emergente ed in particolare delle grandi concentrazioni bancarie. Le diverse soluzioni di governo entro il regime bipolare, pur esprimendo diversi equilibri interni allo stesso blocco dominante, si appoggiano su quel potere e si contendono la sua rappresentanza candidandosi a suo “comitato d’affari”. L’apparato dello Stato, fuori da ogni possibile controllo sociale e pubblico, è il terreno di composizione e scomposizione di cordate politico-finanziarie, di intrecci affaristici, di scontri fra lobbyes, in un’autentica guerra per bande: la vicenda Telecom, l’affare Unipol, la questione Pollari, sono solo un piccolo spaccato rivelatore. Parallelamente l’esperienza del G8 ripropone la funzione repressiva dello Stato come espressione organizzata della forza, fuori da ogni finzione e mascheratura legale. La repressione spesso colpisce non solo attivisti e militanti di avanguardia (licenziamenti politici, marginalizzazione in fabbrica, ecc) ma, in forme diverse, la classe operaia in quanto tale (come nel caso della precettazione degli scioperi, della punizione di lotte di massa radicali, ecc). Più in generale lo stato risponde alla proprio crisi di consenso con la riaffermazione repressiva della propria legalità. L’impugnazione del reato di eversione contro pratiche collettive e simboliche di tipo movimentista (come nel caso delle condanne richieste per i partecipanti alle azioni di cosiddetta “spesa proletaria”) sono non solo enormità giuridica, ma un segnale intimidatorio verso chiunque contesti (persino in termini innocui e perciò discutibili) la legalità dell’ingiustizia sociale. Soprattutto quelle abnormi richieste formulate contro i manifestanti di Genova 2001 –tanto più odiosa a fronte dell’assoluzione strisciante delle violenze poliziesche e della promozione di carriera dei loro responsabili – non rappresentano solo una vendetta di stato, ma un atto di dissuasione preventiva da ogni ribellione di massa verso le classi dominanti ed il loro potere. Parallelamente, su un piano diverso, il carcere assume sempre più la funzione di “discarica sociale” nei confronti dell’immigrazione e degli strati più marginali della società, già colpiti quotidianamente dalle vessazioni poliziesche e dagli effetti diretti ed indiretti delle leggi di emergenza e dei decreti xenofobi. Ed è in questo particolare quadro che il PCL si impegna a promuovere controinformazione e contrasto delle diverse forme di repressione e la solidarietà di classe tra tutti gli oppressi colpiti dall’ordinaria violenza di stato.
Questa è in Italia oggi la democrazia borghese. Gli odiati privilegi parlamentari e istituzionali della cosiddetta “casta”, ne sono il riflesso indecoroso.
Un governo dei lavoratori è tale se rompe radicalmente con questo stato di cose.
Un governo dei lavoratori dovrà realizzare l’esproprio della grande borghesia trasferendo le leve decisive della produzione, del credito, della grande distribuzione sotto il controllo dei lavoratori e dei consumatori: creando progressivamente le condizioni di un’economia democraticamente pianificata finalizzata al soddisfacimento delle domande sociali. Dovrà liberare la stampa e l’informazione dall’attuale controllo del capitale consentendo il libero accesso dei lavoratori e delle associazioni popolari all’informazione e alla produzione culturale. Dovrà revocare le attuali alleanze internazionali dell’Italia e quindi le sue missioni militari, schierandosi al fianco di tutti i popoli oppressi dall’imperialismo e della classe operaia internazionale.
Ma soprattutto un governo dei lavoratori dovrà, in primo luogo, scardinare l’attuale apparato dello Stato (estraneo e parassitario) e rimpiazzarlo con uno Stato di tipo nuovo, interamente basato sull’autorganizzazione democratica dei lavoratori e sulla loro forza organizzata: abolendo i privilegi dell’attuale parlamentarismo, istituendo la revocabilità permanente di ogni eletto, sciogliendo i corpi repressivi e sostituendoli con l’organizzazione diretta dell’autodifesa. E’ il programma del potere consiliare come forma superiore di democrazia. Come la forma attraverso cui le classi subalterne, ossia la maggioranza della società, possono realmente accedere al governo.
L’esperienza dell’autorganizzazione consiliare non ha solo attraversato, in forme diverse, tutte le grandi rivoluzioni del 900, ma ha ripetutamente incrociato la storia del movimento operaio italiano: dai consigli di fabbrica del biennio rosso ('19/'20) alla rinascita dei consigli del 69, a partire dall’autunno caldo. Ogni tentativo di emancipazione della classe operaia italiana ha sprigionato la tendenza alla propria autorganizzazione di massa indipendente in contrapposizione al potere dominante (del padrone e/o dello Stato). E’ necessario ricostruire nella classe e nella sua avanguardia la memoria di questa esperienza. E soprattutto favorire, sostenere, unificare ogni tendenza all’autorganizzazione di massa all’interno delle lotte e dei movimenti. L’esperienza francese degli ultimi 10 anni fornisce sotto questo profilo, indicazioni esemplari.
La lotta per il governo dei lavoratori è la lotta per la rivoluzione sociale. Questa lotta deve impregnare in ultima analisi l’intero lavoro di massa dei comunisti.
Le sinistre di governo, per definizione, rimuovono questo stesso orizzonte: e anzi tutta la loro politica quotidiana predica presso le classi subalterne il rispetto dello Stato borghese, la sacralità delle istituzioni, la mitologia del Parlamento. La loro stessa funzione è quella di assoggettare le classi subalterne all’ordine costituito chiedendo in cambio prebende e onorificenze alle classi dominanti. La presidenza della Camera a Bertinotti è la migliore metafora di questa funzione.
Le organizzazioni centriste/antagoniste, che pur confliggono con le politiche dominanti, rimuovono la questione dello Stato esattamente perché non si pongono nella prospettiva del potere. O si limitano a battaglie democratiche pur essenziali (per la proporzionale o contro la repressione); o ripropongono in forme nuove vecchie varianti storiche dell’elaborazione centrista/riformista (come la “democrazia partecipativa”) che aggirano e negano la stessa necessità della rottura rivoluzionaria, a favore dell’integrazione popolare nell’attuale democrazia borghese. Nell’uno e nell’altro caso non indicano alcuna alternativa al riformismo e soprattutto alcuno sbocco strategico reale per i movimenti di massa.
I comunisti rivoluzionari sono naturalmente in prima fila nella lotta per le rivendicazioni democratiche sullo stesso terreno istituzionale: per una legge elettorale pienamente proporzionale, per il monocameralismo (abolizione del Senato), per l’eliminazione dei privilegi parlamentari (a partire dalla richiesta che lo stipendio di un deputato equivalga allo stipendio di un lavoratore), per la riduzione del mandato parlamentare (da cinque a due massimo tre anni). Ma non si limitano a questo. Riconducono la stessa battaglia democratica alla prospettiva di un’alternativa di potere: assumendo questa prospettiva come cifra della propria politica.
Per questo i comunisti debbono inserirsi, col proprio programma, in ogni linea di contraddizione e frattura tra masse e Stato. Nel rapporto con la percezione e il senso comune di massa la II Repubblica è più debole della prima. Non può usufruire della cintura protettiva del PCI e del suo controllo di massa. Non dispone di un architrave politico capillare e consolidato come la DC. Ed è logorata, giorno dopo giorno, dall’assenza di uno spazio riformistico redistributivo, sullo sfondo della crisi capitalistica. Gli ultimi 20 anni, con la lunga stagione di sacrifici sociali, hanno approfondito il distacco tra grandi masse e Stato. La corresponsabilità delle sinistre nelle politiche dominanti e l’assenza di una sinistra rivoluzionaria sufficientemente radicata spingono questo distacco o in direzione dell’astensione o in direzione di suggestioni populiste. E l’attuale ondata populista, a sua volta, assolve una funzione contraddittoria: da un lato agisce di fatto come megafono di insofferenza di massa, e quindi come fattore di contraddizione; dall’altro ripropone una linea di subordinazione delle masse allo Stato, seppur attraverso un canale particolare (giustizialismo legalitario, dipietrismo, grillismo).
I comunisti non possono lasciare al populismo dell’ “antipolitica” il monopolio dell’insofferenza montante. Contro il populismo che mira a rappresentare la politica borghese come “la politica” (salvo rivolgersi ai politici borghesi e persino a ministri del governo Prodi) abbiamo la necessità di dare la nostra traduzione rivoluzionaria all’umore popolare. La proposta del governo dei lavoratori va incontro a questa esigenza.
E’ l’unica soluzione di governo che rovesciando la dittatura delle imprese e delle banche e dando il potere ai lavoratori, abbatte la separatezza dello Stato (revocabilità), elimina ogni privilegio degli eletti rispetto ai loro elettori, dissolve la burocrazia permanente e quindi il parassitismo della macchina statale borghese. Il governo dei lavoratori è l’unico governo a buon mercato e al tempo stesso l’unica espressione di una democrazia reale.
Al momento la parola d’ordine del governo dei lavoratori è una parola d’ordine di propaganda. Ma è tutt’altro che astratta. Va tradotta in termini popolari di fronte a ogni scandalo della politica borghese (corruzione, sprechi istituzionali, ostentazione di privilegi, arbitrii) fuori da ogni spirito di routine, da ogni tradizione political correct, da ogni logica economicista. Solo una politica rivoluzionaria “popolare” può essere efficacemente antipopulista.