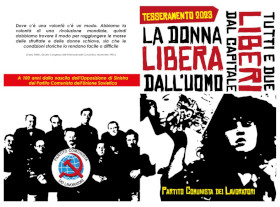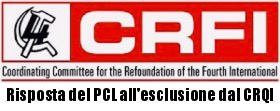Interventi
Per una narrazione working class. Intervista ad Alberto Prunetti
6 Ottobre 2018
108 metri è un libro bellissimo per chi, come me, spesso non tollera il crudo realismo di una narrazione positivista e basta. La classe proletaria non è solo tabelle, grafici, percentuali. C’è bisogno di una poesia, di un’epica, di un’elevazione che passa dalle latrine alla fantasia, dalla concretezza all’astrazione. La coscienza e l’identità di classe non si costruiscono solo con il reportage sociologico. Ma anche e soprattutto con la narrazione, quasi orale, quasi cinematografica, dei nostri working class heroes. E 108 metri di Alberto Prunetti contiene tutta questa umanità, questa disperata fantasia, questo forte senso di noi e loro. Questo ritrovarsi, anche fuori dalla fabbrica, a essere proletari, magari “braccianti cognitivi”.
Chi, come me, proviene da un ambiente operaio ha sentito mille volte i racconti della fabbrica, del lavoro, del campo. Ha sentito di capi e ingiustizie. Di lotte e resistenze. Di gesti tanto ribelli che possono essere ideati solo da chi non ha altro che mani e fantasia. E tutti questi livelli si stringono in 108 metri che è insieme racconto di dopolavoro, romanzo di formazione, epopea gangster, fiaba e bestemmia.
Il lavoro culturale intrapreso da Prunetti è preziosissimo. Come fu ai suoi tempi il lavoro culturale di Bianciardi tra i minatori. Non si tratta di portare “cultura” parruccona e impolverata a una classe ignorante. Ma di dare voce alla classe operaia per (ri)forgiarne in altoforno coscienza e identità.
Un’operazione che, in tempi di spaventosa reazione, non è romantica, ma dolorosamente necessaria.
_________________________________
“So’ regole che valgono in qualsiasi cantiere, anche se vai a lavorà all’estero oppure se usi il geodolide invece che la saldatrice. Semplici. Dai una mano ai tu’ soci. Sciopera. Non leccare il culo al capo. Non fa’ il crumiro. Non infierì se ti tocca menà. Non prendertela troppo coi pisani. So’ umani anche loro. Diffida dei quattrinai. Se uno studiato ti chiama signore, mettiti col culo al muro.”
Alberto, questi comandamenti proletari valgono ancora oggi o sono un’eredità di classe dimenticata? Insomma, esiste ancora la solidarietà proletaria nel mondo fluido “turbocapitalistico”?
Ovviamente siamo in un’epoca di passioni tristi. Dagli anni Ottanta, la sconfitta dei minatori inglesi del black country e la marcia dei quarantamila a Torino hanno aperto la porta al mantra thatcheriano del “le classi non esistono, esistono solo gli individui”. Individui che nell’ottica liberista sono soli, competono contro gli altri e sono lontani da praticare solidarietà e mutuo appoggio, valori working class per eccellenza. Eppure esempi di solidarietà e di mutualismo non mancano. E non parlo di atti individuali e di testimonianze etiche private, ma di realtà sociali. Le fabbriche recuperate ne sono un esempio, come certe realtà di autogestione, i collettivi, le biblioteche popolari, etc. Ma ovviamente si vive immersi nelle tossine che vengono sparse ad arte per minare ogni proposito di unità tra lavoratori sfruttati. A questo serve il razzismo, ad esempio.
La “nuova” classe proletaria, che non ha neppure coscienza di essere tale, ha bisogno di una narrazione in cui riconoscersi, di un’epica di se stessa. In che modo secondo te il lavoro culturale può aiutare i proletari? Può esserci una collaborazione tra i braccianti cognitivi e i braccianti produttivi?
Bisognerebbe che ci fosse. A dispetto dell’idea che non esistano più gli operai, oggi abbiamo una working class, una classe lavoratrice molto ampia. Ci sono meno metalmeccanici, ma sono aumentati tantissimo gli operai della logistica. Poi molti operai lavorano nei servizi, dalle pulizie agli ausiliari della sanità. E sono operai anche i commessi, gli addetti alla vendita nelle catene, quelli della ristorazione. Tra tanti lavoratori, alcuni sono nati nella vecchia classe operaia, altri sono figli della cosiddetta classe media che, impoverendosi, non sta più al passo delle possibilità di un tempo. Sono anche loro parte della nuova working class, magari fanno tre lavori per avere un reddito decente, fanno una vitaccia. Molti di loro faticano però a considerarsi working class, manca loro l’orgoglio che può avere chi è nato in famiglie operaie. Per loro è necessario smettere di rimpiangere i sogni dei padri borghesi e cominciare a sognare i propri sogni. Siamo fottuti se viviamo dentro i sogni di un altro: se la tua condizione è precaria e il tuo stile di vita è proletario, non puoi sognare le vacanze e il lusso, devi fare sogni di utopia e giustizia sociale, altrimenti sei fregato. Anzi. Ti stai fregando da solo. Detto questo, ci sono lavoratori cognitivi che hanno un reddito tale da potersi definire working class. Bisogna che questi lavoratori si considerino “operai della conoscenza” e aiutino a costruire un nuovo immaginario per una nuova working class. Con solo il vittimismo nostalgico, non si rovesciano i tavoli e si rimane sconfitti.
In Down and out in Paris and London, George Orwell parla di “andare ai cani”, ossia arrivare allo strato più marcatamente sottoproletario del tubo digerente della ristorazione e della società tutta. Con un filo di triste sollievo, questo viaggio gli toglie ogni paura. Anche tu hai fatto questo viaggio ai cani: cosa ti ha fatto paura? Come ti ha cambiato?
Di paure ne avevo tante: sono emigrato nel Regno Unito con pochi soldi, potevo solo pagarmi per qualche giorno un tetto, non avevo mai preso un aereo, non avevo mai viaggiato all’estero, non parlavo lingue straniere. Avevo 27 anni e avevo passato gli ultimi anni a finire di laurearmi facendo lavori nella ristorazione. Sicuramente quel viaggio mi ha fatto vincere parecchie paure: o bere o affondare, bisognava andare avanti. Direi che al mio ritorno ero un’altra persona. Ogni viaggio lungo, che non sia realizzato per scopi turistici, ti trasforma. Alla fine, il tesoro dell’isola per me è stato la lingua che ho imparato, con cui oggi mi guadagno il pane come traduttore.
Nel tuo romanzo scorre anche una vena fantastica, per cui i capitalisti venerano l’esecrabile Cthul Ldt, aka il Capitale, con tanto di maleodoranti altarini. Negli ultimi giorni la deriva verso la barbarie sembra avere subito una brusca accelerazione, chiusura dei porti, aggressioni razziste, il tutto con il plauso della classe operaia che questo governo l’ha in larga parte votato. Che fare, quando la nostra stessa classe venera il mostruoso Cthul Ldt e non esita a prendersela con chi sta ancora peggio? Come si recupera una dimensione umana e, perché no, anche di lotta?
Individuando gli avversari giusti, che sono gli sfruttati e non gli sfruttatori. Il gioco della lega e degli altri partiti xenofobi è quello di sostenere che gli immigrati ci rubano il futuro o il lavoro. E’ esatto l’opposto: oggi gli immigrati, ad esempio nella logistica, sono il vero fronte delle lotte contro gli sfruttatori, che poi sono gli elettori tipo della lega. E quando lavoratori immigrati e lavoratori del posto uniscono le forze, sono un pericolo. Per questo i leghisti sono gli utili servi del padrone: perché separano i lavoratori, sabotano le lotte e così difendono i ricchi. Bisogna ripartire da questa consapevolezza: cercare l’intersezione tra questioni di classe, di etnicità e di genere.
In Amianto, altro libro bellissimo, condividi l’esperienza della perdita di tuo padre a causa dell’amianto. Che ci direbbe tuo padre Renato oggi, che consigli ci darebbe?
Non lo so, devo essere onesto. So che non c’è e che quel tipo di “rude razza pagana” che lui incarnava sta scomparendo. Scrivere i miei libri serve anche a tramandare quel tipo di memoria operaia. A chi oggi si trova proletarizzato senza venire da famiglie operaie, quelle storie possono servire. A chi venendo dall’ambiente operaio, ha perso il pride, l’orgoglio per la condizione operaia, ugualmente quelle storie che racconto possono essere utili. Costruire un nuovo immaginario è fondamentale. Se lotti ma non hai un immaginario, hai già perso.
Tu sei anche il traduttore di Donne, razza e classe di Angela Davis, recentemente pubblicato da Alegre. Secondo noi, il femminismo o è anticapitalista, antifascista e antirazzista, o non è. Quali prospettive intravedi per il movimento femminista?
Il movimento delle donne è quello, forse l’unico, che negli ultimi anni è stato capace di grandi mobilitazioni su scala globale, è questo è un primo punto da tenere in conto. Ovviamente ogni movimento deve poter reggere alla lunga. Può essere scalato da un’ideologia borghese, trasformandosi in femonazionalismo, oppure può dilagare nell’intersezione tra genere, classe e razza o etnicità, come dicevo prima con un riferimento ad Angela Davis. Quando queste tre prospettive convergono, non vedo possibilità di recupero in senso conservatore o borghese. Dobbiamo lottare per questo tipo di femminismo intersezionale. Aggiungo solo che il libro di Angela Davis è notevolissimo, una delle traduzioni più importanti che ho realizzato assieme a una compagna femminista, Marie Moise.
Proletari di tutti i paesi unitevi, si diceva una volta. Il mestiere del traduttore, ponte tra due lingue, può avere anche una funzione “militante” e “collante”? Come interpreti questo mestiere in generale?
Il traduttore è uno smuggler, un passeur, un contrabbandiere di cultura. Sta sul guado, sul confine, sui bordi. Da anni faccio di tutto per promuovere autori e testi che possano contribuire a focalizzare il dibattito italiano su certe tematiche di impegno sociale. Il punto debole è che se lavori su questi punti, spesso lo fai nell’editoria militante dove le paghe sono ancora più basse di quella mainstream. È uno dei tanti punti dolenti del nostro lavoro.