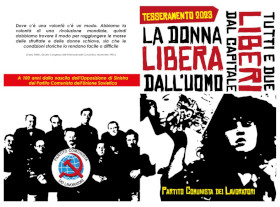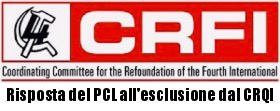Teoria
Critica dell'operaismo
Come si sono smarriti coloro che presentano in veste di marxismo qualche cosa di incredibilmente confuso, intricato e reazionario
29 Marzo 2018
Un'analisi e decostruzione del revisionismo operaista ripercorso principalmente attraverso la carriera politica e filosofica del suo ideologo ed esponente maggiore, Mario Tronti
«Operai, operaie, vi parlo a nome dei vostri compagni studenti: sono le otto del mattino. Oggi, quando voi uscirete, sarà già buio. Per voi la luce del sole oggi non splenderà. Vi cuocerete al cottimo. Otto ore di cottimo! E uscirete stanchi, svuotati, convinti di avere guadagnato la vostra giornata e invece sarete stati derubati. Sì, derubati di otto ore della vostra vita...».
Erano gli appelli che i megafoni di Potere Operaio rivolgevano alla fiumana di operai che ogni mattina entrava in fabbrica a secernere plusvalore nell’intramontabile “La classe operaia va in paradiso” di Elio Petri, 1971. Gli anni dell’adolescenza di quella che è stata la parabola operaista in Italia.
Ma cos’è l’operaismo? Nell’area della sinistra radicale è impossibile non essersi imbattuti in questo ircocervo. La casa editrice DeriveApprodi è impegnata da vent’anni nella riedizione e in battesimi editoriali di molti autori che ebbero la propria collocazione politica in zone variamente graduate dell’estrema sinistra, da Potere Operaio a Prima Linea passando per Autonomia Operaia. Contrassegnata da un gatto selvaggio, simbolo dello sciopero a oltranza su cui s’impernia tutta la strategia di lotta operaista, una sezione apposita è dedicata in segno d’omaggio alla matrice di tutte quelle esperienze: “Biblioteca dell’operaismo”. Ma, provare per credere, alla nostra domanda non si troverà uno solo di quei testi che risponda in modo chiaro. Ce ne assumiamo l’incarico, non tanto per amore storiografico quanto perché, nel poco bene e nel tanto male che quell’esperienza rappresentò per il movimento operaio non solo in Italia e non solo negli anni ’60-‘70, a un giovane comunista che si affacci oggi al mondo delle lotte essa può malauguratamente apparire ancora, circonfusa com’è da un appeal oltranzista (tanto più avvalorato dall’aver ricevuto le maggiori critiche dagli spalti sbagliati, quelli borghesi) quale via giusta. Per scongiurare una simile eventualità, ed è vitale scongiurarla, queste righe auguriamo possano aiutare.
Un’indagine sull’operaismo in Italia non può non partire dalla rivista annuale “Quaderni rossi” fondata nel 1961 dal dissidente socialista Raniero Panzieri e dal dissidente comunista Mario Tronti. All’entourage di questa, che comprendeva rivoluzionarissimi nomi del calibro di Massimo Cacciari e Antonio Negri, allora PSI, si fa risalire la nascita dell’operaismo. Ma se la scienza e la prassi del movimento operaio è il comunismo, a meno che non sia un suo raro sinonimo, e gli “operaisti” si sbracciano come meglio non possono per riaffermare che non lo è, qual è la sostanza di questa dottrina? La domanda elementare reca in sé la risposta altrettanto elementare: l’operaismo nacque proprio nel momento in cui si pensò che la scienza e la prassi del movimento operaio non fossero più (e per alcuni non erano mai state) il comunismo. E che quindi occorreva dell’altro. Un altro –ismo. Nessuno meglio di quello che si trovò e si conservò fino al momento che le realtà che vi si identificavano, per l’infezione che incubavano, non degenerarono al punto da non potere più giustificarlo. Di lì anche il nome cambiò e l’“operaismo” si estinse.
IL 1956
Per capire non solo filosoficamente ma anche storicamente il brodo di coltura da cui ha origine l’operaismo, quello dello stalinismo abbandonato dal versante destro del soggettivismo borghese e dell’idealismo che porta dritti dritti al più reazionario nichilismo, è utile un po’ di storia. Dopo la rivolta degli operai della Germania-est contro Walter Ulbricht nel 1953, il 1956, l’anno della rivolta ungherese, fu un anno tanto tragico quanto importante nel mondo della sinistra, e per molti aspetti un punto di non ritorno. Gli operai d’Ungheria insorsero contro il dispotismo dell’apparato stalinista che tale rimaneva malgrado la destalinizzazione di facciata. La critica a Stalin da parte dell’allora primo segretario Krusciov niente aveva a che vedere con una critica scientifica del fenomeno politico, sociale e storico dello stalinismo. Il suo j’accuse pubblico, le sue desecretazioni e condanne non facevano che additare il singolo Stalin come un capriccioso boia, un assassino senza scrupoli “anche quando non serviva più” (sic!), e non inquadravano affatto anzi eludevano oculatamente il contesto in cui si programmavano purghe e gulag che non erano capricci di un pazzo ma provvedimenti funzionali a un preciso disegno politico, essendo lo stesso Krusciov figlio e continuatore di quel disegno. Lo stalinismo durò ben oltre Stalin e aveva a che fare ben al di là che con la sua individualità efferata certamente quanto la sua mediocrità e il suo opportunismo.
Durante la sollevazione, i soviet costituitisi nelle maggiori fabbriche di Budapest rivendicavano la rottura con l’oppressione della casta burocratica, le accuse a Stalin furono riformulate dialetticamente da comunisti come Sàndor Fakete, e nelle rivendicazioni dei consigli di fabbrica si teneva assolutamente fermo il carattere pianificato dell’economia ungherese, della proprietà pubblica dei mezzi di produzione così come i principi del socialismo da recuperare in Lenin contro l’eredità riveduta e corrotta di Stalin.
Si rivendicavano elezioni libere e autodeterminazione nazionale e si escludeva la riorganizzazione e l’ammissione di partiti borghesi. Imre Nagy, allora e per poco primo ministro, il quale si ritrovò a rappresentare una insurrezione che non aveva né voluto né guidato, di fronte all’invasione dei blindati russi a soppressione della rivolta, minacciò l’uscita dal Patto di Varsavia, imposto da Krusciov, per contrappeso alla Nato, l’anno precedente e che, come il gemello occidentale, soggiogava gli stati satelliti in condizioni di sudditanza assoluta a Mosca. L’insurrezione venne affogata nel sangue (2.652 morti e 250.000 espatriati ca.) dai carri armati sovietici. Il Cremlino, dopo Jalta, aveva costruito il suo impero non secondo i princìpi del leninismo, ma come una copia in carta carbone realsocialista dagli imperi capitalisti – con tanto di invasioni ed esportazioni di socialismo in punta di baionetta – sullo scacchiere geopolitico mondiale. Concepiva gli stati alleati, nella realtà ostaggi, non come frutto di rivoluzioni endogene coi quali coordinarsi e dialogare, ma come bottini di guerra, utili a mantenere l’estensione del proprio regno e incutere paura all’Ovest. Questo non poteva che essere il modo per non lasciarsi sopraffare dal campo avverso dal momento che lo stalinismo rompeva con l’Internazionale per paura che altre rivoluzioni potessero far saltare le poltrone dei burocrati reggenti. Se in Russia, dopo la rivoluzione, lo stalinismo ritornò come menscevismo di reazione, fuori si presentò come menscevismo di mozione. Mosca non avrebbe mai incoraggiato rivoluzioni occidentali, specie quelle (Spagna docet) che volevano svolgersi in aperto contrasto con la degenerazione burocratica.
I partiti comunisti addentellati si accodano alla Pravda: gli insorti ungheresi sono restauratori della borghesia, nostalgici di Horthy, bianchi, provocatori fascisti, orde di teppisti e via dicendo. Su tutti, l’Unità di Togliatti brilla per spregiudicatezza e audacia. In molti, invece, cominciano a snasarsi la verità, abnormemente marcia per non puzzare. Tra questi, il comunista Mario Tronti. Il quale così comincia a cogitare: se il comunismo è buono per sconfiggere il nazifascismo, creare eserciti e colossi statali, un contropotere titanico al potere capitalistico occidentale, d’altra parte non è sempre che tutela gli interessi degli operai. Distinguiamo quindi: c’è il comunismo, che è solo un’uguale e contraria macchinazione di potere improntato a princìpi diversi ma sostanzialmente appannaggio della stessa oligarchia, del medesimo machiavellismo e complotto di governanti contro i governati per imporsi e conservarsi. E quanto a ciò, nulla quaestio giacché – sempre come se la racconta il giovane togliattiano – è solo grazie a questo comunismo (lo stalinismo) che tanto risultato si è ottenuto (vi era già in germe tutta la squisita filosofia trontiana dell’“autonomia del politico”). Ma non siamo d’accordo sulla questione operaia. Qui, l’altro distinguo: i poveri operai da qualche parte dovranno pur sfangarla, fermo restando che, per come è soprainteso, non è col comunismo che possono. La prova del nove è l’Ungheria.
Ma ancora Tronti ingoia il rospo. Firma il manifesto dei centouno che esprime solidarietà agli insorti magiari, tenuto in alcun conto dal Pci che, al contrario, incrementa l’alone di sospetto e diffidenza intorno a chi, per dirla col miglior Togliatti, non “sta con la propria parte, anche quando questa sbaglia”. Si parlava di un punto di non ritorno perché fu quello il momento in cui molti, naueseati e lacerati dalla crisi, abbandonarono il partito. Incluso il regista del film citato in apertura. Ma quello che fa esplodere definitivamente l’“operaismo” di Tronti avviene in casa sua, a Torino, con le giornate di Piazza Statuto.
LA RIVOLTA DI PIAZZA STATUTO
Nel giugno del 1962, dopo anni di stagnazione, migliaia di operai della Fiat di Torino cominciano uno sciopero e una lotta che durerà mesi per il rinnovo del contratto nazionale, con dentro tutte le richieste accumulatesi negli anni e fino allora ignorate, dall’aumento dei salari e la riduzione dell’orario di lavoro alla perequazione di trattamento tra operai e impiegati e tra giovani e meno giovani, ecc. Il 7 luglio, Fiom-Cgil e Fim-Cisl proclamano uno sciopero dei metalmeccanici in sostegno della lotta dei compagni della Fiat. Ma Confindustria aggira ancora una volta le rivendicazioni dei lavoratori, siglando alle loro spalle un accordo separato col sindacato giallo Sida e con la Uil. Proprio dove questa ha la propria sede cittadina su Piazza Statuto, centinaia di lavoratori si riversano dando vita a una delle maggiori contestazioni operaie del secondo Novecento. La rabbia è incontenibile, scavalca gli appelli alla moderazione delle dirigenze sindacali e di partito e assume le forme di una vera e propria guerra civile, una comune italiana, con servizi d’ordine autogestiti, selciato divelto, barricate protrattesi giorni, di qua gli operai, di là la polizia. Una fotografia di Sessantotto in anticipo di sei anni. L’Unità parlerà ancora di provocazioni fasciste e/oppure lumpenproletarie. Mentre al processo dove verranno tradotti molti di quei “vandali”, una inconfutabile verità emerge: i rivoltosi sono tutti operai. E nessuna motivazione soggiaceva alla sommossa che non fosse politica. Tronti lo dirà il momento della sua epifania; quando si accorse del potenziale della forza della classe operaia. Per il Nostro, fu l’ennesimo episodio che vide contrapporsi ragioni operaie e ragioni “comuniste”, ovvero le ragioni del Partito Comunista al cui riformismo i lavoratori non si accodavano più. Ma neanche allora Tronti ritiene sia il momento di ricredersi sulla natura comunista/rivoluzionaria del suo partito. Trova invece che si convenga, più che tenere due piedi in una scarpa, dividere un piede per due scarpe. Come immagine …calza meglio.
Non rinnova la tessera per qualche tempo, ma resta comunista. Un comunista eretico perché non si allineerà al Pci sui fatti torinesi, come già per quelli ungheresi, e comincia a sviluppare tutta una sua teoria di lotta operaia alternativa alle indicazioni del partitissimo. Abbandonerà l’armamentario filosofico accaparrato abusivatamente dal Pci (solo per mezzo del quale, invece, avrebbe potuto distruggere Togliatti e togliattiani). Si sbarazzerà, posto che mai l’assunse, di tutto il marxismo dialettico impugnando il quale l’apparato dimostrava a colpi di contraffazioni la ragione del proprio filisteismo, facendo passare per rivoluzionario il riformismo, per bolscevico il menscevismo, per ortodosso il revisionismo. Così Tronti, d’accordo che, dal versante comunista, fosse nel giusto la dialettica secondo Togliatti (l’unica, per lui) a comandar questo e quello no, scioglie ogni nodo così: se la dialettica vieta le insurrezioni ma io con le insurrezioni voglio stare, e studiarle, capirle, vedere se è vero che non possono condurre a una rivoluzione per vie altre da quelle comuniste (qui, staliniste), bene! Se è così, al diavolo la dialettica! In caso non debba approdare a niente, c’è sempre tempo per i mea culpa.
Dopo la collaborazione a “Quaderni rossi” con Panzieri, Tronti decide che, data la situazione preinsurrezionale dell’Italia dei secondi anni Sessanta, il compito di chi volesse approcciarsi alle lotte operaie da una prospettiva altra da quella del Pci, una prospettiva “operaista” (eccoci arrivati!), dovesse essere l’intervento pratico nel vivo delle lotte e non solo, come finora era stato con Qr, uno studio dal di fuori, dal taglio antropo-sociologico, tutto culturale e poco o punto politico. D’altra parte, viste le contraddizioni ideologiche del nucleo redazionale, tra socialisti che non avevano mai accettata la validità della rivoluzione sovietica e comunisti che, sotto il suo nome, ne accettavano anche la negazione, una prassi comune era impossibile. Non si poteva più limitarsi ad “apprendere dagli operai”, a studiarli in vitro. Era l’ora di proporre. Proporre la via della rivoluzione. I socialisti non concordano, i comunisti ne sono convinti. La redazione si spacca. “Quaderni rossi”, dopo sei numeri dal ’61 al ’66, non esce più. Tronti e i suoi fonderanno “classe operaia”.
SUPEROMISMO SOGGETTIVISTA E NICHILISMO DECADENTE:
UBRIACATURA E POSTUMI DA UBRIACATURA DELL’IDEALISMO BORGHESE ANTIDIALETTICO
Adesso Tronti ha bisogno di inventarsi un altro Marx a suffragio della sua eterodossia. Il famigerato “Operai e capitale”, bibbia dell’operaismo, è una raccolta di articoli che il “cattivo maestro” venne accumulando durante la collaborazione per il suo secondo periodico "classe operaia" dove metterà a punto il suo Marx spurio. La novità che il marxismo eretico di Tronti segna rispetto alla tradizione ha la sua cifra in una costante: la puntuale inversione dei termini della teoria marxiana. Il Nostro si sforza di dimostrare che non il capitalismo dà la classe operaia ma al contrario: la classe operaia dà il capitalismo. Questo gli è possibile farlo, per propria stessa ammissione, solo espungendo dal marxismo il materialismo dialettico che invece ne è il telaio principe e portando al naturale sbocco le premesse di un altro marxista in proprio, Galvano Della Volpe. In che senso non è il capitalismo a dare la classe operaia ma la classe operaia a dare il capitalismo? È indubbio che il capitalismo funzioni grazie alla classe operaia. Ma Storia volle che la borghesia conducesse una rivoluzione. E il capitalismo, il modo di produzione della borghesia, si estese al mondo intero. Il capitalismo allora ha la forza perché ha la proprietà. Il proletariato esiste come soggetto sociale ma non ha ancora esaurito il suo compito storico. Non nell’Occidente, almeno, che è il campo di ricerca operaista. Nessuno di questi poli, quello capitalista e quello operaio, vive per sé come termine astratto senza il potere, la proprietà sulla produzione che può materialmente farli vivere. Pertanto in Marx, il rapporto capitale-lavoro è biunivoco; l’uno vive dell’altro, con la differenza che mentre il capitalista non può vivere senza lo sfruttamento sull’operaio, l’operaio può oggettivamente vivere senza il suo sfruttatore. Tuttavia il capitalismo - che al netto delle recenti affermazioni trontiane, non è un sistema intelligente - tiene piuttosto in non cale i principi oggettivi e il mondo “come potrebbe/dovrebbe essere”. Proprio ciò ne determina l’anacronismo e ne inasprisce le contraddizioni. Contraddizioni che però, stando ai postulati operaisti di possibilità di vita eterna del capitalismo, non esisterebbero. Tutto è rigettato in un estremo soggettivismo da parte operaia, affatto governata da leggi oggettive, strutturali, dialettiche. Ma solo dal proprio grado di “scontentezza”. Qualora il capitalismo riuscisse a rimediare a questa scontentezza - secondo l’operaismo lo ha poi fatto e vanno ben oltre il manicomio della teologia i suoi tentativi di spiegare come! -, l’idealismo soggettivista che porta Tronti e co. a esaltare superomisticamente la classe operaia, sarà lo stesso che ne legittimerà l’abbandono in seguito, liquidandola come integrata, giudicando vincitore un altro soggettivismo, quello dell’“intelligente” capitale, e quindi portando tutti i pargoli dell’operaismo, gli autonomi che ora non possono più dirsi “autonomia operaia”, a razzolare interclassisticamente per bacini di “scontenti” d’altri tipi. Dai sottoproletari ai piccolo-borghesi, produttori in proprio, studenti, liberi professionisti ecc. Non è un caso se, nella storia della repubblica, non si è mai visto un amore così profondo tra le realtà dell’Autonomia e un soggetto istituzionale come il Movimento 5 Stelle.
Ma andiamo con ordine. Nel sistema capitalistico, si è detto, la borghesia detiene i mezzi di produzione solo grazie al processo storico-dialettico che ha permesso questo possesso, così come la dirigenza politica, giuridica e tutto quanto ne compone la sovrastruttura. Ma è proprio questo che rende necessaria la rivoluzione. Nel presente contesto l’operaio, col principio oggettivo della sua autodeterminabilità, fa ben poco: il pane, i mezzi e finanche il permesso di produrlo, se li è allocati il padrone e tocca andare a prenderglieli. Il nostro eretico invece, in una sbornia di machismo da rampollo della borghesia che scopre gli stupefacenti effetti della possenza operaia e ne fa il suo adulterante preferito, legge già operaio e padrone come termini parimenti potenti del rapporto sociale. Anzi la classe operaia, sostiene, è molto più forte del capitale in quanto è della sua forza che il capitale si nutre. Il capitale cerca sul mercato il lavoro dell’operaio, altrimenti felice dov’è e dove il lavoro (il “lavoro morto”, sottratto alla valorizzazione capitalistica, il lavoro in sé, da sé e per sé) può da subito vivere senza padroni perché lo può oggettivamente. A mancare è quell’irrilevante problema della proprietà dei mezzi di produzione, colonna portante del marxismo e liquidato con aristocratica non-chalance dal revisionismo operaista.
Sarà che la proprietà si determina storicamente; ed è un bel groppo, senza il Marx storico, spiegarsi come una classe oggettivamente più forte d’un’altra abbia deliberatamente lasciato che la classe “per sé” debole conquistasse la proprietà sul mondo intero e, soggiogando quella forte e autosufficiente, glielo rivendesse pezzo a pezzo e con gli interessi! E perché, ancora, questa classe è tanto imbecille da accettarlo supinamente quando invece potrebbe voltarsi dall’altra parte e prosperare libera? I soggetti sociali si muovono nel fiume della Storia. Neppure si sarebbero formati come tali, se non fosse per il fiume della Storia. A toglier quello, rimangono due pesci morti che solo la macabra immaginazione di un gioco infantile può far interagire e parlare. Ma Tronti preferisce travestire da lotta di classe questa ventriloqua necrofilia piuttosto che digerire il filosofo della dialettica storica della quale è, ad oggi, un convinto avversario.
LA LEGGENDA DEI GRUNDRISSE
Il Marx che fa la storia dell’autonomia è quello degli sterminatamente chiacchierati “Grundrisse” o “Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica”, pubblicati per la prima volta in Italia da un altro operaista, Enzo Grillo. Erano scritti, questi, non destinati alla pubblicazione, una serie di appunti preparatori a “Per la critica dell’economia politica” disarticolati, implementati e corretti in fieri. Ponte di collegamento tra il Marx filosofo e il Marx scienziato dove ancora molte delle messe a fuoco in “Critica dell’economia politica” e poi ne “Il capitale” sono allo stato primitivo. Ma Tronti troverà in quei vuoti l’occasione di innestare i suoi semi di deviazione.
“Dove Marx mostra il massimo della consapevolezza su questo tema è nei "Grundrisse". E forse per una semplice ragione formale: non costretto né a una ferrea disposizione logica degli argomenti né a una particolare cura linguistica nella loro esposizione, in una fase di lavoro tutto suo, che si poneva molto al di qua di un’uscita pubblica, egli avanzava più speditamente nelle sue scoperte fondamentali e scopre quindi di più e più cose nuove, di quante non ne appaiano nelle opere compiute” (M. Tronti).
Dopo la classe operaia data dal capitalismo, dopo la sua autosufficienza prima del comunismo, eccoci a un altro ribaltamento squisitamente trontiano: in un lavoro confuso e planimetrico, come dice già il titolo, vi sarebbe più esattezza che in un lavoro riveduto, corretto e dato alle stampe. Un esempio di questo modus operandi si riscontra già nel suo approccio a “L’ideologia tedesca”. Nessuna intemerata può coprirlo di ridicolo meglio d'una citazione da egli stesso:
« “mentre la rivoluzione comunista si rivolge contro il modo (Art) dell’attività che si è avuto finora, sopprime il lavoro (die Arbeit beseitigt) e abolisce il dominio di tutte le classi insieme con le classi stesse”… Una riga poi cancellata dal manoscritto continuava, dopo “sopprime il lavoro”, con una interrotta definizione di questo come “la forma moderna dell’attività sotto la quale il dominio delle…”. (Werke, 3, p. 70). Marcuse cerca di giustificare la gravità di queste affermazioni avvertendo che qui compare la solita Aufhebung (superamento), che mentre sopprime restaura e così via. Poi s’accorge della spiegazione troppo banale, e allora pensa lui a sopprimere questa categoria dell’avvenire che è il non-lavoro e a restaurare l’antiquata, filistea, reazionaria idea di felicità”».
I “Werke”, manoscritti propedeutici e campo di ricerca prediletto dell’operaismo onde scovare le ombre che non può nelle opere ufficiali, testimoniano che l’autore stesso fu tentato dal precisare quel “arbeit beseitigt”, “sopprime il lavoro”, con un chiarificatore “sopprime la forma moderna dell’attività”, ecc. Cioè una storicamente determinata forma di attività. Il lavoro inteso com’è inteso nel e dal sistema capitalistico: lavoro salariato, alienazione, reificazione, privazione materiale e spirituale. Non certo l’umano operare tout court. Il comunismo non è il regno in cui l’umanità vivrà d’aria: si continuerà ad operare, a lavorare, ma in ben diverse condizioni. Diverse al punto che, forse, il lavoro non sarà neanche percepito o pensato come lavoro più di quanto un organismo non percepisca e pensi come lavoro l’attività biologica che espleta naturalmente per vivere. Parve banale specificarlo a Marx e pare questione di lana caprina a noi. Tronti invece ne discettò tanto da elevare quel “beseitigt” a discrimen politico e teorico di tutta una scuola. Poiché se ne farà stendardo per la seguente battaglia operaia “alternativa”: il rivoluzionario non lavora! La rivoluzione è contro il lavoro. Comunismo è soppressione di tutto ciò che è in sé reazione. Non si tratta di questa o l’altra forma di lavoro. È nemico il lavoro in sé. Sic et hic! E com’è nemico sic et hic il capitalismo, perciò non si riforma e si distrugge, così vale per il lavoro: non si riforma né trasforma né ce ne si appropria né lo si ripartisce, fossimo matti! Rivoluzione è soppressione e rifiuto del lavoro. Motivo per il quale, se un nemico più grande del Pci avevano e hanno gli autonomi, questo era ed è il sindacato in quanto tale, visto come sensale della forza-lavoro. Ecco la sintesi dell’ideologia operaista ed ecco perché tanto cavillare, che oggi sembra più che autonomia, autismo e basta, intorno ai puntievirgola degli inediti marxiani. Sarà il codice filologico che si applicherà anche sull’intero corpo dei Grundrisse oltre Tronti, fino a Negri.
Il polverone di pretesti sollevato intorno alle pagine dei “Grundrisse” parte proprio dal confondere un’analisi del lavoro per come dovrebbe spontaneamente darsi, nel tempo, dopo la rivoluzione e la presa del potere dei comunisti, in assenza di classi e in piena libertà e uguaglianza, con quanto invece sarebbe possibile già. Confusione gravida di conseguenze perché tutta la rivoluzione si svolge mediante il riconoscimento di nemici ancora vivi e di mezzi mediante i quali soltanto, nelle condizioni date, è possibile avanzare. Dire “Nel comunismo non si lavora da salariati: tu che oggi lotti per lavorare meglio e meno da salariato non sei comunista” equivale a dire “Nel comunismo non si hanno classi: tu che oggi parli di avanzamento di tale classe a scapito di tale altra, non sei comunista”. Non signigica nulla o significa il peggio.
Riportiamo da Tronti che, a sua posta, riporta da Marx e lo s-piega alla sua bisogna: “La sostanza comune di tutte le merci, la loro sostanza cioè non di nuovo come loro contenuto materiale e quindi come determinazione fisica, ma la sostanza comune di esse in quanto merci e perciò valori di scambio, è costituita dal fatto di essere lavoro oggettivato. L’unica cosa differente dal lavoro oggettivato è il lavoro non oggettivato ma ancora da oggettivare, il lavoro come soggettività. Oppure: il lavoro oggettivato, ossia spazialmente presente, può essere anche contrapposto, come lavoro passato, al lavoro temporalmente presente. Nella misura in cui deve essere presente temporalmente, come lavoro vivo, esso può esserlo soltanto come soggetto vivo, in cui esiste come capacità, come possibilità; perciò, come operaio”. E aggiunge Tronti: “Abbiamo già visto nell’Urtext di “Per la critica dell’economia politica” – dello stesso periodo dei Grundrisse (N.d.A, non è che “Per la critica dell’economia politica” è semplicemente "dello stesso periodo dei Grundrisse": questi ultimi erano la stesura preparatoria di quello, uscito non a caso nel 1859, l’anno successivo dei Grundrisse datati 1857-1858; il Nostro sembra occultare accuratamente il fatto che i Grundrisse non siano un’opera come le altre e tra le altre, ma una pianta di lavoro futuro) dirà ancora più in sintesi: “l’unica antitesi al lavoro oggettivato è il lavoro non oggettivo, cioè l’unica antitesi al lavoro oggettivato è il lavoro soggettivo”. Lavoro soggettivo contrapposto a lavoro oggettivato, lavoro vivo contrapposto a lavoro morto, è il lavoro contrapposto al capitale: il lavoro come non-capitale. Due sono le sue caratteristiche fondamentali e tutt’e due segnano il lavoro come un non-qualcosa, un Nicht piantato nel cuore di una rete di rapporti sociali positivi, che tiene in sé insieme la possibilità del loro sviluppo come quella della loro distruzione”.
Com’è diafano il canto della negazione nichilistica (non, non, non) antitetico-antagonista preclusa ad ogni sintesi! Ma d’altronde Tronti lo scrive recisamente che il superamento è pacificazione, che la pacificazione è felicità e la felicità è reazionaria. Il più semplicemente possibile ristabiliamo l’ordine in questa palude di nebbia e intrichi in cui viene affogata la lucerna rivoluzionaria: quando Marx dice che l’unico lavoro sottratto alla valorizzazione capitalistica è il lavoro non oggettivato, quindi il lavoro soggettivo, sta parlando di qualcosa pacifica anche ai sassi. Lui stesso, subito dopo le parole che riporta Tronti, ci fa un esempio: “Se un capitalista si fa tagliare della legna per arrostire il suo montone, il rapporto non solo del taglialegna con lui, ma anche di lui col taglialegna è un rapporto di scambio semplice. Il taglialegna gli presta il suo servizio, ossia un valore d’uso che non accresce il capitale ma nel quale anzi questo si consuma, e il capitalista gli dà in cambio un’altra merce sotto forma di denaro.” Non c’è mole di lavoro che viene cristallizzata, “oggettivata”. Quel lavoro esperito non resta intrappolato in nessuna pietra filosofale. Sfuma, esaurisce nel momento stesso in cui si esperisce in cambio d’altro. Se niente e nessuno fossilizza il lavoro e dunque il valore del lavoro (giacché il lavoro fisico, nel momento in cui si compie è, in sé, ormai finito; solo prelevandone il valore è possibile conservarlo), perché non c’è stato un pluslavoro quindi non c’è stato un plusvalore. E quindi non c’è stato profitto, non c’è stato accrescimento di capitale. Ma i rapporti sociali, al mondo com’è, non si consumano nel modo paritetico che Marx ha posto qui in funzione d’esempio, per illustrare cosa è il lavoro senza estrazione di surplus per poi poter spiegare cos’è, al contrario, il lavoro sotto l’estrazione di surplus, e quindi spiegare cos’è il capitalismo e perché e come occorre liberarsene. Secondo la teoria del plusvalore che nei Grundrisse Marx comincia a delineare (non a caso Tronti, insieme a dialettica e proprietà, non parla mai nemmeno di plusvalore), i rapporti sociali si consumano in quest’altro modo: il capitalista chiede all’operaio di farsi tagliare la legna. Il capitalista lo paga 10 euro. Poi prende questa legna tagliata, un po’ la usa se gli occorre, un po’ no. Quella che non usa la rivende. La rivende già tagliata, quindi farà scambio di lavoro oggettivato. E la rivende all’operaio per 15 euro. L’operaio scoprirà che se il suo lavoro è valso 15 euro e non 10, ha compiuto una mole di lavoro pari a 5 euro gratis. Ma quella mole di lavoro è ormai, nella sua valorizzazione, saldamente in pugno al padrone. Se all’operaio è necessaria, non ha altra via che piegarsi a questo latrocinio. Se quei 15 euro li ha, li scuce subito. Se non li ha, s'indebita. E qualora, sempre estremamente stilizzando, ci si chiedesse se non conviene, a quel punto, che una prossima volta l’operaio si tagli da sé la legna necessaria visto che, avendola tagliata per altri, ne ha le capacità, sorgerà un piccolo problema: non ha né legna né accetta. Che sono proprietà di altri padroni e dovrebbero rivendergliele. Rivendergliele a tanto denaro quanto lui non riuscirà mai a metter da parte. Ipotizziamo il costo di tre mesi di fare legna sottopagato senza, da quella sottopaga, spendere un quattrino per vivere. Allora sì, se riuscisse a star fermo coi consumi e lavorare alle pur inique condizioni di rapina padronale, ma sufficienti nell’arco di tot. tempo a renderlo proprietario di centri e mezzi di produzione, anche l’operaio potrebbe riuscire a diventare un libero produttore e addirittura un capitalista a sua volta, chissà! Ma se quest’operaio, invece, non riesce proprio a digiunare per tre mesi, a non pagare un soldo d’affitto, di bollette e tutto quanto gli occorra per tenersi in vita, l’unica che gli resta e assaltare violentemente il padrone e togliergli quello che esso toglie a lui. Questo illustra e indica Marx. Tronti invece illustra e indica di rispondere con un pernacchio al padrone che ti assolda per fregarti, rimanendo comodamente all’ombra delle siepi beandoti del potenziale soggettivo della forza/capacità di produrre e ripodurti, di ogni gesto che tu compirai fuori dal dominio padronale come “lavoro non oggettivato” quindi “lavoro vivo”; anche se non potrai allungare le mani su di una mela perché nulla t’appartiene per legge. Nel frattempo il padrone morirà di fame (tu, miracolosamente, no) e quando finalmente sarà morto di fame e si sarà bruciato il circuito capitalistico, entrerai nei suoi campi e nelle sue officine a produrre immediatamente per te senza oggettivare/mortificare la tua produzione!
Tronti estrapola frammenti da frammenti, decontestualizzati non solo dal resto delle opere di Marx ma persino dal corpo degli stessi Grundrisse, e a toppe e rappezzi metterà in piedi un Marxenstein da laboratorio che, disossato di dialettica, avanzerà cempennante come uno zombie. Allora lo rianimerà di scariche elettriche estetizzanti e fraseologie energetiche dandogli, a intermittenza, l’imput per urli come “Rivoluzione!”; “Classe operaia!”; “Morte al capitale!”. E in questo modo riuscirà a tenerlo in piedi un po’ di più e a impressionare gli spettatori più sprovveduti come fosse una creatura viva.
TATTICA E STRATEGIA DEL GATTO SELVAGGIO PERMANENTE: STERILITÀ DI UNA DIALETTICA MORTA ALL’ANTITESI
Se allora la classe operaia dovrà rifiutare il lavoro oggettivato che arricchisce il padrone, non le resta che scioperare a oltranza. L’operaismo non proporrà lo sciopero classico, come un momento specifico della lotta contro il padrone; ma il gatto selvaggio permanente come abbandono e rifiuto del lavoro, assioma fondativo di tutta la propaganda operaista. Il “rifiuto dell’attività” e “lo sciopero del lavoro vivo” quale “crollo della contrapposizione tra capitale e lavoro” è la più “terribile minaccia che possa essere portata alla vita stessa della società capitalistica” (cit). Come l’esorcista si precipita dalla finestra per liberarsi dal demone che lo possiede così, per l’operaismo, la classe operaia, scoprendo d’essere il cuore del suo peggior nemico, dovrà ucciderlo uccidendo se stessa. Cessando l’operaio d’essere operaio, finirà il capitalista d’essere capitalista. Semplice, no? Tanti rompicapi e cape rotte e la soluzione era nel non svegliarsi la mattina e non andare in fabbrica, fare un giro di telefonate e dire agli altri di fare lo stesso. Nessun presentimento di incanalarsi per un binario morto sfiora il Nostro nemmeno quando, assimilando l’operaio alla borghesia, arriva all’aberrazione che “la borghesia produca”! In tale sovrapporsi e mescolarsi di soggetti fino alla scomparsa per vie tutte sillogistiche dei termini stessi, la borghesia finisce tutt’uno col proletariato; proletari e proprietari sono già forti alla stessa stregua, nasce la borghesia produttiva e il socialcapitalismo, il piano del capitale, l’uso rivoluzionario del riformismo e il riformismo della rivoluzione (il superamento come restaurazione), il general intellect culla di complottismi che verranno, la rarefazione e la scomparsa delle classi, l’oltremarxismo, l’oltreclassismo e altre amenità.
Una tisica battaglia navale di sofismi senza sbocchi, senza tempo e incarnazioni reali. Travestito da aristocratico spregio barricadiero, un riformismo ben peggiore del riformismo classico che perlomeno pone che delle riforme siano promotori attivi gli operai. Il riformismo operaista toglie perfino questo margine di attività ai proletari intimando loro di lasciare che il capitalismo, collassando da sé in deficit del loro apporto, crei da solo il comunismo. Il “biennio rosso”, in proposito del geniale stratagemma dello sciopero fine a sé stesso, vide a grappoli fabbriche del nord Italia espropriate dagli operai in armi, sull’onda della rivoluzione d’ottobre; dal governo fu disposto di non rifornirle finché gli occupanti non si fossero stancati, accorgendosi che senza padroni si va poco lontano. Ma è senza il potere, senza le leve di comando allora al servizio dei padroni, che si va poco lontano. Infatti, seppur con ingenti perdite di profitto da parte padronale, che dopo la devastante esperienza “democratica” risolse di affidarsi all’uomo forte Mussolini, sulla scommessa contro la rivoluzione mediante la sola occupazione, Giolitti vinse. Tutto qui, insomma, il succo del geniale marxismo eretico di Tronti: non riappropriarsi dei mezzi di produzione, ma lasciarli al padrone, se tanto gli piacciono, e cominciare già a vivere comunisticamente da sé!
CONCLUSIONI
«Il socialismo premarxista è battuto. Esso continua la lotta non più sul suo proprio terreno, ma sul terreno generale del marxismo, come revisionismo» (“Materialismo e revisionismo”).
La via trontiana al comunismo fu una serie di paralogismi reazionari degni del peggior nichilismo piccolo-borghese. Il padre storico di questa filosofia che afferma che “il fine è nulla, il momento dello scontro è tutto”, era già contestato da Lenin contro l’empiriocriticismo di Richard Avenarius ed Ernst Mach, embrione filosofico dell'ipersoggettivismo operaista. Un estremismo ben al di là dell’infantilismo leniniano e un improponibile minimalismo politico mascherato di antagonismo che informa ancora totalmente di sé la strategia dell’autonomia. Con la retorica degli spazi liberati e l’elusione del controllo dello Stato, neanche più del capitalista, come massimo obiettivo politico, se oggi la galassia antagonista abbandona ogni riferimento al mondo del lavoro, la discendenza dai nonni operaisti non può essere più esemplificativa. Questi ultimi accusavano il lavoro di collaborazionismo col capitale; tanto più doloso in quanto pleonastico. Ma, per tornare al film di Petri, essi poterono farlo senz’altro. È Lulù Massa che, adottando questa condotta (e non è un caso se mai il movimento operaio fece sua la linea operaista), si ritrova realmente a morire di fame. Nel film, l’operaio fordista interpretato da Gian Maria Volonté, si lascia convincere dai proclami degli studenti operaisti: rinuncia alla lotta e abbandona tutto, rovinando sempre più. Si ritroverà a dormire sulle panche d’una facoltà occupata, vivrà dell’elemosina della tanto deprecata “società produttiva” e perderà, insieme col lavoro, la casa, la famiglia, la forza dell’unione coi compagni, il futuro. Regredito, atomizzato e impotente nel vicolo cieco di un estremismo parolaio. Ma i suoi compagni, in fabbrica, lottano per lui, coi metodi propri e progressivi del movimento operaio. Ottenendone la riassunzione. Quanti muri deve abbattere la classe operaia! Quanti nemici ha, non solo tra chi suo nemico si dichiara, ma anche in chi se ne dice il miglior alleato!
Definendo il comunismo “un’astrazione dogmatica”, Tronti dirà che esso “ha visto sorgere dinanzi a sé altre dottrine socialiste” dove si sente evidentemente scagionato a riparare. Peccato che, ancora una volta, sia il contrario: la storia del pensiero socialista e del movimento operaio, che ai primordi era tutto e il suo contrario, ha via via selezionato il suo prodotto scientifico: il comunismo. Può sembrare impossibile, ma è così: più di quanto potesse dentro il Pci, Tronti riuscì a far danni fuori. Dove, rivendendo le diapositive di un Marx in negativo a una generazione che aveva sì urgenza della rottura col Marx in salsa Pci, ma per tornare a quello bolscevico non per ulteriormente inquinarlo di nichilismo, provò d’essere, più che un sovversivo, un irriducibile sovvertitore.
UN POSCRITTO E UNA PRECE
Quando Mario Tronti si accorge che le sue strampalate teorie sugli operai e contro gli operai, dagli operai separano in realtà tutti gli altri, studenti, intellettuali, lembi di piccola e media borghesia, col risultato che senza più nessun contatto coi lavoratori, sorgono gruppi e sette giovanili che da sé e per sé soltanto decidono sia il momento del conflitto a fuoco contro il capitale e lo Stato, egli, impaurito, ritratterà dichiarando, a distanza neanche di cinque anni dall’uscita del suo Necronomicon, che quel discorso non è più valido e tutto è da ripensare. Fa in tempo a ricollocarsi prima che il 7 aprile ‘79 colpisca anche lui come Negri e altri. Fa ritorno al Pci nel ‘72 e, perdonato dal gruppo dirigente quale figliol prodigo, ne corona addirittura il Comitato centrale. Da allora sforna verbosi libri vittimistico-nostalgiaci sugli anni e i bei compagni della giovinezza operaista, torna a menarla a quando a quando con “la tesi operaista” in anamnesi senili e arronza sconclusionate morali circa la disfatta della sua linea e, con essa, della classe operaia tutta. Come in una matriosca stregata di aberrazioni, non smette di sottoprodurre, da ogni tossica categoria concettuale, infinite altre sempre più tossiche. È stato senatore fino al governo Gentiloni e la sua ultima pubblicazione, “Dello spirito libero – Frammenti di vita e di pensiero”, l’ha presentata ai Musei capitolini insieme a Maria Elena Boschi. La ministra, non capendo un tubo della serqua di trontonate che a stento capiamo noi, al solo scopo di vezzeggiare l’ultimo intellettuale rimasto nel Pd, e certamente l’ultimo con un po’ di storia alle spalle, qual essa sia poco importa all'ipocrisia borghese, così ha sospirato: “Tu ti presenti come uno sconfitto, ma io non ti ho mai pensato tale”. Generosamente sorridendogli. La Boschi! È superfluo ogni commento.
Per il centenario della rivoluzione d’ottobre, un suo rapsodico intervento in un’aula frastornata e sonnolenta recitava così: “Rivoluzione e terrore, se sono dunque inseparabili, dobbiamo per questo rassegnarci alla pratica di cosiddetti riformismi che però mai riescono a mettere in discussione il rapporto, che poi è un rapporto di forza, tra il sotto e il sopra, tra il basso e l’alto della società? È il problema che ci pone ancora dopo un secolo quell’ottobre del ‘17”. Con che faccia diceva questo dagli spalti di uno dei governi più repressivi e reazionari della storia della repubblica italiana, se la risposta non è “Per lustrarsi la nomea di indefesso ribelle e continuare a vendere per la DeriveApprodi”, è ignota a noi e a lui, al cielo e alla terra, e a tutte le cose visibili e invisibili. Amen.