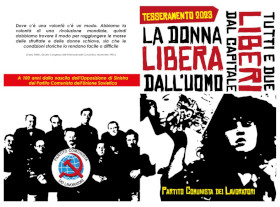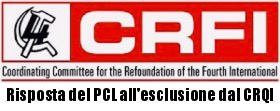Interventi
«Ma che piccola storia ignobile che mi tocca raccontare...» Telecom e Alitalia, la vicenda odiosa del capitalismo arraffone e dei lavoratori dal futuro senza alcun diritto
12 Maggio 2017
Telecom e Alitalia sono due storie tristi accomunate dal fatto che i lavoratori sono stati massacrati senza nemmeno che si sia aperto un qualsiasi spiraglio positivo per il futuro di queste aziende e di conseguenza uno straccio di certezza per quanti vi sono occupati. Stavolta, invece di soffermarci solo sulle dinamiche aziendali che hanno anche in questi frangenti seguito l’indecente copione, oramai consolidato e tanto caro alla classe padronale, dei tagli al personale, dei tagli alle retribuzioni e dell’inasprimento delle condizioni di lavoro, sarebbe forse il caso di soffermarsi anche sulle qualità manageriali di quelli che, preposti a questi compiti, sono solo riusciti a massacrare i lavoratori, senza peraltro ottenere alcun "risultato".
Personaggi individuati come taumaturghi ai quali, con i sindacati conniventi, lo Stato complice dà carta bianca ma che non riescono ad andare oltre a quello che, sin qui, si è sempre e solamente visto: lavoratori che pagano le crisi. Ma in molti di questi casi è forse opportuno dire che i lavoratori non solo hanno pagato le crisi, ma hanno pagato anche incapacità e inettitudine di questa sorta di santoni del management.
Siamo più o meno all’inizio del 1998, Ciampi Presidente del Consiglio dei ministri, tutto attento a preparare l’Italia all’euro, quando iniziarono i guai di Telecom (ex SIP), con quella che fu definita la “madre di tutte le privatizzazioni”. A riguardo, non molti sanno che l’operazione serviva a Ciampi per assicurarsi il fatto che l’Italia fosse tra i paesi che avrebbero adottato l’euro sin dall’inizio, e la vendita di Telecom era necessaria per far cassa e diminuire le spese. Vendita che avvenne senza che, però, vi fosse un gruppo di azionisti disposti a investire nel lungo termine; cosa, questa, che in qualche maniera avrebbe garantito i lavoratori, pur se con contratti di solidarietà a cassa integrazione, a recepire un salario.
A signoreggiare, nell’operazione, fu il gruppo FIAT, che attraverso l’IFIL (società d'investimento controllata dalla famiglia Agnelli) aveva acquisito lo 0,6 per cento del capitale, e che non solo pretese di governare l’azienda senza ingerenze, ma dimostrò essenzialmente di essere interessata - ovviamente – alla gestione del potere economico piuttosto che alle strategie industriali. Lo dimostra il fatto che AT&T e UNISOURCE, due imprese qualificate nel settore della telefonia, che erano state selezionate dal Tesoro, vennero estromesse in maniera veloce e senza spiegazioni, perché non gradite a cotanto socio. Quella fu la prima scelta sbagliata del management, tant’è che Antonio Maccanico, persona non certo ostile alla FIAT, commentando le continue difficoltà cui l’azienda era andata e andava esponenzialmente incontro ebbe a dire: “Ci fu una certa inconsistenza del nucleo stabile sulle scelte manageriali, forse dovuta al fatto che loro non conoscevano il settore.” Esemplare, no? Incapacità aggiunta alle vergognose dinamiche padronali da sempre adottate per ridurre all’osso le spese e far aumentare i guadagni.
Il resto della storia è ancora più triste, perché con l’avvicendarsi di diversi nomi, tutti illustri nel firmamento della finanza - inutili da elencare dal momento che sono gli stessi che hanno poi contribuito ad altre rovine - rimangono sotto gli occhi di tutti questi dati: nel 1998, cioè all’indomani della privatizzazione, la società era la quarta in Italia per fatturato e la prima per valore aggiunto, aveva utili che superavano l’undici per cento del ricavato e le risorse finanziarie generate dalla gestione ammontavano a circa 7,5 milioni di euro. Prima della privatizzazione i dipendenti di Telecom erano 120.000, ora sono 50.000. Il rapporto tra i debiti e il fatturato era del 30%, ora è al 100%. Il gruppo era presente dappertutto nel mondo; adesso, dopo la vendita di Telecom Argentina, rimane Telecom Brasile, proprietà che non si sa bene per quanto altro tempo Telecom Italia riuscirà a tenere, e dove è già stata avviata una ristrutturazione che prevede il licenziamento di 1.700 lavoratori. Questi sono i dati, che bastano da soli a riassumere quanto la privatizzazione e le accorte politiche aziendali adottate dal manager di turno siano riuscite a ridurre al disastro l’ex SIP.
Un altro caso infelice è Alitalia che, se vogliamo, è un capitolo peggiore. Più conosciuto al grande pubblico perché ha avuto una risonanza più rilevante.
La società viene messa su nel settembre 1946, sotto l’egida IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale, nato sotto il fascismo e dismesso nel 2000), effettua il primo volo il 5 maggio 1947 e per i successivi quaranta anni va serenamente per i cieli, fino a quando, negli anni ‘90, si avvertono i primi segnali di cedimento con un sensibile calo del numero dei passeggeri. La compagnia è in crisi, e con una girandola di presidenti e amministratori delegati vivacchia e sopravvive sino al 2006, anno in cui il rischio di fallimento è concreto al punto che il nuovo governo Prodi ne decide la privatizzazione, vendendo le quote di proprietà del Tesoro per arrivare a un salvataggio di mercato, ma la gara pubblica va deserta. Un anno dopo, il governo ci riprova, ma questa volta attraverso una trattativa diretta, avviata in esclusiva con Air France, che nel frattempo già si era già fusa con la olandese KLM; si arriva a un accordo di massima, che prevede un investimento franco-olandese di 1,7 miliardi e 2.100 esuberi. A marzo 2008 il governo Prodi accetta le condizioni, ma è in una posizione di estrema debolezza: il premier è stato sfiduciato, e si sta andando alle elezioni politiche, che Berlusconi vince diventando il nuovo presidente del consiglio.
Poiché i guai non vengono mai da soli, per Alitalia Berlusconi immagina una genialata: pervaso da orgoglio nazionalista e soprattutto per fare un favore bello grosso a un certo numero di persone che su Alitalia pensavano di guadagnarci, partorisce l’operazione “Capitani coraggiosi” (che è il titolo di un romanzo di Rudyard Kipling, e che bene sarebbe stato se ce lo fossimo ricordato solo così); al grido di “Alitalia deve restare italiana” salta la trattativa con Air France, spacca la compagnia in due tronconi; la parte attiva - aerei, rotte, infrastrutture, personale ecc. - la vende ai “capitani”, un gruppo di imprenditori italiani guidati da Roberto Colaninno, che, con la regia dell'allora amministratore delegato di Intesa San Paolo, Corrado Passera, fondano CAI, con annesso e connesso massacro di lavoratori. E riunisce tutti i debiti in un'altra compagnia, la “bad company”, i cui debiti vengono ripianati dallo Stato a spese dei contribuenti.
Purtroppo però, con Colaninno presidente e Rocco Sabelli amministratore delegato, le cose non migliorano, anzi gli affari continuano ad andar male. Una serie di errori strategici si sommano agli errori del passato; cambiano i nomi al vertice, in una girandola che vede sempre gli stessi personaggi spostarsi da un azienda all’altra (non ci dimentichiamo che uno degli ultimi presidenti di Alitalia è stato Luca Cordero di Montezemolo, che la ha lasciata da poco, ma è rimasto nel CdA e che forse, in un futuro non lontanissimo, ritroveremo a Telecom, ma che è stato già presidente e AD di Ferrari e Maserati, già presidente FIAT, già presidente di Telethon, già vicepresidente di UNICREDIT, già presidente di Nuovo Trasporto Viaggiatori–Italo, e già tantissimi altri incarichi che elencati tutti avrebbero la lunghezza di un saggio).
Si arriva alla vendita del 49% di Alitalia a Etihad, compagnia aerea nazionale degli Emirati Arabi Uniti.
Le ultime vicende le conosciamo tutti: i sindacati, le proposte capestro dei padroni, il referendum che boccia l’accordo che chiedeva l’ennesimo sacrificio ai lavoratori (quelli che restavano, perché gli esuberi previsti erano 980), l’intervento del governo, e per finire una Alitalia commissariata, in attesa di essere venduta, non si sa ancora a chi, o chiusa definitivamente.
Storie tristi, vero? Storie che fanno rabbia. Ma una cosa, però, va detta: in questo campo fatto di disastri, di rovine, di perdite, di licenziamenti, di famiglie private di reddito, tutti questi supermanager ne escono sempre a testa alta, perché la loro incompetenza viene sempre (dopo due o tre anni di management) premiata e pagata a peso d’oro, dal momento che incassano liquidazioni favolose, a dispetto di lavoratori che non hanno più ricevuto lo stipendio.